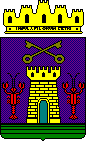Per una storia politico istituzionale di Isola del Liri (di Marcello Rizzello)
Il riordinamento dell'archivio comunale storico di Isola del Liri (di Marcello Rizzello e di Daniela Campagna)
Comune di Isola del Liri
Periodo preunitario
Periodo unitario
Archivi aggregati
|
|
Inventario dell'archivio storico del comune di Isola del Liri
|
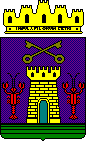 |
|
a cura di
Marcello
Rizzello
Daniela
Campagna
|
|
|
Per una storia politico istituzionale di Isola del Liri (di Marcello Rizzello)

1. Un problema aperto: le origini di Isola
Recentemente, con una pubblicazione di Dionigi Antonelli*,
si è riaperto il dibattito sulle origini medievali di Isola del Liri . L'Autore ha esaminato diversi documenti che riguardano Isola ed il territorio circostante, ma attraverso la loro interpretazione è giunto a conclusioni che non mi sento di condividere.
Già nel passato il Pistilli, l'Ippoliti ed il Carbone si erano occupati, con contrastanti indicazioni, dell'esatta ubicazione della cella di San Benedetto in Colle d'Isola, testimoniata a partire dall'aprile 989. Il primo, nel 1798, congetturava che essa si trovasse presso la chiesetta della Madonna delle Grazie, mentre l'Ippoliti, pur senza fondamento, l'identificava con la chiesa e il monastero delle benedettine di Sant'Andrea in Arpino e Arduino Carbone pensava che si trovasse nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria della Forma, ad Isola del Liri*.
L'Antonelli *, ora, dopo aver notato che la localizzazione di questo complesso sacro rimane attualmente incerta, osserva che esso era comunque situato "a confine con Sora in territorio di Isola, il quale per secoli fu parte integrante del territorio di Arpino". Egli ritiene anzi che sia possibile giungere ad una sua localizzazione "più vicina al vero", se si tiene conto delle determinazioni topografiche date dai documenti. In questi risulta che la cella di San Benedetto sorgeva nei pressi della località Bagnara, dove si estendevano le sue terre, e vicino ad un fiume. Simili condizioni idro-topografiche, secondo l'Autore, si riscontrerebbero presso l'Abbazia di San Domenico. Pertanto il Colle d'Isola, a suo parere, "non poteva essere che l'odierno Colle San Sebastiano".
Per quanto ci riguarda, iniziamo col precisare che l'Autore ha trascurato il fatto che nella zona vi sono diverse isole, attestate da documenti storici*:
1) Insula, poi detta Insula Filiorum Petri
*,
Isola di Sora e infine Isola del Liri;
2) una seconda Insula, denominata poi Insula Solarata
* e infine Isoletta;
3) l'Insula Arpinas
ciceroniana, da individuarsi secondo alcuni nell'isola in località San Domenico e secondo altri nell'isola di Carnello;
4) una quarta insula sul Fibreno, in località Carnello (ai confini fra i comuni di Isola, Sora, Arpino), detta per un certo periodo di tempo Isola di Arpino ed Isola di Carnello*, poi non più citata in quanto tale;
5) una quinta isola sul Liri, in località San Paolo*;
6) infine, un'altra isola, osservabile nella litografia pubblicata da G.B. Pacichelli nel 1703, con la rappresentazione di Sora
*.
Questa situazione così ingarbugliata, induce certamente a valutare le testimonianze documentarie con estrema prudenza.
Per la cella di San Benedetto, rileviamo che in tutti i documenti che le si riferiscono invariabilmente si dice che essa sorgeva in actu Arpini, cioé in territorio di Arpino
*.
A questo proposito, l'Antonelli sottolinea che Isola del Liri ha fatto parte per secoli del tenimento di Arpino. Questo non ci risulta, ma anche ammettendo che sia vero, osserviamo che in un atto di donazione del 1043 (citato dall'Autore come inedito, ma in realtà già pubblicato nel 1983 da F. Farina e B. Fornari
*), nel testo, sicuramente riferibile ad Isola Liri, si legge: " ... sunt duo ecclesie nostre quas non habemus in finibus eiusdem Sora infra actum sunt ambe de ipsa Isola una ecclesia Nomine Sanctus Petrus Apostolus qui est in locum qui dicitur ad Funtana Tegulicci et alia ecclesia Nomine Sancta Lucia Virgo qui esse videtur ad ipso ponte civitatis Isole".
Da queste parole risulta inequivocabilmente che nel 1043 Isola del Liri era nei confini di Sora (in finibus eiusdem Sora infra actum), mentre nello stesso periodo la cella di San Benedetto di Colle d'Isola continua ad essere citata nel teritorio di Arpino (in actu Arpini).
A parte questo, l'indicazione del Colle di San Sebastiano sarebbe comunque inaccettabile. Su questo colle storicamente è documentata la chiesa omonima ed inoltre al Cella di San Benedetto esisteva ancora nel 1474, quando è già testimoniata la Chiesa di San Sebastiano *.
Ma c'è di più: nel privilegio di Innocenzo III de libertate Sancti Dominici de Sora del 1205, è compreso un lungo elenco di pertinenze e possessi di questa Abbazia. Fra gli altri, si legge "In confinio monasterii ... fundum Sambuceti et montem foruli"
*. Tenuto conto che la località Sammucito si trova in pressi di Isola* e che la località Forli (Foruli) si estende sulle pendici nord occidentali del Colle di San Sebastiano*,
ne deriva che l'antico nome di quest'altura non era Colle "de Insula", ma mons Foruli.
Risolti preliminarmente gli equivoci sopra esposti, cercheremo ora di avanzare una nostra ipotesi sulla localizazione della cella di S. Benedetto, in base ai seguenti dati:
1) In comune di Arpino esiste il toponimo Venditti (=Benedicti), relativo ad un colle sul quale sorge attualmente una piccola chiesa consacrata a Santa Maria. Sulle pendici settentrionali della stessa altura, fra la vegetazione, si osservano alcuni ruderi.
2) Questo colle si trova a soli m. 500 dall'isola sul Fibreno (in località Carnello), detta anche come abbiamo visto Isola di Arpino
3) Nei documenti riferibili alla cella di S. Benedetto si citano un fiume e le località Pantano e Baniarola (o Bagnara), dove si trovano proprietà della cella*. Baniarola, poi, nella donazione di Ranieri del 1021, è esattamente localizzata presso il Liri (Viride) ed appare confinante con la loc. Pantano*. Ebbene, in località Carnello, scorre il fiume Fibreno; immediatamente a nord ovest di questa località, sino a Monte Montano, ed oltre sino al fiume Liri, nella zona nella quale in epoca preistorica si estendeva un lago* e nelle epoche successive un acquitrino, in un periodo ancora a noi vicino si estendeva lo stagno (con argini regolari e a forma poligonale) di Tremoletto*e si registrano ancora oggi i due toponimi di Bagnara e di Pantano.
Per quanto sopra, la nostra ipotesi è che la Cella di S. Benedetto in Colle de Insula fosse situata appunto in località Venditti, in Comune di Arpino, mentre le sue proprietà si estendevano nella zona fra il Fibreno e il Liri e quindi anche in comune di Sora. La cella in questione, comunque, a nostro parere, nulla avrebbe a che fare con le origini di Isola del Liri.
Un altro documento su cui si sofferma l'Antonelli è datato al marzo 1042*. Vi risulta che Bonifacio, giudice di Aquino, offre all'Abbazia di Montecassino la chiesa di San Nicola nel castello di Isola, con tutte le pertinenze che egli possedeva nella contea di Aquino. Inutile dire che anche in questo caso riaffiora l'equivoco precedentemente messo in rilievo. Non si tratta qui infatti di Isola del Liri e del suo castello, ma di quella che fu poi chiamata Insula Solarata, che si trovava vicino ad Aquino. La chiesa di San Nicola risulta infatti citata nelle Rationes Decimarum del 1308-1310 e del 1325 nella diocesi di Aquino, in castro Insule (cioè Insula Solarata)
*,
mentre non risulta in alcun modo tra le chiese di Isola del Liri.
In conclusione, il primo documento valido riguardante Isola Liri è proprio l'atto di donazione del 1043 (già citato) all'Abbazia di San Domenico di due chiese. Isola vi figura civitas, come Arpino e Sora
*;
si menzionano le sue chiese di San Pietro Apostolo e di Santa Lucia Vergine e si ricorda un ponte, con il quale si accedeva al centro abitato. Questo era denominato "Isola", non ancora Insula Filiorum Petri. Risulta chiaramente che, se Isola aveva già allora una sua struttura definita (ponte, chiese) ed una qualificazione di un certo livello (civitas), doveva perlomeno esistere da diversi decenni e non si può sbagliare di molto ipotizzandone la fondazione nel secondo cinquantennio del secolo decimo.
2. Isola nella Contea di Sora
Nel 970 Ildebrando, figlio del fu Rachisio, castaldo della città di Sora, assunse il titolo di conte di Sora e di Vicalvi*
ed è probabile che sin da quest'epoca Isola facesse parte di questa contea. Ricordiamo che i castaldi, dignitari longobardi, erano amministratori regi con ampi poteri civili e militari.
Nel 989 a Ildebrando successe Teutone, figlio di suo fratello Alessandro; quindi nel 1009, per breve tempo, suo figlio Pietro I, castaldo di Sora, e , successivamente Raineri (1012-1021), anche lui figlio di Alessandro. Raineri, gastaldus Soranae civitatis, nel 1012 donò all'Abbazia di Montecassino la località Collis de Insula, che faceva parte delle sue eredità nei confini di Arpino*.
Questa notizia ci permette di sapere che già ai tempi di Pietro I (e forse anche prima) i successori di Ildebrando avevano estese proprietà nel tenimento di Arpino.
Come successore di Raineri, è ricordato il figlio di Pietro II, che fu signore di Sora e di Arpino e la cui sposa Donna Doda era la figlia del defunto conte Oderisio, che sappiamo feudatario di Vicalvi nel periodo 1000-1005*. A Pietro si deve la famosa donazione che rese possibile la fondazione da parte di San Domenico da Foligno del monastero in località "inter formas", nei confini di Sora *.
Dalla morte di Pietro II, per alcuni decenni, si prolunga il periodo più incerto della storia di Isola, riguardo alla quale possiamo solo avanzare ipotesi ed esaminare elementi marginali e in buona parte discutibili
*. E' probabile che il Landone signore di Arpino, che nel 1075-1076 donò all'Abbazia di Montecassino la metà di Arpino, la metà di Monte Nero, la parte a lui spettante di Sant'Urbano, di Vicalvi e di Casalvieri e all'Abbazia di San Domenico il castello di Sclavi (ora Fontechiari), estendesse la sua signoria anche a Sora e ad Isola
*.
I documenti medievali, possiamo seguire le vicende di un Castellum Sancti Laurentii, nel quale sarebbe ovvia la tentazione di identificare il castello di Isola del Liri. Si tratta innanzitutto di una donazione del 1077 della chiesa di San Marco Evangelista in Castello Sancti Laurentii
*. Le indicazioni dei luoghi all'interno del documento concorrono tutta via a spostare la nostra osservazione nel Comune di Castelliri e precisamente in località Convento San Lorenzo-Muraglie. Nei pressi è infatti conservato anche il toponimo di San Marco. Il fiume Maior qui citato è il Liri, l'insula di cui si parla è quella di San Paolo (vicino il fiume "ad ipso bado de Sancto Paulo", nella località dove già in epoca romana era testimoniato il ponte poi detto di San Paolo
*.
Nell'ultimo ventennio dell'XI secolo, fu conte di Sora Gerardo, sino a quando la zona fu invasa dai Nomanni e la città fu da loro occupata. Nel 1099 i figli di Gerardo "più con l'inganno che con la forza" riuscirono a recuperarla, ma continuarono i contrasti fra feudatari, mentre i Normanni consolidavano il loro potere in Italia Meridionale. In seguito, la stessa Sora con il suo territorio di nuovo cadde sotto i Normanni e il 15 agosto 1103 fu incendiata da Ruggiero I duca di Puglia
*.
Dopo questo tragico evento, in Sora divenne sempre più importante la presenza e l'autorità del Vescovo. Ne abbiamo una prova evidente nel Diploma del Papa Pasquale II del 9 febbraio 1110, con il quale si confermano i confini della diocesi sorana e si precisano le proprietà del Vescovado. Fra queste leggiamo: castellum Insula cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam sancti Laurentii et ecclesiam Sancti Pauli in campo
*
... Qui dovremmo veramente trovarci difronte alla prima attestazione del castello di Isola del Liri e dell'originaria chiesa isolana di San Lorenzo, pur essendo un elemento di dubbio la successiva menzione della chiesa di San Paolo in Campo, situata più a sud ovest, come abbiamo detto in Comune di Castelliri, in località San Paolo, proprio nei pressi del già citato Castello San Lorenzo e della chiesa di San Marco
*.
Certamente, può destar sorpresa che il castello di Isola qui compaia per la prima volta collegato iure proprietario con il vescovo di Sora; altra osservazione da fare è che, essendo il Diploma un atto di conferma, possiamo arguire che il castello sia stato costruito perlomeno nel secondo cinquantennio del secolo XI. A questo proposito e in connessione con il generale fenomeno dell'incastellamento nella Media Valle del Liri, non dobbiamo dimenticare che un nuovo impulso all'erezione di fortificazioni fu dato proprio dal pericolo che i Normanni rappresentavano. Basta ricordare quanto scriveva Leone Ostiense, riferendosi all'Abate di Montecassino Richerio, il quale nel 1045 suspectam habens Normannorum nequitiam singula monasterii castella muris in giro munivit,ibique rusticos qui hactenus in villis habitaverant manere constituit
*.
Durante il periodo delle lotte con i Normanni, dunque, la civitas di Isola sarebbe divenuta anche un castrum. Forse, nello stesso periodo, anche l'Abbazia di San Domenico si munì di una torre difensiva, mentre nel 1075 le era stato donato da Landone il castellum di Sclavi (Fontechiari)
*.
Nel 1137 Sora appare tra le città che l'imperatore Lotario III riconosce all'Abbazia di Montecassino, ma si tratta probabilmente di un riconoscimento puramente simbolico. Nel 1140 Ruggiero II occupò Sora, riaffermando il potere normanno nella città. Infine, nel 1156, Simone, prefetto di Sora, fu ucciso durante una sommossa, ma il re di Sicilia Guglielmo detto il Malo, affidò la rappresaglia al figlio del morto, anche lui chiamato Simone, il quale, dopo aver ottenuto il suo scopo, cercò di risollevare le condizioni della città
*.
In un documento del 1169, risutano presenti per la costituzione di un beneficio da parte del Conte Roberto di Caserta a favore di Gerardo de Insula (vedi dopo), oltre a due giudici, uno dei quali di Arpino, queli che probabilmente in quel periodo erano i più potenti feudatari della zona, definiti nell'atto milites, cioè facenti parte del ceto dei nobili. Sono nominati Jurello de Loco, Giovanni di Goffredo, Paolino Romaldo detto il Nero, Atenulfo di Burello, Sichinulfo di Beraldo, Paolo de Atenulfo
*, ma non vi sono indicazioni che ci permettano di dire qualcosa sulle loro reali attribuzioni.
3. Famiglia "de Insula - Aymon"
Nel privilegio del 1169 del Conte di Caserta (vedi sopra) è ricordato un fedele del conte, Gerardo de Insula, al quale, evidentemente per i suoi meriti, sono concessi, tra l'altro, il castrum di Montenero e la chiesa di Sant'Altissimo*, benefici questi riferibili al territorio di Arpino. Tuttavia, il primo personaggio della famiglia a noi sufficientemente noto è Petrus de Insula, monaco benedettino, che nel 1174 fu eletto Abate di Montecassino, con il nome di Pietro II. Egli riuscì ad ottenere sia dal Papa che dall'imperatore Enrico VI molti privilegi a favore dell'Abbazia. Partecipò al Concilio Lateranense e morì nel 1186*.
Al 1187 si data probabilmente il Catalogo dei Baroni che dovevano contribuire, sotto il re normanno Guglielmo II il Buono, alla spedizione in Terra Santa
*.
Vi risulta che Roffredo dell'Isola e suo nipote mettevano a disposizione per Isola e Castelluccio 4 milites (e con l'aumento di otto) e dieci servientes. Ricordiamo che i milites appartenevano al ceto nobiliare allora in formazione. Nel Catalogo si legge anche che Raynaldus Boccavidellus possedeva in Isola un feudo di due milites e in Aquino un quartiere feudo di due milites. Ma, ovviamente, come ben rileva il Cayro, l'Isola di cui si parla in quest'ultima citazione è quello che fu poi definita Insula Solarata (ed è ora Isoletta) e non Isola del Liri, come ritiene l'Antonelli*.
Nel 1188, intanto, dopo due anni di sede vacante, divenne abate dell'Abbazia di Montecassino lo stesso Roffredo dell'Isola
*,
che dimostrò negli anni successivi singolari doti di uomo politico e di guerriero. Non vi è alcun dubbio circa l'identità fra il Roffredo feudatario di Isola e il Roffredo Abate di Montecassino. Infatti, Riccardo di Sangermano, per il 1191, parlando di due personaggi beneficati da Roffredo, tra l'altro così scriveva: "... Roffridus ... Roccam Bantrae ad opus retinuit Monasterii Casinensis, ponens ina custodem quendam militem Petrum de Aymon consobrinum summ"
*.
Come si vede, ritorna anche in questo caso, per lo stesso periodo, un Roffridus, che è qui precisamente ricordato come l'abate di Montecassino, e il nipote, il cui nome era Pietro de Aymon*.
Quando Guglielmo II il Buono (1166-1189) morì, Enrico VI, figlio dell'imperatore Federico Barbarossa, avendo sposato Costanza d'Altavilla, divenne il pretendente alla corona di Sicilia, ma si trovò contro Tancredi, figlio naturale di Ruggiero*.
In questa difficile situazione, Roffredo fu uno dei Baroni che giurarono fedeltà ad Enrico VI. Costui, intanto, alla testa di un numeroso esercito, nel 1191 dalla Germania scese in Italia, occupando un vasto territorio e lasciando poi Corrado di Marlenheim come comandante di Rocca Sorella e Diopoldo come comandante di Rocca d'Arce*. Enrico VI, nel partire, condusse con sé Roffredo dell'Isola, al quale confermò il Privilegio dell'imperatore Lotario III e inoltre una Contea comprendente Arce, Castrocielo, Castroforolo (oggi Santopadre) e Pico*. Non appena, però, l'Imperatore si allontanò, ricominciò la lotta fra i suoi partigiani e quelli di Tancredi, sino a quando Enrico VI mandò dalla Germania un forte esercito, guidato dallo stesso Roffredo dell'Isola e dal conte Bertoldo, che combattè con alterna fortuna nel Lazio Meridionale. Sopraggiungeva intanto la morte di Tancredi ed Enrico VI ne approfittò per scendere nuovamente in Italia con un altro esercito, impadronendosi della Terra di Lavoro*. Egli stesso, riconoscendo i meriti di Roffredo, gli donò Atina e Roccaguglielma. Dopo il suo ritorno in Germania, segui una nuova ribellione dei Baroni "forsi per gelosia, poiché l'Imperadore molto favoriva l'Abate di Monte Casino"*. Alla morte di Enrico VI, per breve tempo governò Costanza e quando anch'ella morì, divenne tutore del figlio Federico il papa Innocenzo III.
Questa volta furono i fedeli di Enrico VI, Diopoldo e Corrado di Marlenheim, che non accettarono la nuova situazione e coalizzandosi con Marcovaldo, Duca di Ravenna e Marchese di Ancona, presero a devastare la Terra di Lavoro. Sangermano, nel 1199, fu assediata e Roffredo l'abbandonò, rifugiandosi dapprima nel Monastero, poi ad Atina ed infine nella Marsica, per chiedere aiuto al Conte di Celano. Solo nel 1201, con l'aiuto di Gualtiero Conte di Brienne, egi recuperò i territori in precedenza perduti. Diopoldo fu preso allora prigioniero, ma il Conte di Sora, Corrado di Marlenheim, che aveva esteso la sua influenza sulla Terra di Lavoro, ben presto riprese le armi con altri Baroni*.
Una prima spedizione dell'esercito papalino (1207), guidato dal cardinale Pietro contro di lui, fallì proprio per la vigorosa resistenza opposta dal Castello dell'Isola
*.
Corrado assalì allora di notte, ma senza risultato utile, Bauco (attuale Boville Ernica)
*.
Per compiere questo attacco egli dovette attraversare il territorio di Isola del Liri. Seguì allora una seconda spedizione, al comando dell'Abate di Montecassino Roffredo e dei Signori di Aquino. Sora fu direttamente investita e si arrese il 5 gennaio 1208. Corrado riuscì a resistere nella Rocca Sorella sino al 16 febbraio, ma poi dovette cedere*.
Egli uscì così dalla scena politica, mentre nello stesso anno 1208 (18 giugno) Riccardo Conti, fratello di Innocenzo III, fu proclamato Conte di Sora e di Arce. Fra le terre concesse a Riccardo, poi confermate da Federico II nel 1211 e infine donate (in data 11 ottobre 1215), figuravano Isola e Castelluccio
*.
Per quanto riguarda Roffredo, ricordiamo che egli fu anche nominato da Innocenzo III suo Legato in Sicilia. Lo stesso Papa, soddisfatto della sua opera, gli concesse la Propositura di Atina. Roffredo morì un anno dopo, nel 1209*.
Ad interpretare gli avvenimenti riguardanti Isola sinora descritti, dobbiamo ritenere che Roffredo, preso da incarichi sempre più importanti e poi divenuto Abate di Montecassino, abbia inizialmente delegato al nipote il governo di Isola, spostando poi gradualmente i suoi principali interessi nel territorio gravitante intorno all'Abbazia, ma sempre pronto ad intervenire nella Media Valle del Liri in casi difficili, come quello rappresentato dalle arbitrarie occupazioni di Corrado di Marlenheim. Roffredo, comunque, rivela in questi frangenti, con le sue qualità di guerriero, le sue origini di castellano feudale. Ma Innocenzo III, se da un lato riconosceva i meriti di Roffredo, dall'altro era fermamente intenzionato a favorire il fratello Riccardo. Questo spiega la cessione di Isola e la rinnovata inclusione di questo centro nella contea sorana, anche se la famiglia de Insula vi ritornerà presto al potere.
Ad un periodo che va dalla fine del XII secolo agli inizi del XIII, nella zona intorno all'Abbazia di San Domenico doveva già essere in funzione una fabbrica di pannilana, a giudicare dal fatto che il monastero era tenuto a pagare un censo di cento braccia di panno nella festività di Pasqua e Natale*. Anzi si può ragionevolmente supporre che questa attività fosse esercitata dagli stessi monaci.
Federico II, dopo aver ricevuto la corona imperiale nel 1220, iniziò ben presto una politica di riaffermazione della sua autorità, contro il Papato. uno deisuoi primi provvedimenti fu quello di privare Riccardo della Contea di Sora (comprendente, come abbiamo visto, anche Isola e Castelluccio). Seguì un periodo turbinoso di lotte. Diversi centri inizialmente si opposero all'Imperatore, ma fra questi soltanto Sora continuava a resistere. La città fu allora assediata e, presa con la forza, fu data alle fiamme, con grande strage degli abitanti e dei soldati del Papa che vi si trovavano. Anche il Ponte Marmone durante questi avvenimenti bellici fu distrutto. Ritornando ad Aquino, Federico II passò per la via di Isola
*.
Nella stessa Isola e Castelluccio, occupate per ordine dell'Imperatore da Stefano de Anglone, "Giustiziere" della Terra di Lavoro, furono poste delle guarnigioni.
Sembra poi, secondo quanto asserito da Riccardo di Sangermano, che anche l'Isola di Sora e l'Isola Solarata siano state date alle fiamme*, ma indubbiamente, anche se questo è vero, con danni molto ridotti ad Isola del Liri in confronto a quelli subiti da Sora. Nello stesso anno, quando appena "si era dato riparo a' danni sofferti"
*,
papa Gregorio IX dette ordine che Pandolfo, ciambellano di Tommaso Conte de' Marsi, muovesse con il suo esercito contro il Regno di Napoli, per riconquistare le terre tolte alla Santa Sede. Pandolfo allora puntò verso Isola e la tolse di mano agli Imperiali, ma non appena terminarono le ostilità, questi tornarono nella cittadina
*.
Nel 1250 morì Federico e, come è noto, nel suo testamento dette disposizioni per la ricostruzione di Sora. Alla sua morte, il papa Innocenzo III pretendeva che il Regno di Sicilia fosse devoluto allo Stato della Chiesa e si riaccesero allora le ostilità contro Corrado IV e Manfredi. Quest'ultimo, nel settembre del 1251, marciò contro i Conti di Aquino e di Sora, debellando i suoi avversari
*.
Dopo la morte di Corrado, fu necessario un nuovo intervento di Manfredi, che sottomise gran parte di Terra di Lavoro, ad eccezione di Sora e di Arce
*.
In questi anni turbinosi che seguono la metà del secolo, possiamo inquadrare cronologicamente una citazione riportata in un atto di vendita del 1273. Vi compare una Cecilia, figlia del defunto domni Henrici de insula filiorum petri. Ci troviamo di fronte, probabilmente, ad un altro feudatario di Isola, riguardo alla cui famiglia nulla sappiamo
*.
Dopo la discesa in Italia di Carlo I d'Angiò, con la definitiva sconfitta di Manfredi e la sua morte in batttaglia, il vincitore nel 1269 si accinse ad un'opera di riorganizzazione dei castra (castelli) della zona. Ci rimane di questo programma un documento del 28 novembre 1869, conservato nell'Archivio di Stato di Napoli*,
che riveste una notevole importanza per Isola del Liri. Dal citato documento risulta che Carlo I d'Angiò, avendo definito il numero dei castellani militi, scutiferi e contergi e degli inservienti da tenersi in ciascun castello e avendo inoltre stabilito l'ammontare degli stipendi da pagarsi ad ognuno di loro in quattro rate, dà istruzioni ai "Secreti" del Principato, della Terra di Lavoro e dell'Abruzzo per il pagamento della rata di settembre, ottobre e novembre. Dà inoltre disposizione per il pagamento degli stipendi dei cappellani dei castelli che non avevano proventi e per le riparazioni necessarie negli stessi castelli.
Nel documento si legge che in Insula Filipetri vi era allora un Contergius, al quale veniva attribuito uno stipendio annuale di 14 once d'oro e di 18 tarì (o tareni) e per la quarta parte dell'anno once tre, tarì 19 e grana 10. In particolare, si rileva che ai castellani militi spettavano ogni giorno 2 tarì d'oro;ogni cappellano con un chierico riceveva 16 grana d'oro al giorno ed ogni inserviente 8 grana. Come si vede, vi erano fra i castellani diversi livelli di stipendio, sicuramente corrispondenti all'importanza che si attribuiva ai castra loro affidati. Precisiamo che in Castro Pescli Falconarie (Arpino) e in Castro Sorelle (a Sora) vi era un Castellanus miles; in Castro Civite Veteris (sempre in Arpino), in Castro Fontane, in Castro Rocce de Archis, in Castro Ianule un castellano scutifer; infine, in Insula Filipetri, in Castro Lupici e in Castro Celi un contergius.
E' evidente, per le distinzioni sopra indicate, che Isola del Liri doveva avere in quell'epoca un sistema di fortificazioni ancora piuttosto modesto e che solo in seguito essa fu difesa da un castello più articolato e difficilmente espugnabile. E' interessante anche notare che alcuni dei castra citati nel documento avevano necessità di restauri, ciò che presuppone un loro impianto più antico o danni subiti nelle lotte dei decenni precedenti. Tali restauri dovevano essere realizzati per mezzo degli uomini delle Terre e delle località, qui ad ... reparacionem tenentur
*.
Da altra fonte, sappiamo che nello stesso 1269 vi erano in Napoli Roffredo Isola e Giovanni Aymone, possessori della Terra dell'Isola, i quali avevano ceduto i loro diritti, con l'approvazione di Carlo I, a Robert de Brienson*, uno dei tanti feudatari francesi a cui il re aveva affidato il governo dei locali castelli, ritendendoli a lui fedeli e per ricompensarli di quanto avevano fatto a suo vantaggio
*.
Da ciò si rileva:
1) che alla famiglia "de Isola" erano già stati in precedenza nuovamente riconosciuti i diritti su Isola del Liri, a noi noti documentariamente sin dal 1187;
2) che la cessione (probabilmente forzosa) di tali diritti rientrava in un più vasto progamma di Carlo I d'Angiò rivolto a mettere nei posti di comando feudatari francesi a lui fedeli. Sembra però strano (ed è forse una ripetizione della notizia del 1187) il binomio di Roffredo e del nipote, anche se è indubitabile il passaggio del poteri dalla Famiglia "de Isola-Aymone" ad un feudatario francese.
La cessione di cui abbiamo parlato fu certamente temporanea o parziale, perché nel 1276 Bartolomeo Isola, figlio di Roffredo, appare come possessore della terza parte di questa Terra
*.
Tre anni dopo, nel 1279, risulta che Federico Isola aveva vassalli a lui sottoposti sia in Isola che a Castelluccio*.
Infine, nel 1310, il re Roberto d'Angiò, successore di Carlo II, con un suo diploma, rimetteva al suo Vicario le rimostranze di un Roffredo di Isola di Napoli, contro alcuni turbantes i suoi diritti sui castelli di Insula filiorum Petri e di Castelluccio
*.
Da notare che nelle Rationes Decimarum del 1308-1310, per la diocesi di Aquino e per il castrum Insule (Insula Solarat) sono citati l'abate Giovanni, figlio del Signore Roffredo de Insula e l'abate Matteo de Insula
*.
Roffredo dovrebbe essere il già citato signore di Isola del Liri e di Castelluccio, ma si sottolinea comunque di nuovo la possibilità di confusione fra le diverse Isole.
Sembra essere questo il momento di maggiore potenza della Famiglia de Insula, la cui graduale affermazione ebbe certamente come base l'opera meritoria degli Abati di Montecassino Pietro II e Roffredo. La connessione territoriale fra Isola e Castelluccio, qui constatata, è poi una realtà che riaffiorerà più di una volta nel corso secolare della storia dei due paesi. Sono anche da sottolineare i legami che i de Insula ebbero a lungo con l'ambiente napoletano. Proprio a Napoli essi riuscirono probabilmente ad avere quelle conoscenze altolocate che spiegano la durata della loro fortuna.
Pochi anni dopo, nel 1316, ci appare una situazione politica e amministrativa completamente diversa. La famiglia "de Isola", per estinzione o cessione dei suoi diritti, non possiede più i suoi antichi feudi. Infatti, nel 1316, in un Diploma del Re Roberto, si legge che il nuovo Signore di Isola e di Castelluccio è un certo Novellone di Salvilla*.
Per il terzo decennio del secolo XIV abbiamo alcune notizie di economia riguardanti Isola. Per il 1320-1321 risulta che, nell'ambito delle tasse che si dovevano versare nel Giustizierato della Terra di Lavoro, Insula Filiorum Petri doveva versare 13 once, 1 tarì, 14 grana e Castellucio once 9, tarì 6 e grana 1*.
Nello statuto di Arpino del 1329 si dispone che la carne sia venduta al prezzo in vigore in altre città, specialmente vicine ad Arpino, "ut in Insula et Albeto et ubi minori (sic) pretio venduntur"*.
In un privilegio del 1339, Filippo Estentnardo (Etendard e Stendardo), un altro feudatario di origine francese, vende la metà di Castelluccio a Tommaso de Zaulis, segno questo che le sorti di questo paese si erano ormai distaccate da quelle di Isola del Liri
*.
Anche per Isola la situazione è piuttosto confusa. Al 1340 risale un documento in cui il re Roberto dà l'assenso alla transazione convenuta fra Clemenza di Villaclubay (...) e Carlo di Stella, ambedue possessori di alcune porzioni dell'Isola e di Castelluccio, mentre lo stesso Re rinunzia al diritto che aveva sulla quarta parte della torre del Castello*.
Per il 1345-1346, si ha notizia da un documento dell'Archivio angioino, di alcune cartiere in funzione "in fine di un terreno della mensa vescovile" (diocesi di Sora), ma non se ne dà l'esatta collocazione*.
4. Famiglia de Celano
Dopo gli ultimi avvenimenti descritti, per alcuni decenni, non emergono, per quanto attualmente ci risulta, notizie riguardanti Isola del Liri, ma un passo del Di Costanzo ci permette di ricostruirne almeno in parte la storia.*
Scrive il Di Costanzo che nel 1393 una gran dama, vedova di Casa Celano, si trovava nell'Isola presso Pontecorvo. Un capitano chiamato Domenico di Siena*, evidentemente approfittando della sua debolezza di donna e con l'intenzione di impadronirsi del feudo, di notte scalò il Castello e la violentò. Tutto ciò gli costò tuttavia molto caro, poiché pochi giorni dopo il nipote della donna, Paolo da Celano, fece irruzione nella casa dove dimorava con la nuova sposa e lo "fece morire con grandissimo strazio"*.
A proposito di questo resoconto dei fatti, il Cayro, tuttavia, giustamente (vedi dopo) precisa che l'Isola non era certamente quella "presso Pontecorvo", ma Isola del Liri (ancora una volta quindi si può constatare la confusione fra le diverse Isole) ed aggiunge, con testimonianze documentarie, che Domenico di Siena, Barone di San Giovanni Incarico, non era Capitano ma Commissario incaricato di esigere "le nuove tasse dall'Abbadia Cassinense e Valle di Cominio nel 1383"*.
Per quanto ci riguarda, ci preme sottolineare che nel 1393 la dama feudataria di Isola del Liri era vedova di un componente della Casa di Celano, nobile famiglia originaria della Marsica, e che pertanto già anteriormente a tale data questa Famiglia possedeva Isola del Liri.
Un diploma dell'Archivio di Stato di Napoli del 19 ottobre 1400 ci informa su una questione di confini sorta tra Matteo da Celano, ciambellano e consigliere regio e Signore di Isola del Liri da una parte e Giacomo Etendard, milite, consigliere regio, maresciallo del Regno di Sicilia e Signore di Arpino dall'altra. Si trattava di accertare se la Torre di Carnello (quindi già esistente in quest'epoca) fosse situata in territorio di Arpino o di Isola del Liri ed il re Ladislao affidava il giudizio su tale controversia a Donato di Arezzo, dottore in legge e anche lui consigliere regio*. La disputa fu decisa a favore di Matteo da Celano.
Matteo da Celano è lo stesso che dopo la morte di Carlo III, assassinato in Ungheria nel 1386, era stato tra i partigiani di Luigi II d'Angio, ma che in seguito, dopo la vittoria della Casa di Durazzo, l'otto luglio 1393, era stato riammesso nelle grazie del re Ladislao insieme con Giacomo Cantelmo
*.
In un documento del 26 gennaio 1410, D. Bartolomeo di Filippo, arciprete di Vicalbo, davanti alla curia del Conte di Celano, protesta per le modalità del pagamento di alcuni censi dovuti alla chiesa*.
In un rescritto pontificio del 5 settembre 1452, riguardante il monastero di benedettine di San Giovanni Battista, che sorgeva ad Isola del Liri, si fa cenno a due Baroni del Castello di Insula Filiorum Petri. Il primo, Paolo da Celano, era probabilmente il successore di Matteo. E' lo stesso che, come abbiamo visto, uccise l'usurpatore Domenico di Siena e probabilmente si può identificare con il Paolo da Celano che, secondo il Corsignani, visse all'epoca di re Ladislao di Napoli (1386-1414) e con regio diploma divenne rettore e commissario nelle città del Lazio e in Sezze*. In realtà, abbiamo già visto nella controversia per la torre di Carnello che anche Matteo era stato insignito da Ladislao di importanti cariche. Il secondo è Giuliano da Celano, figlio di Paolo e suo successore, che risulta Signore di Isola prima e dopo il 1452 (data del rescritto pontificio)*.
5. Famiglia Cantelmo
Nel 1439 è ancora una vedova della stessa famiglia, Antonella da Celano, che, con un matrimonio politico, viene sposata da Nicolò Cantelmo, il quale diviene così anche Conte di Sora e nel1443 duca di Sora
*.
E' probabile che Antonella avesse sposato in prime nozze un Tomacelli; infatti, il 15 settembre 139 Giovanni Tomacelli aveva ricevuto l'investitura della Contea di Sora*. Quando Nicolò Cantelmo morì, nel dicembre 1454, lasciò come suo erede Pietro Giampaolo*.
Attraverso Antonella, forse alla morte di Giuliano da Celano e comnque prima del 1460, Isola del Liri e Castelluccio erano passate intanto ai Cantelmo e da questo momento in poi la storia dei due paesi sarà strettamente legata a quella di Sora. E' noto l'atteggiamento che Giampaolo tenne nella lotta fra Aragonesi e Angioini. Da una parte vi era il re Ferdinando I, spalleggiato dal Papa Pio II,dall'altra alcuni fra i più potenti Baroni del Regno, che nel 1458 avevano acclamato come loro re Giovanni, figlio di Renato d'Angiò*.
Al gruppo dei Baroni ribelli si unì Giampaolo, il quale nel 1460, dopo alterne vicende belliche*, si ritirò a Castelluccio con gli armati comandati dal senese Antonio Petrucci. Il Petrucci fu preso prigioniero, mentre Giampaolo si salvava con la fuga, ma, dopo aver promesso di sottomettersi a Ferdinando, riprese ben presto le armi contro di lui.
Allora, nel 1463, Napoleone Orsini, al comando delle milizie papali (circa mille uomini), investì Isola del Liri e ne occupò dapprima il territorio e l'abitato. Fu poi attaccata la stessa Rocca. La Torre maggiore di questa, colpita dalle bombarde disposte aldilà del fiume, crollò e i papalini poterono impadronirsene. Era ormai la sconfitta per Giampaolo. Isola, Castelluccio, Sora, Arpino, Casalvieri e Fontana, con il patto di Arpino del 24 novembre 1463, rimasero in possesso della Chiesa, mentre il Duca di Sora dovette passare al partito degli Aragonesi.
La nuova situazione era tuttavia svantaggiosa per il re Ferdinando, il quale solo nel 1472 e dopo ripetuti tentativi, riuscì a spingere il nuovo pontefice Sisto IV a rinunziare ai suoi diritti sul Ducato di Sora*.
6. Famiglia "della Rovere"
Nel 1472, dopo la rinunzia di Sisto IV, Ferdinando concesse il Ducato di Sora a Leonardo della Rovere, nipote del Pontefice, dandogli in moglie la figlia naturale Caterina*. Iniziava così un nuovo dominio, che durò per circa un secolo, ma con periodi di intervallo. Leonardo governò per pocotempo. Il 24 novembre 1475, infatti, il re Ferdinando investì dello Stato e Ducato di Sora Giovanni d'Aragona della Rovere*.
Quando re Carlo VIII discese in Italia, il partito angioino si risollevò. Il 22 febbraio 1495 il Re francese entrava a Napoli e il 5 agosto 1496 i Baroni si riunivano in la rocha del castello de Isula per giurare e firmare il patto che li legava al Re di Francia contro il re Ferdinando II d'Aragona. Fra gli altri, firmavano Pietro Giampaolo Cantelmo, duca di Sora, e Giovanni della Rovere*.
Morto Ferdinando II il 7settembre 1496, il suo successore inviava contro i ribelli il Gran Capitano Consalvo di Cordova. Fu espugnato prima il Castello di Isola e poi quello di Sora, difeso da Mario Equicola. Fu dura la punizione contro i Baroni e l'unico a salvarsi fu Giovanni della Rovere*.
A lui succedeva nel 1501 il figlio Francesco Maria il Vecchio, il quale era riuscito a respingere un attacco contro Sora di Cesare Borgia, ma dovette cedere nel 1516 dinanzi ad un esercito comandato da Ferdinando d'Avalos, che per ordine di Carlo V assediò Sora sino alla sua capitolazione. A queste operazioni di guerra, seguì l'investitura dello Stato e Ducato di Sora, fatta dell'imperatore a favore di Guglielmo di Croy*.
In seguito al riavvicinamento fra Clemente VII e Carlo V, il 30 maggio 1533, l'Imperatore stabiliva la reintegrazione del Ducato di Sora a favore di Francesco Maria della Rovere duca di Urbino*. Egli, però, il 7 maggio 1556 cedette il Ducato a suo fratello Francesco Maria della Rovere, con il consenso di Filippo II re di Spagna*. Tuttavia, in un atto di vendita della mola di Isola, fatta in data 10 giugno 1573 dal cardinale Giulio della Rovere, egli si qualifica ancora come duca di Sora*.
Al periodo in cui erano feudatari Guglielmo di Croy e i della Rovere, risalgono alcune significative testimonianze riguardanti la storia dell'industrializzazione della zona, per la quale più importanti sviluppi si ebbero in seguito con la famiglia Boncompagni.
Ci riferiamo ad alcuni documenti conservati nell'Archivio Segreto del Vaticano*. Due di questi sono datati al 14 luglio ed al 28 luglio 1519 e riguardano rispettivamente:
1) La donazione a favore di Ottavio Petruzzi di una "forma" con corso d'acqua scorrente dal fiume di Carnello per la costruzione di un edificio di una cartiera (donanti sono Evangelsta Carrara e Gaspare de Marescali);
2) la concessione per la costituzione di una cartiera sul fiume di Carnello, a favore della Comunità e degli Ufficiali di Sora, dietro la corresponsione di scudi dieci una tantum e di una risma di carta ogni anno per il futuro.
Segue, per il 5 gennaio 1535, l'atto di vendita di una cartiera, fatta da Ottavio ed altri della famiglia Petruzzi, a favore di Sebastiano Bonaventura. Ricordiamo che nella Reintegra dello Stato di Arpino al Marchese di Pescara, fatta nel 1548, per ordine di Carlo V, dal Consigliere Scaibano, risulta che il Marchese aveva nell'Isola di Carnello cum tribus molendinis, duas sedias molendini, drappaniam unam et duas bulcherias
*.All'anno 1572 risale un "Memoriale per il consenso al Duca di Sora per la compera della cartiera fatta da Angelico Fantoni de Prospero Celli" ed è del 26 ottobre 1574 "L'assenso originale" del duca Francesco Maria della Rovere, dato al fiorentino Francesco Angelico Fantoni per l'acquisto della cartiera e "invalchiera" di Sora dal notaio Prospero Celli e altri suoi parenti*. Nella Descritione dello Stato di Sora e suoi confini, composta da un Officiale del Vescovado nel 1579 e rivolta al nuovo Duca Giacomo Boncompagni, si legge che in quella data in Isola si faceva "esercitio di panni grossi" e che inoltre vi erano delle "gualchiere". Lo scrivente sottolineava poi la possibilità di potervi creare ferriere ed un'industria per la concia del cuoio*.
Per evitare alcuni equivoci sorti recentemente e riguardanti la famiglia Carrara, di cui abbiamo sopra citato un componente (Evangelista Carrara), crediamo opportuno dare necessarie precisazioni. In un articolo del 1986, Patrizia Fortini ha presentato una sua infondata ipotesi sull'architetto Evangelista da Carrara che nel 1570 ristrutturò il castello di San Casto*. La Fortini scrive testualmente: "Nonostante le ricerche espletate, non ho reperito alcuna notizia su questo architetto.Va sottolineato come Carrara sia un cognome bergamasco, derivato dalle "carrere": strade carraie o carri attraverso i quali gli abitanti orobici trasportavano le loro mercanzie attraverso l'intera penisola. Probabilmente Evangelista da Carrara fu uno dei tanti muratori (!), capi mastri o piccoli imprenditori della città lombarda, che per motivi di lavoro abbandonarono la propria terra ed arrivarono nell'Italia centrale ed a Roma*".
Sembra inspiegabile che l'Autrice, che pure cita nella stessa pagina l'articolo di S. Pagano riguardante l'Archivio Boncompagni, non si sia accorta dell'abbondante materiale archivistico riferibile alla sorana famiglia Carrara ivi contenuto.
Punto di partenza è la citata Descritione dello Stato di Sora, dalla quale sappiamo che "La cità fra le altre famiglie nobili ne ha quattro principali cioè casa Carrari, casa Mancini, casa Paladii e casa Ruggeri. E particolarmente tra Ruggeri e Carari da doi anni in qua sono nate inimicizie capitali, e con casa Carari pere che hora tenga casa Mancini e Paladii, di modo che la terra è molto divisa"*.
La famiglia doveva avere proprietà nella zona già nel XV secolo, perché, come abbiamo visto, nel 1519 Evangelista Carrara donò una "forma" in località Carnello per la costruzione di una cartiera. Da notare che questo rappresentante della famiglia era probabilmente il nonno dell'omonimo architetto, tenuto conto dell'usanza, allora molto diffusa, di ripetere i nomi degli avi. Quanto i Carrara fossero ricchi e potenti lo si può constatatre dal fatto che Giampietro Carrara il 18 ottobre 1619 stipulò un contratto di affitto per quattro anni dell'intero stato di Sora (vedi dopo), per una somma molto elevata (circa 48.000 ducati), evidentemente per lucrarne le rendite.
A proposito del pagamento di tale affitto, il nome di un Francesco Carrara ricompare diversi anni dopo, in una pergamena del 6 gennaio 1630. Nell'Archivio Boncompagni, con la data 22 gennaio 1744, si conserva poi un quaderno intitolato "Relazione dello stato del fiume Liri fatta da Basilio Carrara"*. Ricordiamo, infine, in questa sede la nota opera dell'umanista Ubertino Carrara*. Come si vede, per oltre tre secoli questa famiglia ha avuto sempre un ruolo attivo e di primo ordine nella vita economica del Ducato Sorano, alla quale ha contribuito con politici, affaristi o imprenditori, con un architetto, con un letterato e con un conoscitore di problemi idrografici.
7. Famiglia Boncompagni-Ludovisi
Preparata da una serie di atti, il primo dei quali si data al 12 settembre 1579, il 5 dicembre 1580 si attua la vendita del Ducato di Sora, da parte di Francesco Maria della Rovere a Giacomo Boncompagni Marchese di Vignola, figlio del pontefice Gregorio XIII, per scudi 100.000 d'oro*. La dominazione della famiglia Boncompagni sul ducato di Sora durò per oltre due secoli, sino al 1795. Alla morte del padre, Giacomo raggiunse il suo feudo, nel quale scelse come residenza il Castello di Isola del Liri, che fu poi la residenza locale prediletta dai Boncompagni.
Da quanto si legge nella citata Descritione dello Stato della Rocca, la Rocca di Isola già prima del 1579 aveva degli ambiento ampi e confortevoli: "... una rocca di fabrica antica ma molto comoda, con sale che hanno di longhezza più dicento palmi et con stantie grandi e magnifiche"*. Tuttavia, Giacomo Boncompagni intraprese un'impegnativa attività edilizia, che portò alla sistemazione e costruzione del Palazzo Ducale. Nel progetto del Palazzo era previsto anche un piccolo teatro: "Tra queste camere (del primo piano), sul lato destro coverto, se ne numerano due pe' teatrali spettacoli, essendovi in esse il palco scenario"*. Giacomo Boncompagni favorì inoltre l'introduzione dell'arte della lana "alla maniera fiorentina" attuata nella Terra d'Isola dal fiorentino Meo Neri, che si associò per questa iniziativa con Ippolito e Aurelio de Joannellis di Alatri (in data 28 novembre 1581).
Il 16 maggio 1583, sempre da fonti archivistiche, sappiamo che Giacomo acquistò "una cartiera e valche con orto annesso, poste nel territorio di Sora, nel fiume Fibreno, in vocabolo Carnello" da Francesco Angelico da Firenze*. Il Duca amava inoltre circondarsi di letterati e artisti, che incoraggiò nelle loro attività. Fra l'altro, fece decorare con pregevoli affreschi e stucchi diverse sale del Castello e sembra che nei primi anni del suo governo abbia dato incarico di progettare la "chiesa dell'Isola di Sora"
*. Nel 1590 Marco Sciarra, il Fra Diavolo di quei tempi, con la sua banda rinforzata da ribelli alvitani, dopo aver saccheggiato Settefrati e Gallinaro, si diresse verso Isola del Liri, con l'intenzione di invadere il Lazio, ma fu affrontato nelle campagne di Sora da un esercito di 4.000 uomini, guidato da Carlo Spinelli, e dovette ripiegare verso l'Abruzzo*.
Dopo la morte di Giacomo Boncompagni, avvenuta il 26 agosto 1612, si avvicendarono al governo del Ducato i suoi successori. Di Gregorio I (morto il 13 ottobre 1628) ricordiamo l'intervento per la fondazione e la dotazione del Collegio dei Gesuiti di Sora. Questo Duca il 18 otobre 1619 affittò per quattro anni lo "stato di Sora, consistente nella città di Sora, nelle terre di Brocco, Arci, Fontana, Isola e Castelluccio", per annui ducati 12.180 e grana 22, a Giampietro Carrara e Giovanni Evangelista Giannotti; il 26 ottobre 1620 concedeva poi in enfiteusi perpetua una torretta posta nelle mura di Sora*. Al periodo del suo governo risalgono documenti molto interessanti. Un fascicolo del 28 ottobre 1621 è intitolato "Regia provisione contro l'Arrendatore di Gaeta per il libero passaggio ed esenzione da ogni dazio sulle lane che si introducono per il lanificio della terra d'Isola"*. Come si vede, i Boncompagni (o chi per loro) cercavano di garantire esenzioni dal dazio a favore delle industrie isolane. Un altro fascicolo del 6 febbraio 1623 riguarda la "Regia concessione di erigere una ferriere nello stato di Sora"*.
Seguono: Giacomo II (dal 1628; morto il 18 aprile 1636); Ugo (morto il 28 ottobre 1676), il quale il 28 febbraio 1646 vendette all'Università di Sora due case con torre in contrada "la Cittadella"; Gregorio II Boncompagni Ludovisi (morto il primo febbraio 1707), che il 19 giugno 1701 istituì un censo di 1300 ducati "per l'annua risposta di ducati 91" a favore del monastero di Santa Chiara di Sora*.
Antonio I (morto il 28 gennaio 1731) sin dal 1690 resse come luogotenente il Ducato di Sora al posto del fratello, il quale con la famiglia si era trasferito a Roma. Venne anzi trattato come Duca anche dalla Corte Vicereale di Napoli, da quando Gregorio I nel 1701 giurò fedeltà al Re di Spagna in qualità di Correggente del Principato di Piombino*. Ma proprio nel 1701 Antonio si trovò in un posizione difficile. In seguito ad una rivolta politica avvenuta a Napoli ai primi di settembre ad opera del partito imperiale, uno dei capi della congiura, Don Giovanni Nicolò di Capua Principe della Riccia, cugino dei duchi di Sora, per salvarsi nello Stato Pontificio attraversò il ducato dei Boncompagni, inseguito da 1.500 soldati napoletani, comandati dal Commissario Regio Marchese Garofalo. Costui, a nome del Vicerè, ingiunse a Don Antonio di armare tutti gli uomini disponibili e di partecipare all'inseguimento del fuggitivo,del quale d'altra parte il Duca di Sora non conosceva l'identità.
Don Antonio aveva dato naturalmente ordine ai suoi di non superare i confini dello Stato Pontificio, ma probabilmente per l'intervento degli ufficiali napoletani non fu rispettato e il Principe della Riccia fu quindi raggiunto ed arrestato, dopo che aveva superato i confini del Ducato, in prossimità di Isola. Il Principe si riteneva sicuro di essere subito rilasciato in quanto parente del Duca, ma questi, professando dinanzi al Commissario Regio la sua fedeltà verso il Re di Spagna, affermò che il fuggiasco, anche fosse stato suo padre, avrebbe dovuto essere condotto al Palazzo. Il Principe fu quindi giudicato e, condotto in Francia, fu rinchiuso nella Bastiglia dove rimase per venti anni*.
Le conseguenze furono che si svolsero dei processi per la violazione di confine (a Frosinone, ecc.) e il Duca incorse nelle ire del Papa e nelle censure ecclesiastiche. Egli non avrebbe potuto superare i confini pontifici, perché i locali magistrati avrebbero potuto arrestarlo e inoltre era considerato scomunicato. Questa situaizone fu modificata solo nel 1726, in previsione del matrimonio del figlio Gaetano con Donna Laura Chigi. Allora, infatti, si giunse, seppure con qualche difficoltà, ad una riappacificazione fra il Duca di Sora e la famiglia del Principe Della Riccia. Del Duca Antonio ricordiamo anche che nel 1702 sposò la nipote Maria Eleonora, figlia di Gregorio II, di sedici anni (di 28 anni più giovane di lui) e dalla quale ebbe cinque figli*.
Lo stesso Duca Antonio, con un atto del 12 marzo 1711, estinse due censi di 2.300 ducati, che erano stati istituiti da Gregorio Boncompagni Ludovisi a favore del Monastero di Santa Chiara.
Tuttavia, tali rapporti finanziari dovettero dar luogo a controversie. Infatti, al 24 gennaio 1729 è datata una transazione in cui si conviene che il Monastero di Santa Chiara cede a favore del Duca il credito di circa mille ducati di un censo che si conosce già estinto ed il Duca solo "a titolo di elemosina" paga al Monastero 400 ducati*.
Il successore Gaetano (morto il 24 maggio 1777)si trovò a governare in una situazione esplosiva. Infatti, in seguito ad una vasta congiura filoaustriaca, che da Napoli si era diffusa nella Terra di Lavoro, vi erano stati nel Regno centinaia di arresti. Lo stesso ministro Tanucci aveva parlato di Sora, Isola, Arpino, Casalvieri e San Germano come di focolai di insurrezione. Nel 1744 Carlo III, proprio per riconfermare la sua autorità nella zona, mentre si recava alla guerra di Velletri, si fermò ad Isola e ad Arpino*. Verso la metà del secolo, l'industria della lana decadde e allora Gaetano fece venire dall'Olanda 12 artigiani con le loro famiglie, perché "ne curassero la ripresa"*. Anni negativi furono poi il 1763 e il 1764, quando il Regno di Napoli fu funestato prima dalla siccità e poi da una grave carestia*.
Gaetano Boncompagni, durante il suo governo, formò una ricca biblioteca nel Palazzo dell'Isola. Intensa fu l'attività edilizia che egli promosse: fece ricostruire la cupola della chiesa di San Lorenzo e fondare uno sperone di sostegno della stessa. Anche sotto la cascata, per la stabilità del Palazzo, fu realizzato uno sperone di sostegno. Fece ricostruire ad Isola la stanza del bargello nella Corte e lo Stallette nello stesso luogo, fuori della Porta di Regno, poiché erano state distrutte da un incendio; a Carnello l'edificio delle Valche, quello della cartiera, il ponte e la peschiera; a Sora la Mastrodattia e a stanza della Corte*.
L'ultimo Duca, Antonio II, resse il Ducato dal 1777 al 1795, anno in cui risale la documentazione relativa alla "permuta degli stati del duca di Sora da passarsi in regio demanio"*. Egli, fiutando i tempi nuovi, prese evidentemente una saggia decisione. Non molto tempo dopo Carlo III, seguendo un consiglio del Tanucci, costrinse infatti i diecimila feudatari del Regno a trasferirsi a Napoli, per poterli avere sotto controllo*.
Ad onore della Famiglia Boncompagni, oltre alle iniziative a cui abbiamo già accennato, si possono citare: notevoli lavori edilizi in Isola del Liri e nel suo circondario (casino di diporto sul colle San Sebastiano, due ponti levatoi sulle cascate), l'istituizione di una rameria nel locale detto il Valcatoio, l'introduzione dell'arte di trarre la seta, ad opera di artigiani settentrionali, ecc.*.
8. Il periodo francese e la Restaurazione
All'occupazione francese degli anni 1798-1799 corrispose un'aspra reazione locale, che si manifestò tra l'altro con il riacutizzarsi su più ampia scala del fenomeno del brigantaggio. Gaetano Mammone con i suoi accoliti, raccolti da diversi paesi, spadroneggiò a lungo nella zona, rintuzzando anche i primi tentativi dei Francesi di ristabilire la situazione. A questo punto, un esercito di 13.000 Francesi, guidati dal generale Watrin, si presentava davanti ad Isola del Liri. Mammone con i suoi fu costretto a ritirarsi e seguì allora, ad opera dei Francesi, la strage di una buona parte dell'innocente popolazione (circa 550 morti, uomini e donne)*. Il ritorno dei Francesi nel 1806 portò di nuovo alla contrapposizione tra il loro esercito e i briganti, questa volta comandati da Michele Pezza, meglio conosciuto come Fra Diavolo. Nel settembre, i Francesi si accampavano ad Isola, per puntare poi verso Sora, che veniva presa dopo brevi scontri
*.
Giuseppe Bonaparte fu Re di Napoli dal 1806 al 1808. In questo periodo si approvarono importanti provvedimenti e riforme amministrative. Fondamentale quella con cui il 3 agosto 1806 si abolì la feudalità in Italia Meridionale. Con legge del 16 ottobre 1806 venivano intanto riformati gli Statuti Municipali e i corpi rappresentativi delle Università (cioè i Comuni)*. Da allora essi furono indicati in modo uniforme con la denominazione di Decurionati. I decurioni dovevano essere in numero di 10 nei Comuni che avevano una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Essi erano sorteggiati fra quei proprietari che avessero una rendita perlomeno di 24 ducati. Inoltre, si imponeva che almeno un terzo dei membri del Decurionato sapesse leggere e scrivere.
Gioacchino Murat fu re di Napoli dal 1804 al 1818. Soprattutto in questo periodo, ad Isola, con l'impegno tenace delle persone più evolute, si poterono ricucire le profonde lacerazioni prodotte dalla strage del 1799 e si avviò quella proficua collaborazione fra popolazione e Francesi, che costituì la base di un efficente sviluppo industriale. Nel 1810 il francese Beranger prese in gestione la cartiera di Santa Masia delle Forme, nell'ex Convento dei Carmelitani. Egli fu il primo di un'illustre serie di industriali d'Oltralpe (Lefebre, Lambert, Courrier, Boimond, ecc.) ed italiani (Viscogliosi, Mancini, ecc.), che operarono con notevole successo ad Isola del Liri*.
Conosciamo i nomi dei Sindaci di Isola del Liri da quando fu attuato il nuovo ordinamento: dal 16 marzo 1807 Ottavio Marsella, dal 10 maggio 1807 Francesco Antonio Spagnoli, dal 25 novembre 1808 Giacinto Marsella, dal 28 aprile 1809 Carlo di Fede, dal 6 febbraio 1810 Luigi Merluzzi (con una lunga supplenza del secondo eletto Pio Pellegrini), dal 21 marzo 1811 Errico Zuccari, dal 17 gennaio 1813 Nicola Annonj*.
Con la Restaurazione, continuò a funzionare regolarmente il Decurionato. Riportiamo i nomi dei sindaci, facendo presente che dal 17 gennaio 1813 era in carica Nicola Annonj, dal 31 gennaio 1817 Ludovico Mancinelli, dal 16 febbraio 1820 Nicola Annonj, dal 2 aprile 1823 L. Spagnoli, dal 12 giugno 1821 Nicola Annonj, dal 6 luglio 1823 L. Spagnoli, dal 4 gennaio 1829 Antonio Mazzetti (con una lunga supplenza dal 14 marzo1832 del secondo eletto Ottavio Marsella), dal 21 febbraio 1833 Vincenzo di Fede, dal 4 gennaio 1835 Vincenzo Silvestri, dal 23 giugno 1838 Antonio Mazzetti, dal 15 febbraio 1841 Santino Marsella, dal 21 aprile1847 Michelangelo Campoli, dal 4 marzo 1849 G. Nicolucci (con supplenze di G.B. Nicolamasi e Tommaso Spagnoli), dal 29 settembre 1850 Loreto Mazzetti, dal 18 febbraio 1853 Tommaso Spagnoli, dal 2 gennaio 1859 Giuseppe Simoncelli (sino al 24 luglio 1861)*.
Nell'Isola del Liri del periodo risorgimentale si distinse la singolare figura di Giustiniano Nicolucci, che fu scienziato di fama internazione (con competenze che riguardavano l'antropologia, la paleontologia, l'archeologia, l'anatomia, la fisiologia, la patologia e la botanica) e, contemporaneamente, professore universitario e uomo politico aperto a rapporti con molti uomini rappresentativi del suo tempo.
Dai Registri delle Deliberazioni del Decurionato sappiamo che egli fece parte di questo Corpo Comunale come decurione dal 18 luglio 1848 e poi dal 4 marzo 1849 come sindaco. Accusato di fare parte della Giovine Italia, dovette tuttavia rifugiarsi in Italia Settentrionale. Nei citati Registri di Deliberazioni egli appare sostituito da supplenti dal 10 agosto 1849 al 29 settembre 1850, sino alla nomina del nuovo sindaco Loreto Mazzetti. Dopo un anno di permanenza a Torino, ritornò ad Isola dove potè risiedere in libertà vigilata e gli si vietò di uscire dal proprio Comune. Nel 1860, egli fu eletto nel Parlamento italiano, per una legislatura, come Deputato di Pontecorvo*.
Per l'espansione industrale registratasi nel nostro secolo ad Isola del Liri, argomento questo che non rientra in modo specifico nel nostro lavoro, ci limitiamo a ricordare gli stabilimenti di maggiore importanza (diversi ancora in funzione), che nel nostro secolo hanno operato nel territorio comunale: Cartiere Riunite Donzelli o Meridionali, Forze Idrauliche del Liri, Cartiere Angelo Mancini, Cartiere Emilio Boimond, Feltrificio Ippolito e Pisano, oltre ad alcuni lanifici.
Alla fine del mese di maggio del 1944, le truppe tedesche in ritirata provocarono gravissimi danni alle attrezzature industriali isolane, facendo saltare in più punti potenti cariche esplosive*. Presentiamo qui una documentazione fotografica* inedita riguardante le distruzioni di quelle terribili giornate. Gli edifici, ora abbandonati, delle fabbriche più antiche, con alcuni resti di macchinari (alcuni nelle foto nn. 13-19), che testimoniano i sistemi di lavorazione dell'epoca, costituiscono un notevole munumento di archeologia industriale, preziosa materia di osservazione per gli studiosi.
APPENDICE GIURISDIZIONALE ED AMMINISTRATIVA
a. Norme statutarie e giurisdizionali
Non vi sono studi specifici che riguardino la situazione giurisdizionale ed amministrativa di Isola del Liri attraverso i secoli. Tra l'altro, non è stato rintracciato sino ad oggi lo Statuto dell'Universitas isolana, che ci avrebbe permesso di avere una visione sufficientemente dettagliata, sotto questo aspetto, della vita di Isola nel passato.
Ricordiamo che per La Media Valle del Liri sono stati pubblicati dagli inizi del secolo ad oggi, integralmente o in parte, diversi Statuti e documenti amministrativi fondamentali*. Per Arpino: Statuto del 1329, Statuto del 1487 (approvato da Giovanni d'Aragona della Rovere), Bilancio del 1627-1628, Privilegi del 1463, Privilegi o Capitoli del 1584*; per Alvito: i Capitula cinquecenteschi e i Libri publicarum conclusionum Universitatis Terrae Albeti del sec. XVIII (inoltre, si ricorda un Liber censuumdi cui non resta più traccia)*; per Monte San Giovanni Campano, Strangolagalli e Colli: Statuti probabilmente relativi alla redazione del sec. XVII*; per Pescosolido: Statuto degli inizi del sec. XVI*; per Sora: Statuto del XVI secolo (datazioni espresse: 1534, 1547, 1560, 1586) , ma una parte risalirebbe al secolo XIV (vi si cita anche come fonte un Liber Consiliorum)*; per Veroli: Statuto nella redazione del 1540, contenuto in un codice della Biblioteca Giovardiana e pubblicato nel 1657*.
Per quanto riguarda Isola del Liri, non siamo attualmente in grado di produrre i documenti fondamentali più antichi, ma possiamo tuttavia raccogliere notizie documentarie più tarde, che ci permettono di ricostruire, perlomeno approssimativamente, quella che dovette essere nel passato la tessitura amministrativa di questo centro, peraltro analoga in gran parte a quella dei paesi vicini.
Nella "Descrizione dello Stato di Sora e suoi confini" si legge che mentre nella città di Sora risiedeva il "Governatore generale di tutto lo stato, nell'Isola rende raggione un Capitano, un altro in Fontana e un altro in Arce; Castelluccio va all'Isola a raggione e Brocco a Sora". Le sentenze date dai Capitani erano appellabili in seconda istanza a Sora, ma per quelle del Governatore, prima dell'avvento dei Boncompagni, si doveva ricorrere a Napoli. Il Governatore risiedeva a Sora in "un palazzo molto antico ma però assai comodo", posto sul fiume presso la Porta di Corte*. Ricordiamo che solo al tempo di Carlo V si cominciò a distinguere fra la carica di Governatore e quella di Capitano, dando alla prima un maggiore rilievo. In precedenza vi erano solo i Capitani*.
Nella "Descrizione" si parla diffusamente della comunità di Sora che "crea per i suoi ufficiali un Mastro giurato che ha cura di guardare la cità con homini armati da scandali e da disordini, crea poi Camerlenghi che hanno cura delle entrate pubbliche... Affitta ancora la Mastro Dattia,cioè la Cancelleria... affitta il passo e datio del vino.. un certo sopra più di balìa, cioè de danni... affitta la pezzicheria... la hosteria... il forno...paga un mastro di scola... un procuratore e l'avvocato de poveri". Unico accenno alla "comunità" isolana è invece là dove si dice, a proposito di Isola e Castelluccio, che "tra queste due comunità si contrasta per causa di questi confini, ma però sono tra loro in termine d'accomodamento"*.
Nell'Inventario dell'Archivio Boncompagni-Ludovisi, è rilevabile per Sora una notevole documentazione rigurdante i Governatori e Precettori (Prot. 187-193; 201-211), la Mastrodattia (Prot. 29,31; Prot. 31,41; Prot. 31,65); la Bagliva e controversie riguardanti l'Università (Prot. 30,34; Prot. 30;37; Prot. 31,67), i Commissari (Prot. 31,43), l'elezione dei Catapani e Grascieri (Prot. 31,66), Portulanìa e passo (Prot. 31,67), ecc.*. Per Isola del Liri, possiamo citare il Registro di Lettere dell'Agente dell'Isola (dal 1708 al 1801)*.Gli "Agenti" potevano essere degli incaricati che le università inviavano a Napoli per sbrigare affari più semplici, ma la figura ufficiale dell'agente era soprattuto quella di un commssario inivato dai tribunali per prendere informazioni riguardanti le tasse (numerazione di fuochi, ecc.) e su eventuali abusi commessi. Questi agenti, a quanto sembra, erano una vera iattura per le comunità, alle quali provocavano danni gravissimi con continue concussioni, frodi, ecc.*.
Particolarmente interessanti, nella documentazione dell'Archivio Boncompagni-Ludovisi, i ripetuti accenni a conflitti giurisdizionali. Nota il Pagano che fu costante preoccupazione di Giacomo Boncompagni quella di "difendere i tribunali del ducato e la sua personale autorità dalle ingerenze del Commissario di Campagna"*. Ne sono esempi due documenti, il primo dei quali risale al 25 novembre 1604: si tratta di un provvedimento con il quale la Regia Camera concede che i giudici del Duca di Sora possano procedere nella cause criminali contro i sostituti del Capitano della Grascia, purché non si tratti di reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni*. Al 28 ottobre 1621 risale un altro provvedimento regio, rilasciato in seguito a supplica del Duca di Sora, con il quale si permette che i giusdicenti del Duca "possano procedere civilmente e criminalmente contro Giacomo Palmieri, sebbene scrivano di ragione della regia corte". Il Palmieri si era reso colpevole di aggressione a mano armata ai danni di un ministro del vescovo di Sora e di altri reati*.
L'atteggiamento che Giacomo Boncompagni ebbe nei riguardi dei Privilegi locali e delle diposizioni statutarie si può ricavare da quanto accaduto ad Arpino nei primi tempi della Signoria del Duca di Sora su questo centro. Gli Arpinati, agli inizi del 1584, gli avevano chiesto la conferma e la concesione di privilegi e grazie e l'ottennero il 15 marzo 1584, ma il 4 luglio 1587 Giacomo Boncompagni, annullando la sua precedente decisione, ordinò che privilegi e capitoli dovessero osservarsi ad suum beneplacitum
*. D'altra parte, si deve osservare che la presenza del Governatore o dei Capitani dava ai cittadini una certa sicurezza. Lo si vede dalla supplica che gli Arpinati rivolsero al Duca: "Essendosi visto con l'esperienza ch'in tempo che non è riseduto il Governatore in questo stato di Arpino vi sono soccesi (sic) molti et varj deliti ... Vogli farle gratie concedere detto Governatore in detto stato secondo generalmente è stato voluto..."*.Nei rapporti con l'Università sorana i Boncompagni ebbero momenti buoni ed altri più contrstanti. La vendita "con patto di ricompra"della mastrodattia (cancelleria) di Sora, fatta dall'Università di questo centro a favore di Ugo Boncompagni in data 29 luglio 1649, è da interpretarsi come un aiuto che il Duca volle dare in un periodo di difficoltà finanziarie per l'Università sorana*.
Al contrario, una situazione tesa fra il duca Gaetano e l'Università di Sora affiora da diversi documenti del periodo 1790-1791 e la linea dura assunta dal Corpo comunale sorano potrebbe aver contribuito a far prendere al Duca la decisione di vendere lo Stato di Sora. Nel 1790 Gaetano prese posizione contro la magistratura sorana, che non intendeva "descrivere" nel catasto alcuni fondi di proprietà dello stesso Duca*. In quattro quaderni datati al 1790 e 1791 venivano esposte le "Ragioni a favore del duca di Sora contro l'Università di Sora, la quale pretendeva di tassare come corpi burgensatici la Mastrodattia, il molino d'Ischitello e le valchiere di Carnello"*. Infine, un Decreto in data 23 febbraio 1791 (del Regio delegato Governatore di Roccaguglielma) era rivolto a far eseguire provvedimenti regi "a favore della Camera ducale di Sora riguardanti l'elezione dei Catapani e Grascieri", da farsi dall'Università di Sora
*.
b. Bilanci di Isola del Liri
Per il 1578-1584, come si è rilevato, rimangono dei compendi inediti riguardanti lo Stato di Sora, ma cinque soli fogli si riferiscono a sei paesi, fra i quali Isola, Castelluccio e Sora*. Nell'Archivio di Stato di Napoli erano conservati i Bilanci Comunali del 1627-1628, conosciuti come "Stati di Tappia", perché erano stati esaminati e rivisti da Don Carlo Tappia, marchese di Belmonte e reggente della R. Cancelleria
*.
Purtroppo essi sono andati distrutti durante la seconda guerra mondiale. Il bilancio di questi anni di Sora era stato già pubblicato dal Magliari sul Bollettino Storico Volsco negli anni 1897-1898*, ma quello di Isola del Liri non aveva avuto tale fortuna. Gli "Stati di Tappia" costituivano uno schema di bilancio comunale, compilato dal Camerlengo, (o massaro, ecc.) e dagli "officiali" dell'Università, in conformità delle consuetudini, ed inviato a Napoli per la revisione e l'approvazione del Governo centrale*.
Nei registri delle Deliberazioni del Decurionato sono riportate estesamente diverse scritture contabli. Riteniamo che in questa sede sia opportuno pubblicare il primo bilancio "intero" di Isola del Liri giunto sino a noi, quello del 5 aprile 1807. Tra l'altro, facendo un confronto con il bilancio di Sora del 1627-1628*,
nel quale si rispecchiavano istituzioni e consuetudini amministrative più antiche, derivate dagli statuti cittadini, si potrà constatare che vi sono ancora evidenti le strutture amministrrative del vecchio mondo feudale.
BILANCIO COMUNALE DEL 1807
Dalle Deliberazioni del Decurionato - dal 30 Novembre 180 al5 Marzo 1826 (Arch. Isola, Pre/Reg. 1), p. 21 sgg.
- Carta legale con bollo del 1806 di grani due
|
|
|
|
p. 21 r
|
"Isola li cinque Aprile 180sette
Noi infrascritti Decurioni in esecuzione d'ordini del Sig. Sottointendente pervenutoci (sic) p(er) il canale della Reg(i)a Corte di Sora, relativamente a dover ciascun Corpo Decurionale formar lo stato discusso delle rendite, pesi ed esiti di ciascuna Commune, da trasmetterlo subito nella Sottointendenza, come pure per eleggersi due Deputati p(er) la liquidazione deiconti da farsi col Reg(i)o Ricivitore Manente, mediante l'autorizzazione ottenutane dal Sig. Sottointendente del Distretto a tali oggetti si è risoluto quanto segue:
Rispetto al primo Capo, essendosi dai Sig.ri Decurioni esaminati i bisogni della Commune, e(t)c(e)t(e)r(a) (sic), si è formato il seguente stato discusso:
Stato di q(u)esta Commune dell'Isola p(er) quello (che) deve annualmente alla Reg(i)a Corte, Creditori Istrumentari, Salariati, ed altre spese straordinarie secondo lo stato presente
Esito
Reg(i)a Corte
Per Xma (decima), e Doppia Xma annui doc(a)ti millecentonovantadue, e g(ra)na quarantaquattro, che si paga in sei mesi d'ordine Reale
|
|
|
|
p.21 v
riporto 1192:44
|
Istrumentarj
Agli Er(e)di del D(otto)r D(on) Loreto Mazzetti per le case ad uso di Macello annui doc(a)ti quindici
|
|
|
|
15:00
|
A Fratelli Raimondo Francescosaverio e Casimiro Paolucci p(er) frutti del Capitale di doc(a)ti novecento, giacchè gli altri cento, compimento dei mille gli hanno ricevuti da D(on) Luigi Chigi ritratti dalla censuazione dei terreni Demaniali di q(ue)sta Un(ivers)ità, giusta il Parlam(en)to dei 11mag(gi)o 1806, confirmato, ed approvato dalla Reg(i)a Cam(er)a a 7 Giug(n)o presso l'attuario D(on) Antonio Francione, e ridotto dalla med(esi)ma al cinque p(er) 100: annui docati quarntacinque
|
|
|
|
45:00
|
Salariati
Al Medico Condottato annui doc(a)ti centoventi
|
|
|
|
120:00
|
|
Al Cerusico an(nui) doc(a)ti settantadue
|
|
|
|
72:00
|
|
Al M(aest)ro di Scuola annui doc(a)ti trentase
|
|
|
|
36:00
|
|
Al Predicatore Quaresimale annui docati trentasei
|
|
|
|
36:00
|
|
|
|
|
|
1516:44
|
|
Al Reg(i)o Gove(ernator)e di Sora p(er) rata spettante a questa Commune annui doc(a)ti sessantacinque, e
|
|
|
|
p. 22 r
Rip(ort)o 1516:44
|
|
cinquantasei a norma de Reali ordini
|
|
|
|
65:56
|
|
Al Cancelliere di questa Commune annui doc(a)ti ventiquattro compresovi le fatighe strordinarie dentro l'abitato e non quelle fuori l'abitato
|
|
|
|
24:00
|
|
Al Castaldo di d(ett)a Commune annui doc(a)ti ventiquattro compresovi le fatighe strordinarie
|
|
|
|
24:00
|
|
Al Custode dell'Orologio an(nui) docati sei
|
|
|
|
6:00
|
|
All'Organista p(er) sonatura d'Organo per la Festa votiva della Commune annui doc(a)ti nove
|
|
|
|
9:00
|
|
Al Guardiano della Selva an(nui) doc(a)ti ventiquattro
|
|
|
|
24:00
|
|
Ai Rev(eren)di PP. Carmelitani p(er) la lampada votiva accesa giorno e notte avanti l'Immagine S(antissi)ma di Loreto an(nu)i doc(a)ti quattro e mezzo
|
|
|
|
4:50
|
|
Al Sacrestano p(er) il suono delle Campane an(nui) carlini venti
|
|
|
|
2:00
|
|
Ai Razionali p(er) la misura dei conti annui doc(a)ti sei, e carl(in)i sei
|
|
|
|
6:60
|
|
All'Avvocato, e Procuratore in Napoli annui doc(a)ti venti
|
|
|
|
20:00
|
|
|
|
|
|
1702:10
|
|
Al Sindaco per la formazione dei Libretti per tutto l'anno delle imposizioni
|
|
|
|
p. 22 v
Rip(or)to 1702:10
|
|
annui docati 6
|
|
|
|
6:00
|
Spese straordinarie
Per riattamenti di strade, Fontane, Ponti, Chiesa Parrocchiale, e cavi dei Fiumi un'(sic) anno p(er) l'altro annui doc(a)ti cinquanta
|
|
|
|
50:00
|
|
Per spesa dei Corrieri an(nui) doc(a)ti centocinquanta
|
|
|
|
150:00
|
|
Per Festa votiva dei S(anti) Protettori an(nui) doc(a)ti cento
|
|
|
|
100:00
|
|
Per alloggio dei soldati, stramma (sic), e letto un anno p(er) l'altro annui doc(a)ti cinquanta
|
|
|
|
50:00
|
|
Per mantenim(en)to di sette Projetti an(nui) doc(a)ti cento sessant'otto
|
|
|
|
168:00
|
|
|
|
|
|
Sono in tutto 2226:10
|
Dall'impiego delle descritte somme devono esibirsi nel rendimento dei conti legittimi documenti e tutto ciò, che non verrà impiegato in ciascun ramo di esso deve rimane in Cascia (sic) separata
Introjto
Dall'affitto del Macello annui doc(a)ti trenta e g(ran)a dieci
|
|
|
|
30:00
|
|
Dalle sue stanze terranee p(er) uso di Macello annui doc(a)ti quindici
|
|
|
|
15:00
|
|
|
|
|
|
45:10
23 r
Rip(ort)o 45:10
|
|
Dalla Pizzicaria an(nui) doc(a)ti centosessanta, e g(ra)na dieci
|
|
|
|
160:10
|
|
Dal Forno an(nui) doc(a)ti sessanta, e g(ran)a novantuno
|
|
|
|
63:91
|
|
Dalla mettà (sic) dell'Osteria an(nui) doc(a)ti dieciotto, e mezzo
|
|
|
|
18:50
|
|
Dalla Zecca an(nui) doc(a)ti otto, e g(rana) dieci
|
|
|
|
8:10
|
|
Dai frutti della Selva Communitativa dedottone i Padroncelli del 20 p(er) 100 an(nui) doc(a)ti sessantaquattro
|
|
|
|
64:00
|
|
Somma in tutto l'introjto,
|
|
|
|
359:71
|
Della retroscritta somma di esito di doc(a)ti duemila,duecento ventisei,e grana dieci, toltone i sud(det)ti docati trecentocinquantanove, e grana settantuno d'introito, rimane l'Un(ivers)ità in debito di annui docati milleottocentosessantasei, e grana trentanove.
Dalla qual somma di docati 1866:39 toltone doc(a)ti 1192:44,che si ritraggono dalla Tassa di Xma, e doppia Xma, ed altri docati duecento, cioè docati 72 p(er) il Medico, docati 48 p(er) il Chirurgo, docati 30 p(er) la Predica Quaresimale, e docati cinquanta per riattamenti di Strade, Fontane, Ponti, Chiesa Parrocchiale, e cavi
|
|
|
|
23 v
|
dei Fiumi, che debbono esiggersi (sic) con Tassa particolare anche dai non possidenti, perché tutti ne sentono il comodo, qual tassa viene a ricadere a grana dodici ad anima in ogni anno, il mancante della somma consistente in docati 473:95 per il ripiano deve buttarsi con altra Tassa sopra i Possidenti.
Si avverte, che siccome vi sono varj altri debbiti (sic) di questa Commune predetta con Particolari Cittadini, venendo questi liquidati nella debita forma, se ne daranno in altra gli espedienti oppo(rtu)ni ... Omissis
Ottavio Marsella Sind(ac)o, e Decurione
Enrico Zuccari Decurione
Luigi Chigi Decurione
Leopoldo Nicolucci Decurione
Domenico Signorj Decurione
Domenico Cialone Decurione
+ Segno di croce di Cicerone Saccucci Decurione Illetterato
Francesco Lombardi Seg(reta)rio".
|
|
|
|
|
Nel bilancio (o stato) qui pubblicato è menzionata esplicitamente l'Universitas di Isola del Liri e si accenna al "Parlamento" dell'11 maggio 1806.
Il Parlamento, come scriveva il Santoro, "sebbene oculatamente, vigilato dal dipotismo prepotente e sospettoso, accolse, alimentò e accrebbe il germe delle libertà republicane". In origine, vi partecipavano tutti i capi-famiglia, detti Capofuochi. Il Parlamento avveniva previo bando pubblico e vi si eleggevano i Sindaci (ad Arpino il Camerario, a Pescosolido i Massari, ecc.) e gli altri ufficiali dell'Università. Le riunioni erano presiedute dai Sindaci e ad esse assisteva un rappresentante del Signore feudale. Le elezioni avvenivano con votazione palese sino al 1776, quando il Re ordinò che essa divenisse segreta*.
Nel Bilancio si adopera più volte il termine "la Commune", secondo la fraseologia di provenienza francese. Fra i "salariati" della "Commune" figurano: il medico condotto, il cerusico, il maestro della scuola, il predicatore, quaresimale, il cancelliere, il castaldo, il custode dell'orologio, l'organista, il guardiano della Selva, il sacrestano, i razionali, l'avvocato procuratore in Napoli, il sindaco. Una contribuzione veniva data annualmente al Regio Governatore di Sora ed una somma annuale era corrisposta ai PP. Carmelitani per la lampada votiva della Madonna di Loreto. I personaggi qui indicati compaiono frequentemente negli Statuti centro-meridionali*.
Per il Maestro di Scuola vi erano in alcune Università opposizioni (alla sua stessa presenza o alla consistenza del suo stipendio), constatabili sia nella popolazione, che non comprendeva ancora il valore dell'istruzione e cercava di risparmiare, sia nelle Autorità, che temevano il diffondersi della cultura*. Ad Isola del Liri, oltre al maestro, nel 1816, risulta presente anche una maestra*. Il cancelliere aveva parte delle attribuzioni che in seguito saranno proprie del Segretario Comunale; i castaldi avevano la funzione di messi comunali, mentre ai razionali era affidata la revisione dei conti*. Il Sindaco, nel bilancio del 1807, risulta retribuito solo per una parte limitata delle sue competenze.
Per quanto riguarda le somme corrisposte, rileviamo che un compenso ragguardevole veniva dato al medico condotto (120 ducati) e al cerusico. in una seconda fascia di retribuzioni vi erano il maetro di scuola e il predicatore quaresimale, mentre gli altri stipendi erano più modesti. La "Commune" svolgeva anche un servzio sociale con il mantenimento di sette "projetti" o "esposti" (trovatelli abbandonati). Irrisorie risultano le spese per interventi edilizi e stradali, mentre una congrua somma era destinata al servizio dei corrieri.
Dall'esame della parte del Bilancio relativa all'Introito, si rileva che le entrate fisse dell'Università provenivano dall'affitto del Macello e dalla gestione della "Pizzicaria", del forno, di metà dell'osteria, della "zecca" e dei frutti della selva comunale. Le altre entrate provenivano da diritti di decima e doppia decima o da tassazioni che potevano riguardare o tutti i cittadini o solo i possidenti. Precisiamo, poi, che la "zecca" costituiva la tassa sulle monete, sui pesi e sulle misure*.
In un registro di Deliberazioni del Decurionato*, in una data piuttosto tarda (2 settembre 1851), si accenna allo "Statuto penale municipale" di Isola del Liri. Riportiamo il testo: "Trovandosi riunito il Decurionato, il Sindaco à letto notizia (?) a stampa del Sig. Direttore dell'Interno comunicato dal Sig. Intendente della Provincia col quale si impone ai Sindaci perché propongano ai Consigli Comunali la revisione degli Statuti penali municipali, essendo spirato il quinquennio della loro durata giusta l'art. 280 della Legge dei 12 dicembre 1816. Il Decurionato, essendosi occupato della cennata revisione, trova in nulla doversi innovare lo Statuto penale municipale ed è di parere che abbia il suo pieno vigore per un altro quinquennio".
c. Andamento demografico di Isola del Liri
Le prime indicazioni riguardanti la consistenza numerica della popolazione si possono riscontrare solo indirettamente da un elenco di tasse rigurdanti il Giustizierato di Terra di Lavoro e la Contea del Molise per gli anni 1320-1321. Come è noto, la tassazione anticamente avveniva "per fuochi", cioè numerando le famiglie in grado di pagare anche una minima quota di tasse, ma il conteggio era in genere approssimativo ed era spesso concordato fra le Autorità centrali e le Università*.
Risulta dall'elenco che Isola era allora tassata meno di Alvito, Sora, Atina, Arpino, Settefrati, all'incirca come San Donato, Fontana e Picinisco, ed era maggiormente gravata nei confronti di Rocca d'Arce, Roccasecca, Fontechiari, Santopadre, Campoli, Casalvieri, Montattico, Posta, Vicalvi, Castelluccio, Pecosolido e Brocco*.
Il Gustiniani ci informa che Isola nel 1532 era tassata per 133 fuochi, nel 1534 per f. 138, nel 1561 per f. 156, nel 1595 per f. 192, nel 1601 per f. 195, nel 1669 per f. 198, nel 1737 per f. 186 e che, infine, nel 1795 aveva circa 2.600 abitanti*.
Un dato significativo ci deriva dallo Descrizione dello Stato di Sora del 1579 da cui sappiamo che in quel periodo Isola era conteggiata per 170 fuochi* e che quindi doveva avere oltre mille abitanti. Ci mancano ormai i dati statistici degli Stati di Tappia (bilanci del 1627-1628), ma abbiamo i risultati del Censimento della popolazionee dei beni effettuato dal 1744 al 1747 per volontà di Carlo III di Borbone. Nei relativi prospetti la popolazione di ogni paese appare divisa in tre Ceti: 1) civili, 2) mediocri, 3) inferiori. Per questo censimento, l'arciprete Cesidio Muscella affermava che le "anime" di sua competenza erano 1431, divise in 258 famiglie*. Come è noto, il 12 maggio 1799 furono massacrati dai Francesi 533 isolani e leggiamo negli atti del Decurionato che otto anni dopo la popolazione di Isola era di 1748 abitanti*.
Nel 1823 la popolazione di Isola, in forte incremento, ammonta a 2592 abitanti; nel 1846 era già salita a 4002 persone e nel 1856 a 4572, di cui un centinaio stranieri (francesi, tedeschi, inglesi "compresi i loro figli nati da madri isolane"). I maschi erano allora 2296 e le femmine 2276*. Il periodo della più intensa industrializzazione di Isola ha il suo riscontro nel Primo Censimento del regno d'Italia del 1861, quando gli abitanti risultarono 4796 e soprattutto nel II Censimento del 1871 con 6534 abitanti
*. In soli dieci anni la popolazione risulta cresciuta circa del 27%. Dagli inizi del secolo si evidenzia tuttavia un forte movimento migratorio. In sei anni (1901-1907) emigrano 479 persone. Nel 1911 Isola ha 8416 abitanti; nel 1921 (sei anni dopo il terremoto della Marsica 9103; nel 1961; 12.118*.
Il riordinamento dell'archivio comunale storico di Isola del Liri (di Marcello Rizzello e di Daniela Campagna)

1. Fonti archivistiche
Ad Isola Liri si riferisce un notevole complesso di fonti archivistiche, che sono tuttavia dislocate in luoghi diversi. Naturalmente, essendo stato questo centro per interi secoli compreso nelle entità statali che si sono susseguite in Italia Meridionale, una parte del materiale è attualmente conservata nell'Archivio di Stato di Napoli, nell'Archivio Storico per le Province Napoletane e nell'Archivio di Stato di Caserta.
Durante il lungo dominio dei Boncompagni, si è poi creato un consistente archivio, che considerato per lungo tempo come privato, in realtà riguarda direttamente i diversi settori economici, sociali, politici, ecc. del Ducato di Sora. I relativi documenti sono sistemati nell'Archivio Segreto del Vaticano. Recentemente, l'inventario di quella parte dell'Archivio Boncompagni-Ludovisi riferibile al Ducato di Sora è stato egregiamente pubblicato da S. Pagano*. Precisiamo che in tale inventario sono compresi anche molti atti e documenti del periodo che precede il dominio dei Boncompagni, a partire dagli inizi del secolo XVI*.
Altro materiale documentario, affluito nell'Archivio di Stato di Frosinone, in genere è inquadrabile cronologicamente nel periodo successivo alla creazione di questa provincia. Dei continui rapporti che Isola del Liri ha sempre avuto con Sora, resta una documentazione, seppur limitata ad epoca recente, nell'Archivio Comunale Storico di questo centro*.
Vi sono poi da citare gli archivi ecclesiastici. Ricordiamo soprattutto quelli dell'Abbazia di Montecassino e dell'Abbazia di Casamari e dell'Archivio Vescovile di Sora. Un'estesa documentazione è infine rintracciabile negli archivi parrocchiali, particolarmente in quello della Collegiata di San Lorenzo.
Non considerando la specifica bibliografia e limitandoci a considerare la documentazione di maggior rilievo, per il periodo delle origini di Isola e per la Contea sorana, le fonti archivistiche sono essenzialmente rappresentate dai fondi dei monasteri di Montecassino e di Casamari, dove si possono esaminare, ad esempio, le pergamene riguardanti la cella di San Benedetto di Colle d'Isola*, le diverse donazioni dei Signori e proprietari locali e particolari concessioni feudali*.
Per il periodo angioino e successivo, le testimonianze archivistiche sono concentrate nell'Archivio di Stato di Napoli (Archivio Angioino, Archivio della Zecca*). Un documento eccezionale, il Patto di Congiura, sottoscritto nel Castello dell'Isola il 5 agosto 1496, si trova nell'Archivio di Stato di Mantova*.
Per i secoli successivi, oltre al materiale dell'Archivio Boncompagni, sul quale ci soffermeremo in modo più particolareggiato, ricordiamo ancora per l'Archivio di Stato di Napoli i bilanci del 1627-1628, cd. "Stati di Tappia"* distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale, e i quattro volumi (con copertina in pergamena) della sistemazione catastale eseguita nel Regno delle Due Sicile, per disposizione di Bernardo Tanucci, ministro del re Carlo III. Essi comprendono: gli atti preliminari, lo stato delle anime, l'elenco dei possidenti isolani, dei possidenti forestieri, i beni demaniali, i beni ducali, le proprietà e i censi degli enti religiosi, i terreni privati, le confinazioni, le consistenze, i redditi e i pesi che vi gravano*.
Nella Chiesa Collegiata di San Lorenzo Martire di Isola del Liri, la documentazione più antica è quella delle "Delibere Capitolari". Si tratta di documenti contabili (spese) degli anni 1679-1680.
Interessante è poi il settore degli atti dello Stato Civile, che comprende registri degli atti di nascita dal 1733, registri di atti di matrimonio dal 1741 e registri di atti di morte dal 1744. Infine, per quanto riguarda il carteggio, si conserva corrispondenza dagli inizi del 1800 in poi. Ricordiamo che in un registro parrocchiale si può leggere il racconto della strage compiuta dai Francesi ad Isola del Liri il 12 Maggio 1799*.
Il parroco Don Enzo Tavernesi ci ha gentilmente riferito che l'Archivio della Collegiata subì gravi danni sia ad opera dei Francesi, sempre nel 1799, sia ad opera dei "Piemontesi" nel 1860.
2. L'Archivio della Famiglia Boncompagni-Ludovisi
Il criterio che fu seguito nell'ordinamento dell'Archivio fu essenzialmente quello topografico. Un più antico documento prevedeva una suddivisione del materiale per armadi, ma prevalse successivamente l'inventariazione con numero di protocollo. Tuttavia - come osserva il Pagano - attualmente mancano diversi numeri di protocollo e ci sono volumi privi di una precisa segnatura. Ricordiamo, inoltre, che è conservato tuttora un "Inventario dell'archivio esistente nel palazzo ducale dello Stato di Sora appartenente a S. E. D. Antonio Boncompagni Ludovisi, principe di Piombino". Quest'inventario è datato al 10 giugno 1721*.
La parte maggiore del materiale archivistico necessario per studi specifici su Isola del Liri è naturalmente compreso nella documentazione a carattere generale riguardante il Ducato di Sora. Noi qui indichiamo solo quelle unità archivistiche che si riferiscono in modo specifico ad Isola del Liri.
- Prot. 28, 13. 10 giugno 1573. Vendita della mola di Isola fatta dal Cardinale Giulio della Rovere, duca di Sora, per ducati 1500 a favore di Pietro Leyra. Fascicolo contenente un quaderno e una supplica di Pietro de Leyra (10 marzo 1580)*.
- Prot. 28, 16. "Descrizione in compendio delle rendite dello stato di Sora". Anni 1578-1584. Tra l'altro: Note diverse delle rendite e pesi dello stato di Sora (5 fogli riguardanti le rendite di Isola, Castelluccio, Sora, Arce, Fontana, Brocco)*.
- Prot. 29, 20. "Descritione dello Stato di Sora e suoi confini", attribuibile ad un "officiale" del Vescovado di Sora e databile alla fine del 1579 (vi sono diversi passi che riguardano direttamente vari aspetti di Isola del Liri e del suo territorio)*.
- Prot. 29, 30. "Regie provvisioni riguardanti il diritto di percepire una tassa sul passo per lo stato di Sora e specialmente all'Isola, fino all'abolizione di questo diritto". Anni 1611-1792. Fascicolo contenente quaderni e carte sciolte. Circa ff. 40*.
- Prot. 29, 33. 28 ottobre 1621. "Regia provvisione contro l'Arrendatore di Gaeta per il libero passaggio ed esenzione da ogni dazio sulle lane che si introducono per il lanificio della terra di Isola". Fascicolo contenente carte sciolte, ff. 6*.
- Prot. 29, 40. "Memorie riguardanti la permuta degli stati di Sora, di Aquino, progettata da Ferdinando IV re delle Due Sicilie ad Antonio Boncompagni Ludoviso, duce di Sora e principe di Piombino". Fascicolo di circa ff. 80. Tra l'altro: "Relazione fatta dal regio ingegnere Giovanni Ragozino sopra i corpi speciosi di fabriche, palazzi esistenti in diversi feudi dello stato di Sora e mandata dall'agente di Napoli D. Giovanni Minieri con lettera de' 5 luglio 1796". Si tratta di un inventario dei beni immobili dei dichi di Sora molto interessante per la conoscenza dei palazzi dell'Isola e di Arpino*
- Prot. 40. Isola, parte prima. Cartone contenente 67 fascicoli. Anni 1558-1628. In tutto circa ff. 250 e diverse pergamene notarili. In particolare, Prot. 40, 2 "Instrumentum societatis super exercitio artis lanae in terra Insulae inter D. Meum Nerium et Hippolitum et Aurelium de Ioannellis, a' 28 di novembre 1581 (ff. 12). Sulla industrializzazione nella zona e la fondazione della cartiera lungo il Fibreno (nucleo delle future Cartiere del Liri, poi Cartiere Meridionali) cfr. soprattutto Prot. 30, 1 (con documenti che vanno dal 1519 al 1721) e poi Prot. 31, 65 (per le "valchiere" di Carnello)*.
- Prot. 41. Isola. Parte seconda. Cartone contenente 52 fascicoli. Anni 1631-1803. In tutto circa ff. 300*.
- Prot. 77. Registro di lettere dell'Agente dell'Isola. Anni 1708-1801. Volume di circa ff. 60*
3. L'Archivio Comunale Storico
L'Archivio Comunale Storico di Isola del Liri, comprendente n. 750 unità archivistiche, è stato suddiviso in diverse sezioni. La prima si riferisce al periodo preunitario, dal 1806 al 1860, e consiste in 79 unità (disposte in serie chiusa), delle quali 77 sono rappresentate da registri e registrazioni (Pre/Reg. 1-76), mentre del carteggio restano solo due buste (o cartoni) con relativi fascicoli (Pre/77-78/B.1-2).
La seconda sezione, quella più ampia e più articolata, comprende n. 571 unità archivistiche e si riferisce al periodo unitario (1861-1946) con la massiccia presenza di n. 484 unità relative a registri e registrazioni e di n. 87 buste, tutte impostate in serie aperte. Le schede delle buste presentano frequentemente la distinzione in numerosi fascicoli.
La terza sezione comprende, infine, alcuni Archivi aggregati:
1. Ufficio di Conciliazione, che presenta: Atti Istruttori, Registri e Fogli di Udienze, Sentenze (con materiale che va dal 1889 al 1948 per un totale di n. 8 schede).
2. Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.), con Deliberazioni e Verbali, Protocollo, "Ordini di esigenza", Elenchi di beneficiati, Ruoli riguardanti i diversi tipi di sussidi, interventi vari di assistenza (con materiale archivistico dal 1926 al 1948, per un totale di n. 21 schede).
3. Lascito B. Viscogliosi: 1915-1920 (una sola scheda).
4. Cartiera E. Boimond: libri paga settimanale, libro giornale, libri "manodopera", elenco piante e documentazione relativa ad opere murarie, rubrica alfabetica (materiale archivistico dal 1937 al 1960, per un totale di n. 70 schede)*.
a) Il periodo preunitario
Dal momento della permuta del Ducato di Sora (1796) per alcuni anni, non vi è più per Isola del Liri un nucleo archivistico centralizzato* e in realtà l'Archivio Storico del Comune di Isola inizia nel 1806 durante il Regno di Giuseppe Bonaparte.
Già nel 1788 per motivi di ordine pubblico si era pensato di sostituire l'assemblea popolare prevista dagli antichi Statuti con un Consiglio ristretto composto da 30 cittadini (10 del ceto civile, 10 del ceto degli artisti, 10 del ceto dei massari) e detto decurionato, ma tale proposta non fu allora realizzata e quindi giunse ad attuazione solo sotto il governo di Giuseppe Bonaparte *. Con una legge del 18 ottobre 1806 si riformarono infatti gli Statuti Municipali e in particolare i corpi rappresentativi delle Università furono allora uniformemene designati con il nome di Decurionati. I decurioni dovevano essere 10 nei Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti ed erano estratti a sorte tra i proprietari che avessero una rendita minima di 24 ducati. Importante innovazione era quella che almeno un terzo dei decurioni dovesse saper leggere e scrivere*.
Rileviamo che ad Isola non solo quasi tutti i decurioni erano in grado di firmare, ma fra di loro vi fu un'alternanza nel ricoprire la carica di Sindaco. Quindi essi potevano occuparsi adeguatamente dei vari problemi riguardanti il paese.
Con lettera del 7 marzo 1807* il Sottointendente del Distretto comunicava al Sindaco dell'Isola che non poteva "accordare il permesso di riunirsi al decurionato, e concludere in numero inferiore di due terzi del corpo". Questo intervento fa comprendere che non sempre era facile distogliere un certo numero di persone dalle loro occupazioni, perché attendessero agli affari pubblici.
Nell'archivio di Isola del Liri, i Registri delle Deliberazioni del Decurionato coprono uno spazio che va dal 30/11/1806 al 24 luglio 1861. In genere presentano una numerazione in "fogli" o "pagine". In tutti i volumi il dorso è in pergamena. dal 15/4/1830 la registrazione dei volumi è eseguita dall'Intendenza di Terra di Lavoro, mentre in precedenza risultano registrazioni della Sottointendenza di Sora e dell'Intendenza della Provincia. Ricordiamo che l'assetto amministrativo e l'organizzazione territoriale del Regno erano state stabilite con la legge dell'8/8/1806 "Divisione del territorio. Amministrazione provinciale. Distretti. Università", a cui si ispirò la successiva legge del 12-12-1815*.
Isola faceva parte della provincia Terra di Lavoro che comprendeva quattro distretti (Sora, Capua, Nola e Gaeta). A sua volta il distretto di Sora era composto da 10 circondari: Sora, Arpino, Alvito, Atina, Arce, Roccasecca, San Germano (oggi Cassino), Cervaro, Venafro e Colli al Volturno). Nel circondario di Sora vi erano 39 comuni con 132.879 abitanti. Il capoluogo della provincia di Terra di Lavoro fu prima Capua e poi Caserta. La provincia era retta da un Intendente (poi chiamato Prefetto), mentre in ogni Distretto risiedeva un Sottointendente (poi Sottoprefetto)*.
Isola, nel 1858, risultava comune di seconda classe appartenente al Distretto, Circondario e Diocesi di Sora. Dipendeva dai tribunali criminale e civile, che avevano sede in Santa Maria e dalla Gran Corte di Napoli. Era sede di una dogana per dazi indiretti e vi risiedeva un Ufficiale comandante la Gendarmeria Reale. Aveva, inoltre, per il servizio delle poste una valigia particolare. Nello stesso anno a Castelluccio il Monte Frumentario (fondato nel 1750) conteneva 4.179 tomoli di grano e 1550 tomoli di frumentone*.
Ben documentate sono le serie degli Atti dello Stato Civile relativi alle nascite ed ai matrimoni. Anche in questo campo furono i Francesi a mettere ordine. Fu appunto nel 1808 che la registrazione dei nati, dei matrimoni e dei morti passò dalle parrocchie ai Comuni, che furono obbligati "ad impostare con il massimo ordine i registri dello Stato Civile"*. Ad Isola del Liri, la serie dei registri delle nascite va dal 1811 al 1860, ma presenta dei vuoti (1815-1818, 1820, 1829). I registri contengono indicazioni sul battesimo e quasi sempre sono forniti di tavole alfabetiche. Dal 1846 si cominciano a distinguere, fra le nascite con registrazione a parte, quelle degi esposti e dei nati all'estero.
Per il 1-10-1850 è riportato su un registro autonomo un atto di nascita di un'esposta.
La serie dei matrimoni inizia dal 1809 e giunge sino al 1860. I vuoti qui riguardano solo gli anni 1811-1812. Troviamo ancora tavole alfabetiche e dorso in pergamena. Per il 12-3-1854 vi è la trascrizione in un registro autonomo di un matrimonio celebrato all'estero e da questa data in poi si cominciano ad indicare separatamente nei registri i matrimoni celebrati all'estero. Si rileva che per il Preunitario non è stata rintracciata la serie relativa alle morti.
Per quanto riguarda le buste, il materiale del preunitario, molto limitato, riveste tuttavia una certa importanza. La relativa documentazione si riferisce ai lavori pubblici. In Pre/78B 2 (fasc. 4) è conservato l'interessante "Progetto di perfezionamento del Camposanto" del Comune di Isola del Liri del 1842 e 1847 e nei fascicoli 5-7 vi sono i documenti delgi interventi comunali riguardanti strade e riparazioni all'osteria (anni 1851-1855). Nei fascicoli 1-3 è raccolto il voluminoso incartamento della "Causa Manna" (1834-1839).
b) Il periodo unitario
Registri e registrazioni
Nella sezione dell'Amministrazione, nella serie 1°, le Deliberazioni del Consiglio Comunale (regg. 1-11), proseguono praticamente la serie preunitaria delle Deliberazioni del Decurionato. Vi sono alcuni vuoti per questi periodi: dal 25-7-1861 al 9-5-1863; dal 15-10-1916 al 4-10-1920. Nel reg. 11 sono comprese anche Deliberazioni del Podestà (dal 24-4-1927 al 27-7-1928). La serie, dopo l'interruzione fascista, riprende con il reg. 12 (dal 14-4-1946 al 13-10-1947). Sino al 1898 si fa ancora uso di dorsi in pergamena. Nella serie seconda sono compresi i registri di Deliberazioni della Giunta Municipale, con un vuoto dal 27-10-1915 al 15-10-1920, e la ripresa, dopo il fascismo, dal 9-9-1944 (dal 28-8-1944 Deliberazioni del Sindaco). Qui si usa il dorso in pergamena sin dal 1904. La serie terza comprende le Deliberazioni del Delegato Civile (dal 14-10-1916 al 4-10-1920) e le Deliberazioni del Podestà (vedi sopra Serie prima, Reg. 11) dal 1-8-1928 al 4-9-1943.
Sono poi presenti sempre per l'Amministrazione, Liste elettorali e verbali della Commissione Elettorale (serie 4°-5°), mentre la serie 6°, riguardante il Protocollo, presenta solo i Registri che vanno dal 1944 al 1946, per cui si può constatatre in questo settore una perdita notevole per l'Archivio Comunale Storico. Le serie 7°-8° si riferiscono al personale, con un elenco di salariati e impiegati e prospetti e ruoli di stipendi e salari.
Nella sezione della Sanità ed Igiene è compreso il Regolamento municipale di igiene del 19-5-1938. In quella delle Finanze e Contabilità, bilanci di previsione, conti consuntivi, libri mastri, giornali di cassa, mandati, ruoli e verifiche di cassa sono rappresentati da un esiguo numero di registri. Significativi, invece, per il Demanio Comunale, sono due registri (anni dal 1882 al 1886), con "verbali di campagna" non accettati e, per le proprietà comunali, gli atti di incanto per la vendita di legname del bosco di Selvagrande (1886).
Per la sezione "Leva e truppa" le liste di leva vanno dal 1906 al 1946 senza vuoti anche se con incertezze per la datazione di alcune registrazioni. Per le liste dei renitenti, la serie va dal 1924 al 1946, ma mancano gli anni 1933, 1937-1938. Dal 1932 sono presenti con qualche vuoto liste di leva di riformati; dal 1939 liste di leva di renitenti residenti all'estero. Per la leva di mare vi è una sola lista, quella del 1928. Al 1939-1940 risalgono elenchi di rivedibili e rimandati. Per il periodo bellico (1942-1945) e per il 1946, vi sono registri di sussidi per i congiunti dei militari, mentre un registro (1935-1964) riguarda i pensionati di guerra.
Per quanto si riferisce ai Lavori pubblici, si segnalano elenchi di strade comunali, fra i quali interessante particolarmente uno del 1866. Un altro elenco è quello dei Consumatori di energia elettrica, mentre è conservato un registro di deliberazioni della Commissione edilizia comunale (dal 25-8-1946 al 28-8-1953). In un'altra serie, altri quattro registri di deliberazioni riguardano la Commissione Comunale per la disciplina del commercio e vanno dal 21-9-1928 al 14-11-1946 (e sino al 9-4-1976).
Per lo Stato Civile i registri degli atti di nascita sono datati dal 1861 al 1946 (senza vuoti). Sino al 1865 hanno ancora il dorso in pergamena. A parte, citiamo alcuni registri di nascita di esposti (serie 31°) e indici alfabetici di nascita (serie 32°). Per gli atti di matrimonio si inizia dal 1862 (per il 1861, vedi Pre/reg. 76) sino al 1946, con mancanze per gli anni 1882-1885. Nei registri è riportata sino al 1866 l'indicazione della "Celebrazione cattolica". Il dorso in pergamena è riscontrabile sino al 1869 (ma ricompare dal 1911 al 1917). Citiamo, inoltre, (nella serie 34°), alcuni indici alfabetici di atti di matrimonio. Con la serie successiva, che non presenta però precedenti nel Preunitario, hanno inizio i registri degli atti di morte, che vanno dal 1889 al 1937. Le mancanze riguardano, oltre al periodo 1938-1946, gli anni 1890-1892. Si nota il dorso in pergamena dal 1938 al 1908; nel 1912 e dal 1925 in poi. Anche qui vi sono degli indici alfabetici (serie 33°). La serie seguente (37°) si riferisci alla edichiarazioni di cittadinanza. Va dal 1866 al 1945 con frequenti mancanze (1867, 1874, 1880-1886, 1903, 1909-1913, 1917, 1920, 1922, 1938, 1941, 1944).
Nella serie 39° vi è un registro di dichiarazioni di trasferimento di residenza. Citiamo ancora un registro di popolazione e un altro rguardante pratiche di emigrazione (1944-1947).
Buste (carteggio)
Nella Serie A (Amministrazione) è raccolto il carteggio che si riferisce al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori, al Segretario Comunale ed al personale dipendente; alle retribuzioni dei dipendenti e all'assistenza che li riguarda, ai locali per gli uffici, alle deliberazioni del Podestà. Interessante la busta Unit./B. A 13 con incartamenti relativi alla "causa Viscogliosi", alla "Causa Albini", alla "Causa Montefusco".
Nella serie B (Opere pie e beneficenza) si evidenziano le diverse forme assistenzali realizzate dal Comune (sussidi a reduci, a partigiani, ad orfani di guerra; ristoranti popolari, distribuzione di generi vari, contributi per "spedalità", assistenza postbellica; brefotrofi, orfanotrofi, ecc.; consultori, refettori materni, ecc.) ed ai rapporti con enti assistenziali.
Nella serie C, il carteggio riguarda il personale sanitario, consorzi sanitari e veterinari; farmacie e ambulatori, ecc.; il mattatoio. Particolare rilievo assume la busta Unit./B.C 6 avente come oggetto il cimitero e le sue condizioni per la presenza di una planimetria generale risalente al 1922-1927.
Per la serie D (Finanza) distinguiamo un inventario dei beni comunali del 1870, le pratiche relative ai boschi comunali, ai fabbricati di proprietà del Comune, alle baracche e case asismiche, al Teatro Comunale, alla Colonia Elioterapica e poi agli usi civici, canoni, ecc. Vi è poi la parte riguardante la contabilità (fatture, bilanci), tasse e imposte, mutui, servizi di esattoria. La busta Unit./B. D 8 contiene carteggio relativo al Catasto.
Molto limitato è il carteggio della successiva serie E (Governo).
La serie F (Leva e truppa) presenta corrispondenza relativa alle operazioni di leva, una busta per il "Tiro a segno" ed una sezione paricolarmente interessante che riguarda le vicende della seconda guerra mondiale (Unit./B. F 5, F6, F7). Dopo le pratiche per le salme dei caduti in guerra (Unit./B. F5, fasc. 1) e per gli infortunati civili di guerra (idem, fasc. 2), seguono quelle relative alla corrispondenza specifica degli anni 1943-1944 (idem, fasc. 3), un elenco delle offese belliche (idem, fasc. 4. In Unit./B. F5, fasc. 5 si parla del rastrellamento di materiale bellico; nel fasc. 6 della stessa busta di distruzioni belliche. Altri fascicoli riguardano i prigionieri di guerra, le vittime politiche, i danni di guerra, una relazione statistica di danni di guerra.
Per la serie G (Istruzione pubblica), citiamo fra gli altri fascicoli riguardanti la Scuola "industriale", la scuola di avviamento professionale, la scuola elementare. l'asilo infantile e il corso popolare di insegnamento, l'edificio scolastico urbano, gli edifici scolastici rurali ed infine la protezione di monumenti nazionali.
La sezione dei lavori pubblici (H) è senz'altro la più ampia nel carteggio dell'archivio con materiale di grande interesse.
Citiamo per i lavori stradali il progetto per la strada rotabile da Isola alla Selva (1882) con gli altri interventi successivi, l'ampliamento di via Roma (1862), interventi per la strada Isola-Casamari (1873-1879 e 1918-1919), per strade urbane (1881), per il largario del ponte di Napoli (1889), per la via Carnello (1892), per la via dalla piazza San Lorenzo al ponte di Roma (1896), per la strada in Isola Superiore (1914), per la strada verso Sora (1916-1919), per le strade comnali danneggiate dal terremoto (1917), per la strada Stazione Isola Liri-Arpino (1919); per la strada di Capitino (1934-1941).
Per le costruzioni, ricordiamo gli interventi per le baracche e le case popolari, per demolizione di fabbricati, per la costruzione di un ponticello nella strada Isola-Casamari (1918), per il Ponte di Napoli (1874), per il Ponte di Roma (1888, 1934, 1937 e 1939), per il Palazzo Comunale e il Cimiterio (ossario) ed il progetto per l'edificio dell'ospedale. Ugualmente notevole la sezione delle concessioni e derivazioni di acque ed in genere delle opere sulle sponde del fiume Liri (con relative vertenze). Vi si parla anche degli acquedotti (in Unit./B. H11, il fasc. 25 è riservato ai danni apportati dal terremoto all'acquedotto municipale), delle fontane, dei lavatoi, dei canali e delle fogne. Il fasc. 24 della busta sopra citata comprende il carteggio riferibile all'alluvione del 1925 ed allo straripamento del fiume Fibreno. Nella stessa serie molte pratiche riguardano espropriazioni e contravvenzioni. Seguono i fascicoli dei servizi postali, telefonici, telegrafici e automobilistici e il progetto per una "tranvia" Frosinone-Piperno-Sora.
Nella serie I, vi sono pratiche relative all'agricoltura (trebbiatura, macinazione e trasporto dei cereali, campagne olearie, contratti agrari, censimento agricolo, Commissione agricola comunale, proprietari agricoli), all'allevamento (macellazioni suini), alle industrie, all'artigianato ed al commercio.
La serie L presenta carteggio relativo allo Stato Civile.
Nella serie N (Calamità, Sicurezza pubblica) una buona parte è occupata da fascicoli con le pratiche riguardanti la concessione di casette asismiche (in seguito al terremoto del 1915), di case economiche e popolari.
Poi si parla di incolumità pubblica, di armi e munizioni, di spettacoli teatrali, di esercizi pubblici, di sfollati.
Fuori catalogo, sono raccolti alcuni manifesti del 1906-1907.
4. Interventi di sistemazione. Cenni di metodologia archivistica
La considerazione in cui l'Archivio di Isola era tenuto nel primo cinquantennio del socolo scorso è evidenziata dal fatto che il Segretario Comunale era allora designato con la qualifica di Cancelliere Archiviario. Dalle Deiberazioni del "Decurionato" risulta che alla morte del precedente Cancelliere Archiviario fu nominato a suo successore nel 1839, Don Francesco Lombardi, il quale a sua volta, fusostituito nell'incarico da Don Giacomo Campoli nel 1852 (Pre/reg. 4. pp. 150-151 e Pre./reg. 6, pp. 170 sgg. e 186v). Sappiamo anche che si procedeva alla nomina del Cancelliere scegliendo in una terna di nomi proposti (Pre/reg. 4 pp. 150-151). In data 9 aprile 1839, il Decurionato in una sua riunione propose per il citato Don Francesco Lombardi una "gratificazione di D(uca)ti venti e g(ran)a venti ... per supplire alla minorazione del suo soldo", che era stata disposta "giusta gli ultimi regolamenti, in proporzione della consistenza numerica della popolazione.
La gratificazione gli era corrisposta "visto l'esatto adempimento dei suoi doveri" (Pre/reg. 4 pp. 113/114). Di un altro aumento "di soldo al cancelliere Archiviario" si ha notizia in data 23 novembre 1839 (Pre/reg. 4 pp. 154-155) e sempre del suo stipendio si trattò in altra riunione del 31 dicembre 1844 (Pre/reg. 4 p. 138). Per la nomina del Cancelliere sostituto, la valutazione delle capacità e delle qualità del candidato, il 21 maggio 1839, è così espressa: "... è un giovane onesto, ed esatto, e convenientemente istruito, e che fra l'altre circostanze vi è quella di avere un buon carattere" (Pre/reg. 4 pp. 117-118).
Gli interventi che dovettero contrassegnare la nascita e lo sviluppo dell'Archivio Comunale Storico di Isola sono desumibili dalla cura con cui vediamo raccolti gli atti dello Stato Civile, che furono rilegati con dorso in pergamena indiverse riprese. In generale, i registri degli atti di nascita e di matrimonio furono rilegati presumibilmente nel decennio 1860-1870, mentre per i Registri delle Deliberazioni questo tipo di rilegatura è attuato sino al 1898. Per gli atti di morte si è fatto ricorso al dorso in pergamena anche per epoche più recenti (dal 1925 in poi).
Un altro intervento di sistemazione si può dedurre dalla presenza di un consistente numero di cartelle color avana con targhette esplicative sul dorso. Tali cartelle entrarono in uso, per un limitato periodo di tempo, nell'immediato dopoguerra ed esse furono impiegate per ordinare il carteggio di epoca precedente. Presumibilmente, fu in questo modo riorganizzato ciò che restava dell'Archivio Comunale, dopo le vicende belliche che avevano provocato gravissimi danni.
E' quanto sappiamo da un'accorata lettera dell'allora Commissario T. Patrizi del 28 gennaio 1944, inviata alla "Eccellenza Capo della Provincia", con oggetto "Saccheggi Uffici Comunali". Il Capo della Provincia aveva allora la sua sede provvisoria a Fiuggi.
Riportiamo di seguito il testo della lettera: "Compio il dovere di segnalare a V.E. che gli edifici comunali, da tempo evacuati per i danni subuti dai continui bombardamenti aerei a cui è stato oggetto questo comune, sono stati oggetto in questi ultimi giorni (dì) ripetuti saccheggi da parte di truppe tedesche che hanno asportato tutti i mobili ivi esistenti. Di tutti gli atti di ufficio e di archvio non resta che un mucchio informe di carte per cui si rende pressoché impossibile ogni rintraccio di pratiche e di documenti. Uguale sorte hanno subito le scuole in genere ove sono stati asportati e distrutti mobili e suppellettili. Tanto rassegno a V.E. anche a scanso di eventuali responsabilità di cui mi si potesse fare addebito non senza far presente che tali saccheggi sono stati operati mediante scassinamenti delle porte di accesso a vari uffici e senza che si fossero potuto (sic) comunque impedire".
Un successivo saccheggio del Municipio avvenne il 23 maggio 1944, quando già le truppe tedesche si preparavano per la ritirata. Dal Palazzo Comunale, rimasto senza porte, furono sottratti il busto in bronzo di Giustiniano Nicolucci, il gonfalone di Isola e altri oggetti*.
Malgrado il tono pessimista della lettera del Patrizi, non ci risulta tuttavia che la distruzione dell'Archivio sia stata così radicale e si può comprendere dal materiale archivistico rimasto quali siano stati i settori più duramente colpiti. Fra le altre dolorose perdite, ricordiamo, per il preunitario il carteggio quasi intero e la serie degli atti di morte.
Successivamente hanno influito negativamente sull'Archivio Comunale i ripetuti eventi sismici. Non siamo abbastanza informati a questo riguardo suquanto avvenuto in occasione del terremoto della Marsica del 1915, ma siamo in grado di riferire sulle ripercussioni delle scosse sismiche dell'8 e 11 maggio 1984.
L'edificio del Comune fu lesionato e si rese necessario un rapido trasferimento del materiale archivistico dagli ambienti pericolanti.
In seguito a tali spostamenti, pratiche e registri in gran parte furono stipati in due locali e, non essendo sufficienti gli scaffali, si fu costretti ad accatastare in terra tutto il materiale senza più avere la possibilità di mantenere un qualsiasi criterio di sistemazione.
Questa è stata la situazione di partenza per il nostro lavoro, che abbiamo potuto gradualmente svolgere grazie anche alla collaborazione e alla viva sollecitudine con cui ci hanno seguito l'allora sindaco geom. Ezio Bartolomucci, l'attuale sindaco Ing. Flavio Gabriele ed il Segretario comunale dott. Aldo Gentilucci.
Nella prima fase del nostro intervento si è proceduto a individuare il materiale inquadrabile nell'Archivio Storico (dalle origini sino al 1946), che era peraltro mescolato con quello di epoca successiva e disperso in diversi locali del Palazzo Comunale. Il materiale è stato quindi da noi trasferito nell'ambiente che ci era stato assegnato per l'esame dei documenti.
Dopo una preliminare suddivisione tra Registri e Carteggio è quindi iniziata la fase della schedatura, attuata con il sistema del riscontro provvisorio con le diverse unità archivistiche. Il materiale documentario è stato esaminato per quanto riguarda la sua possibile collocazione archivistica ed abbiamo contemporaneamente osservato con attenzione, per il carteggio, le eventuali indicazioni di titolario. Tutti gli estremi utili per l'identificazione di ogni unità archivistica (oggetto, data, ecc.) sono stati riportati su schede provvisorie con numero provvisorio.
Abbiamo notato che in genere sui documenti, anche quando era impresso il timbro di protocollo, quasi mai eano segnati gli estremi del titolario. Talvolta si rilevava, invece, per anni più recenti, l'indicazione con matita rossa e blu, della categoria e della classe. Questa indicazione appariva in diversi casi apposta in periodo posteriore a quello della produzione del documento ed evidentemente era stata applicata in occasione dii nterventi più o meno estesi di riordinamento. Anche sui contenitori e sulle copertine spesso erano riportati gli estremi delle categorie e delle classi.
In generale, le indicazioni rilevate riguardavano costantemente il titolario modello attualmente in uso. Solo in alcuni casi erano eccezionalmente segnati dei dati di un diverso titolario che evidentemente era stato usato in precedenza. Si tratta tuttavia di elementi sporadici che non ci permettono di ricostruire neppure in minima parte il titolario precedente.
Segnaliamo, comunque, le difformità rilevate, che si riferiscono esclusivamente alla Serie del Lavori Pubblici e in particolare alle concessioni di acque.
1) Unit./H9, Fasc. 2, 1867-1897, Fiume Liri: derivazione chiesta da P. Nicola Masi. Documento protocollato il 29-4-1895, Cat. XXIV, Fasc. 7.
2) Idem. Documento protocollato il 1-9-1896, Cat. XIII, Fasc. 10.
3) Unit./H9, Fasc. 7, 1873-1897, Innovazione sul Liri fatta da L. Mazzetti. Documento protocollato il 12-12-1893, Cat. XII, Fasc. 9.
4) Unit./H9, Fasc. 18, 1895, Derivazione Manna-Viscogliosi. Documento protocollato il 20-4-1895, Cat. XIII, Fasc. 9.
5) Idem. Documento protocollato l' 11-4-1895, Cat. XIII, Fasc. 9.
Quanto da noi rilevato comporta il fattoche per lo meno sino al 1895 (qui è documentato il periodo 1893-1895) era in uso nel Comune di Isola del Liri un titolario del quale ci risultano sino a ventiquattro categorie.
Terminate le operazioni di schedatura, si è provveduto all'"accostamento". Si sono individuati, innanzitutto, i due periodi del Preunitario e dell'Unitario e inoltre si sono enucleati i diversi Archivi aggregati. Era a tal punto necessario procedere alla suddivisione archivistica del materiale schedato.
Per il Preunitario si è ritenuto di dover suddividere i molti registri ed il limitato carteggio "per uffici", seguendo validi suggerimenti forniti in proposito dalla bibliografia specializzata*. Nelle diverse sezioni così costituite, le unità archivistiche sono state contrassegnate da una numerazione progressiva in serie unica "chiusa".
Per l'Unitario i Registri sono stati suddivisi per materia in serie aperte, seguendo all'interno di ogni serie l'ordine cronologico. Si precisa che le serie aperte sono necessarie, dovendosi prevedere le future accessioni archivistiche (dal 1947 in poi). Per il carteggio, l'unica strada da seguire, in base al materiale presente era quella di applicare , con una certa elasticità e solo come filone di riferimento, il sistema di catalogazione per categorie.
Partendo infatti dalla constatazione che non tutte le categorie sono presenti nell'Archivio Storico e che ad una parte del materiale non sono state apposte indicazioni archivistiche, abbiamo anche qui creato un sistema di serie aperte.
In realtà, mentre nei grandi archivi è possibile una catalogazione per classi, nel nostro caso, riteniamo che non sia possibile una simile suddivisione, che provocherebbe un eccesivo frazionamento del materiale. Gli inserimenti di documenti successivi al 1946 potranno avvenire in modo automatico per le serie già costituite. Per quelle mancanti sarà opportuno ricorrere a lettere minuscole dell'alfabeto (es. a, a1, a2, ecc.; b, b1, b2, ecc.).
Le operazioni riferentesi all'inventario hanno portato ordine nella materia, creando un'organicità di successioni, razionalizzando le suddivisioni interne dei fascicoli, eliminando le inevitabili sfasature, programmando una nomenclatura e una numerazione che rendesse facilmente consultabile il materiale archivistico.
Per il Preunitario, ogni "unità" è stata contrassegnata dalla sigla Pre. Per i Registri, è stata applicata la sigla Reg. poi il numero progressivo (es. Pre/Reg. 35); per il carteggio il numero progressivo, la sigla B, con l'indicazione della successione delle Buste (es. Pre/77, B2).
Per l'Unitario si è impiegata la sigla Unit. Segue il numero "romano" di serie, la sigla Reg., il numero interno della serie (es.: Unit./XVI/Reg. 3)
Per il carteggio, si precisa la serie (con lettere maiuscole), la numerazione interna della serie, il fascicolo (es.: Unit./C 2/fasc. 6). Per gli Archivi aggregati si è attuata, per ognuno di essi, una numerazione progressiva.
Le indicazioni d'archivio presenti nell'inventario generale (ora pubblicato) sono state riportate sia sullo schedario consultabile nei locali dell'Archivio Storico Comunale, sia sulle stesse unità archivistiche (e sui fascicoli).
Auspichiamo che per una corretta conservazione della documentazione ora riordinata, non si effettuino, per alcun motivo, prestiti di registri o documenti e si istituisca un registro dal quale dovranno risultare eventuali movimenti all'interno degli Uffici Comunali con firma di responsabilità di chi preleva un documento e con la data del prelievo e dell'altra di restituzione. Si dovrà inoltre fissare il termine improrogabile entro il quale registri e documenti dovranno essere riconsegnati. Si auspica, inoltre, che tutta la documentazione possa essere messa a disposizione degli studiosi e sia quindi consultabile nei locali dell'Archivio Storico (con il controllo dell'addetto comunale).
N.B. Si fa presente che attualmente una parte del materiale dell'Archivio Storico (essenzialmente registri di Deliberazioni e dello Stato Civile) si trova dislocata in diversi uffici comunali. Suggeriamo a questo proposito che i Registri, per i quali non sia strettamente necessaria, per motivi di continua consultazione, una tale sistemazione, siano ricollocati nella loro sede naturale
Comune di Isola del Liri
Amministrazione*
Deliberazioni del Decurionato
|
|
| |
Parte I: dal 30-11-1806 al 18-3-1808; fogli n° 113
Parte II: dall'1-3-1808 al 13-11-1817; fogli n° 170
Parte III: dal 7-12-1817 al 19-12-1819; fogli n° 40
Parte IV: dal 13-12-1820 al 5-3-1826; fogli n° 162
Dorso in pergamena - Condizioni buone
Note: sottoscrivono il Sindaco Presidente e i decurioni, registra la Sottointendenza di Sora
| 30-11-1806/5-3-1826 |
|
|
| |
Fogli n° 150
Dorso in pergamena - Condizioni buone
Note: sottoscrivono il Sindaco e i decurioni; registra la Sottointendenza di Sora
| 22-11-1823/4-4-1830 |
|
|
| |
Dorso in pergamena - Condizioni buone
Note: sottoscrivono il Sindaco presidente ed i decurioni, registra l'Intendenza di Terra di Lavoro
| 15-4-1830/16-8-1832 |
|
|
| |
Parte I: dal 18-8-1832 al 7-8-1837; fogli n° 184
Parte II: dall'7-8-1837 al 16-3-1840; fogli n° 188
Parte III: dal 5-4-1840 al 5-7-1846; fogli n° 188
Dorso in pergamena - Condizioni buone
Note: sottoscrivono il Sindaco Presidente e i Decurioni, registra l'Intendenza di Terra di Lavoro
| 18-8-1832/5-7-1846 |
|
|
| |
Pagine n° 238
Dorso in pergamena - Condizioni molto buone
Note: sottoscrivono il Sindaco ed i Decurioni, registra l'Intendenza di Terra di Lavoro
| 9-8-1846/29-4-1849 |
|
|
| |
Fogli n° 209
Dorso in pergamena - Condizioni molto buone
Note: sottoscrivono il Sindaco ed i Decurioni, registra l'Intendenza di Terra di Lavoro
| 29-4-1849/2-6-1853 |
|
|
| |
Pagine n° 190
Dorso in pergamena - Condizioni molto buone
Note: sottoscrivono il Sindaco e i Decurioni, registra l'Intendenza di Terra di Lavoro
| 28-6-1853/4-9-1857 |
|
|
| |
Pagine n° 243 + 119 + 38.
Dorso in pergamena - Condizioni molto buone
Note: sottoscrivono il Sindaco ed i Decurioni, registra l'Intendenza di Terra di Lavoro
| 13-9-1857/30-12-1860
(e sino al 24/7/1861)
|
Contabilità*
Cautele
|
|
| |
I Parte deI ruolo delle Cautele - Conto materiale
Condizioni buone
| 1845 |
Atti dello Stato civile*
Nascite
|
|
| |
1811 atti n° 90; 1812 atti n° 92 - Con tavola dei nati del 1811 e rubrica alfabetica
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1811-1812 |
|
|
| |
Atti n° 159 - Con indicazioni sul battesimo, rubrica alfabetica
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1813-1814 |
|
|
| |
|
Atti n° 1 - Idem
| 1813-1814 |
|
|
| |
Atti n° 90 - Con indicazioni sul battesimo
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1821 |
|
|
| |
Atti n° 133 - Con indicazioni sul battesimo e tavola alfabetica
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1826 |
|
|
| |
Atti n° 118 - Con indicazioni sul battesimo
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1827 |
|
|
| |
Atti n° 118 - Con indicazioni sul battesimo e con tavola alfabetica
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1830 |
|
|
| |
Atti n° 122 - Con indicazioni sul battesimo e con tavola alfabetica
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1831 |
|
|
| |
Atti n° 109 + 35 - Idem
| 1839 |
|
|
| |
Atti n° 120 + 9 - Idem
| 1840 |
|
|
| |
Atti n° 140 + 17 - Con indicazioni sul battesimo e due tavole alfabetiche
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1846 |
|
|
| |
Atti n° 135 - Con indicazioni sul battesimo e tavola alfabetica
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1847 |
|
|
| |
Atti n° 140 + 12 + 2 - Idem
| 1848 |
|
|
| |
Atti n° 140 + 22 - Con indicazioni sul battesimo e tavola alfabetica
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1849 |
|
|
| |
Atti n° 140 + 24 + 3 - Idem
| 1850 |
|
|
| |
Atti n° 140 + 40 + 22 - Idem
| 1851 |
|
|
| |
Atti n° 170 + 8 - Idem
| 1852 |
|
|
| |
Atti n° 160 + 6 - Con indicazioni sul battesimo e due tavole alfabetiche
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1855 |
|
|
| |
Atti n° 160 + 18 - Idem
| 1856 |
|
|
| |
Atti n° 140 + 38 - Idem
| 1857 |
|
|
| |
Atti n° 160 + 47 - Con indicazioni sul battesimo e tavola alfabetica
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1859 |
|
|
| |
Atto di nascita di un'esposta
Condizioni buone
| 1-10-1859 |
|
|
| |
Atti n° 148 + 41 - Con indicazioni sul battesimo e tavola alfabetica
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1860 |
Matrimoni
|
|
| |
1809 atti n° 13 con tavola alfabetica - 1810 atti n° 26
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1809-1810 |
|
|
| |
1813 atti n° 20; 1814 atti n° 31; 1815 atti n° 6; 1816 atti n° 2; 1817 atti n° 6;
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1813-1817 |
|
|
| |
1818 atti n° 9; 1819 atti n° 52 - Idem
| 1818-1819 |
|
|
| |
1820 atti n° 18; 1821 atti n° 5 - Idem
| 1820-1821 |
|
|
| |
1822 atti n° 22; 1823 atti n° 23 - Idem
| 1822-1823 |
|
|
| |
1824 atti n° 16; 1825 atti n° 28 - Idem
| 1824-1825 |
|
|
| |
1826 atti n° 16; 1827 atti n° 10 - Con due tavole alfabetiche
| 1826-1827 |
|
|
| |
1828 atti n° 9; 1829 atti n° 14 - Idem
| 1828-1829 |
|
|
| |
1830 atti n° 21; 1831 atti n° 12 - Idem
| 1830-1831 |
|
|
| |
1832 atti n° 11; 1833 atti n° 19 - Idem
| 1832-1833 |
|
|
| |
1834 atti n° 19; 1835 atti n° 22 - Idem
| 1834-1835 |
|
|
| |
1836 atti n° 19; 1837 atti n° 19 - Idem
| 1836-1837 |
|
|
| |
1838 atti n° 45; 1839 atti n° 19 - Idem
| 1838-1839 |
|
|
| |
1840 atti n° 18; 1841 atti n° 6 - Idem
| 1840-1841 |
|
|
| |
1842 atti n° 20; 1843 atti n° 32 - Idem
| 1842-1843 |
|
|
| |
1844 atti n° 24; 1845 atti n° 32 - Idem
| 1844-1845 |
|
|
| |
1846 atti n° 24; 1847 atti n° 25 - Idem
| 1846-1847 |
|
|
| |
1848 atti n° 31; 1849 atti n° 26 - Idem
| 1848-1849 |
|
|
| |
1850 atti n° 26 + 4; 1851 atti n° 36 + 6 - Idem
| 1850-1851 |
|
|
| |
1852 atti n° 26; 1853 atti n° 30 - Idem
| 1852-1853 |
|
|
| |
Atto n° 1 - Trascrizione di un matrimonio celebrato all'estero
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1818-1819 |
|
|
| |
1854 atti n° 17 + 1 (allegato); 1855 atti n° 30 - Con due tavole alfabetiche
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1854-1855 |
|
|
| |
1856 atti n° 30 + 6; 1857 atti n° 29 - Idem
| 1856-1857 |
|
|
| |
1858 atti n° 28; 1859 atti n° 36 - Idem
| 1858-1859 |
|
|
| |
1860 atti n° 23; 1861 atti n° 32 - Con indicazione della celebrazione cattolica - Tavola alfabetica
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1860-(1861) |
Lavori pubblici*
Edilizia e Viabilità
|
|
Fasc. 1 e 2: Causa "Manna" 1834;
Fasc. 3: Vertenza "Manna" 1839
| |
|
"Cat. X, cl. 1", aggiunto successivamente
| 1834
, 1839 |
|
|
Fasc. 4: Progetto di perfezionamento del Camposanto del Comune di Isola del Liri (1842, 1847);
Fasc. 5: Strade interne (1851)
Fasc. 6: Strada Valcatoio (1851)
Fasc. 7: Accomodi all'osteria (1853)
Fasc. 8: Elenco dei fondi comunali (1855)
| |
|
nel fasc. 5 antico bollo comunale di Isola
| 1842
, 1847
, 1851
, 1853
, 1855 |
Amministrazione*
Serie I - Deliberazioni del Consiglio Comunale*
|
|
| |
Registra l'Intendenza di Terra di Lavoro
Dorso in pergamena - Condizioni buone - Fogli non numerati
| 10-5-1863/12-2-1872 |
|
|
| |
Registra l'Ufficio del Registro di Sora
Dorso in pergamena - Condizioni buone - Fogli n° 145
| 10-5-1867/27-4-1873 |
|
|
| |
|
Dorso in pergamena - Condizioni buone - Fogli non numerati
| 8-5-1873/31-5-1880 |
|
|
| |
|
Idem
| 20-10-1880/31-5-1892 |
|
|
| |
|
Dorso in pergamena - Condizioni buone - Fogli n° 200
| 29-6-1892/23-12-1898 |
|
|
| |
|
Idem - Fogli 207
| 30-1-1899/20-11-1903 |
|
|
| |
|
Condizioni buone - Fogli n° 200
| 28-11-1903/15-12-1907 |
|
|
| |
|
Condizioni mediocri - Restaurato - Fogli non numerati
| marzo 1908/27-12-1915 |
|
|
| |
|
Condizioni buone - Fogli n° 102
| 29-10-1915/14-10-1916 |
|
|
| |
|
Condizioni buone - Fogli non numerati
| 5-10-1920/26-6-1924 |
|
|
| |
Deliberazioni del Consiglio Comunale
Deliberazioni del Podestà -Condizioni buone - Fogli n° 287
| 26-8-1924/16-3-1927
Deliberazioni del Consiglio Comunale
, 20-4-1927/27-7-1928
Deliberazioni del Podestà
|
|
|
| |
|
Condizioni buone - Fogli non numerati
| 14-4-1946/13-10-1947 |
Serie II - Deliberazioni della Giunta Municipale*
|
|
| |
|
Dorso in pergamena - Condizioni molto buone - Fogli n° 102
| 9-2-1862/13-2-1867 |
|
|
| |
|
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 17-2-1867/15-11-1877 |
|
|
| |
|
Dorso in pergamena - Condizioni molto buone - Fogli non numerati
| 15-2-1877/10-5-1884 |
|
|
| |
|
Dorso in pergamena - Condizioni buone - Fogli non numerati
| 30-6-1884/27-9-1893 |
|
|
| |
|
Dorso in pergamena - Condizioni buone - Fogli n° 295
| 12-3-1898/3-5-1904 |
|
|
| |
|
Condizioni buone - Fogli n° 396
| 13-5-1904/27-5-1907 |
|
|
| |
|
Idem - Numerazione per argomenti
| 26-6-1907/31-12-1908 |
|
|
| |
|
Idem - Fogli dal n° 211al 320
| 9-1-1909/27-8-1910 |
|
|
| |
|
Idem - Fogli non numerati
| 12-10-1910/27-3-1913 |
|
|
| |
|
Idem - Fogli n° 200
| 27-3-1913/26-10-1915 |
|
|
| |
|
Idem - Fogli non numerati
| 16-10-1920/5-2-1927 |
|
|
| |
|
Deliberazioni del Sindaco - Deliberazioni della Giunta Comunale - Condizioni buone - Fogli non numerati
| 28-8-1944/6-9-1944
, 9-9-1944/20-12-1946
(e sino al 19-12-1947)
|
Serie III -Deliberazioni del Delegato civile - Deliberazioni del Podestà
|
|
| |
Deliberazioni del Delegato Civile
Condizioni buone - Fogli n° 205
| 14-10-1916/4-10-1920 |
|
|
| |
|
Da qui Deliberazioni del Podestà - Condizioni buone - Fogli n° 199
| 1-8-1928/19-12-1931 |
|
|
| |
|
Condizioni buone - Fogli n° 110
| 31-12-1931/1-8-1933 |
|
|
| |
|
Idem - Pagine n° 396
| 3-8-1933/26-4-1935 |
|
|
| |
|
Idem - Pagine n° 400
| 26-4-1935/6-9-1937 |
|
|
| |
|
Idem - Pagine n° 398
| 8-9-1937/8-11-1938 |
|
|
| |
|
Idem - Pagine n° 378
| 10-11-1938/31-12-1939 |
|
|
| |
|
Idem - Pagine n° 400
| 5-1-1940/2-12-1941 |
|
|
| |
|
Idem - Fogli non numerati
| 22-12-1941/4-9-1943 |
Serie IV - Liste elettorali*
|
|
Elezioni amministrative - Lista aggiuntiva
| |
|
Iscritti n° 28 - Condizioni discrete
| 30-4-1946 |
Serie V - Verbali della Commissione Elettorale
|
|
| |
|
Atti n° 4 + 22 - Condizioni buone
| 18-6-1945/22-5-1946 |
Serie VI - Protocollo*
|
|
| |
1944: dal n° 611 al 2147; 1945:dal n° 1 al 1050
Condizioni molto buone
| 1944-1945 |
|
|
| |
Dal n° 1051 al 4080
Idem
| 1945 |
|
|
| |
1945: dal n° 4081 al 5506; 1946:dal n° 1 al 1400
Idem
| 1945-1946 |
|
|
| |
dal 1401 al n° 7580
Idem
| 1946 |
Serie VII - Elenco degli impiegati e salariati
Serie VIII - Stipendi e salari*
|
|
Prospetto degli stipendi e salari
| |
|
Condizioni buone
| 1923 |
|
|
Stipendi, salari e caro viveri
| |
|
Idem
| 1925 |
|
|
"Tabella", stipendi, salari e caro viveri
| |
|
Idem
| 1926 |
|
|
Ruolo per pagamento di stipendi ed altri assegni
| |
|
Idem
| 1927 |
|
|
Ruolo per pagamento di caro viveri
| |
|
Condizioni buone
| 1930 |
|
|
Ruolo per pagamento di stipendi
| |
|
Idem
| 1930 |
|
|
Ruolo per pagamento di stipendi, salari ed altri assegni
| |
|
Condizioni buone
| 1931 |
|
|
| |
|
Idem
| 1932 (gennaio-aprile) |
|
|
| |
|
Idem
| 1932 (maggio-giugno) |
|
|
Ruolo per pagamento di stipendi, salari ed altri assegni
| |
|
Condizioni buone
| 1932 (luglio-settembre) |
|
|
Prospetto delle modificazioni apportate agli assegni
| |
|
Condizioni buone
| 30-4-1934 |
|
|
Ruolo per pagamento di stipendi, salari ed altri assegni
| |
|
Condizioni buone
| 1934 (maggio) |
Sanità ed Igiene
Serie IX - Regolamento municipale d'igiene
|
|
| |
Con deliberazione allegata
Condizioni buone
| 19-5-1938 |
Finanze e Contabilità
Serie X - Demanio Comunale*
|
|
"Verbali di campagna" non accettati
| |
Vol. 1 - Verbali n° 122
Condizioni buone
| 1882
, 1884
, 1886 |
|
|
Idem
| |
Vol. 2 - Verbali n° 19
Condizioni buone
| 1882
, 1886 |
Serie XI - Proprietà Comunali
|
|
Atti di incanto per la vendita di legname del bosco demaniale Selvagrande
| |
|
Condizioni buone
| 1886 |
Serie XII - Bilanci di previsione
|
|
Esercizio finanziario 1944
| |
Pagg. 89
Condizioni buone
Note: abitanti n° 10867
| 1944 |
|
|
Esercizio finanziario 1944, con rubrica per argomenti
| |
|
Condizioni buone
| 1944 |
|
|
Esercizio finanziario 1946
| |
Pagg. 47
Condizioni buone
| 1946 |
Serie XIII - Libri mastri*
|
|
Libro mastro e registro impegni della spesa
| |
Pagg. 382 (scritte)
Condizioni buone
| 1931 |
|
|
Libro mastro e registro impegni della spesa
| |
Pagg. 183 (scritte)
Condizioni buone
| 1941 |
|
|
Idem
| |
Pagg. 147 (scritte)
Condizioni buone
| 1942 |
|
|
Libro mastro e registro della spesa
| |
Pagg. 345 (scritte)
Condizioni buone
| 1945 |
|
|
Libro mastro entrata e uscita
| |
|
Condizioni discrete
| 1946 |
Serie XIVa - Giornale di cassa*
|
|
| |
Pagg. 79 (scritte)
Condizioni buone
| 30-4-1940/22-8-1943 |
|
|
| |
Con mastro della contabilità e rubrica per materia
Condizioni buone
| 1943 |
Serie XIVb - Verifiche della Cassa Comunale
|
|
| |
|
Condizioni buone
| 1938-1939 |
Serie XV - Mandati di pagamento*
|
|
| |
|
Condizioni mediocri
| 1943
, 1945-1946 |
Serie XVI - Ruoli
|
|
Ruolo cautele - Ing. N. Del Prato
| |
Vol. 1
Condizioni mediocri
| 31-1-1942 |
|
|
Idem
| |
Vol. II
Condizioni mediocri
| Indicazioni relative al 1946 |
|
|
Aggiornamento ruoli censo e canoni
| |
Parte I, II, III
Condizioni discrete
| 31-1-1942 |
|
|
Ruolo tasse, canoni e livelli
| |
|
Condizioni discrete
| (1946) |
Serie XVII - Conti consuntivi
|
|
Esercizio finanziario 1944
| |
|
Condizioni buone
| 1944 |
|
|
Esercizio finanziario 1945
| |
|
Condizioni buone
| 1945 |
Leva e Truppa
Serie XVIII - Liste di Leva*
|
|
Classe 1888
| |
Iscritti n° 94 - Capilista classi 1886-1887 - N° 44
Condizioni buone
| 1906 |
|
|
Classe 1889
| |
Iscritti n° 115 - Capilista classi 1886, 1887, 1888 - N° 34
Condizioni buone
| 1907 |
|
|
Classe 1890
| |
Iscritti n° 110
Condizioni buone
| 1908 |
|
|
Classe 1890
| |
Iscritti n° 22 - Capilista classi 1887-1888-1889
Condizioni discrete
| 1908 |
|
|
Classe 1891
| |
Iscritti 105 - Capilista classi 1888-1889-1890 - N° 22
Condizioni buone
| 1909 |
|
|
Classe 1892
| |
Iscritti n° 132 - Capilista classi 1889-1890-1891 - N° 25
Condizioni buone
| 1910 |
|
|
Classe 1911
| |
Iscritti n° 84
Condizioni discrete
| 1911 |
|
|
Classe 1893
| |
Nominativi per numero di estrazione - Capilista classi 1890-1891- 1892
Condizioni buone
| 1912 |
|
|
Classe 1895
| |
Nominativi per numero di estrazione
Condizioni buone
| 1913 |
|
|
Classe 1894
| |
|
Capilista classi 1891-1893 - Nominativi per numero di estrazione
| Annotazioni relative al 1914 |
|
|
Classe 1896
| |
Nominativi per numero di estrazione
Condizioni buone
| 1914 |
|
|
Classe 1895
| |
Capilista classi 1893, 1894, 1895 - Nominativi per numero di estrazione
Condizioni buone
| Annotazioni relative al 1915 |
|
|
Classe 1897
| |
Iscritti n° 120
Condizioni buone
| 1915 |
|
|
Classe 1898
| |
Iscritti n° 117
Condizioni buone
| 1916 |
|
|
Classe 1898
| |
Capilista classe 1898
Condizioni mediocri
| Annotazioni relative al 1917 |
|
|
Classe 1899
| |
Iscritti n° 103
Condizioni buone
| 1917 |
|
|
| |
Capilista n° 15
Condizioni mediocri
| Annotazioni relative al 1917 |
|
|
Classe 1900
| |
Iscritti n° 128
Condizioni buone
| 1917 |
|
|
Classe 1900
| |
Capilista classi 1897, 1898, 1899 - Iscritti n° 9
Condizioni mediocri
| Annotazioni relative al 1918 |
|
|
Classe 1901
| |
Iscritti n° 111
Condizioni buone
| 1918 |
|
|
Classe 1901
| |
Capilista classi 1898, 1899, 1900-1887 - Iscritti n° 26
Condizioni mediocri
| Annotazioni relative al 1920 |
|
|
Classe 1920
| |
Iscritti n° 137
Condizioni buone
| 1920 |
|
|
Classe 1902
| |
Iscritti n° 7
Condizioni mediocri
| Annotazioni relative al 1921 |
|
|
Classe 1921
| |
Iscritti n° 99 - Capilista classe 1903 n° 19
Condizioni buone
| 1921 |
|
|
Classe 1905
| |
Capilista classi 1904 n° 18
Condizioni discrete
| Annotazioni relative al 1921 |
|
|
Classe 1904
| |
Iscritti n° 120
Condizioni buone
| 1922 |
|
|
Classe 1904
| |
Capilista classi 1901, 1902, 1903 n° 16
Condizioni buone
| Annotazioni relative al 1923 |
|
|
Classe 1905
| |
|
Iscritti n° 114
| 1923 |
|
|
Classe 1906
| |
Iscritti n° 84
Condizioni buone
| 1924 |
|
|
Classe 1907
| |
Iscritti n° 105
Condizioni buone
| 1925 |
|
|
Classe 1906
| |
|
Iscritti n° 39
| Annotazioni relative al 1926 |
|
|
Classe 1906
| |
Capilista classi 1905, 1906 - Iscritti n° 31
Condizioni discrete
| Annotazioni relative al 1926 |
|
|
Classe 1908
| |
Iscritti n° 150 - Rivedibili classi 1905, 1906, 1907 - Iscritti n° 34
Condizioni buone
| 1926 |
|
|
Classe 1909
| |
Iscritti n° 125 - Capilista classi 1907, 1908 - n° 28
Condizioni buone
| 1927 |
|
|
Classe 1910
| |
Iscritti n° 144
Condizioni buone
| 1928 |
|
|
Classe 1911
| |
Iscritti n° 113 - Capilista classi 1909, 1910
Condizioni buone
| 1929 |
|
|
Classe 1930
| |
Iscritti n° 119
Condizioni buone
| 1930 |
|
|
Classe 1913
| |
Iscritti n° 133 - Capilista classi 1911, 1912 - n° 24
Condizioni buone
| 1931 |
|
|
Classe 1914
| |
Iscritti n° 135
Condizioni buone
| 1932 |
|
|
Classe 1915
| |
Iscritti n° 172
Condizioni buone
| 1933 |
|
|
Classe 1916
| |
Iscritti n° 120
Condizioni buone
| 1934 |
|
|
Classe 1917
| |
Iscritti n° 77
Condizioni buone
| 1935 |
|
|
Classe 1918
| |
Iscritti n° 99
Condizioni buone
| 1936 |
|
|
Classe 1919
| |
Iscritti n° 95
Condizioni buone
| 1937 |
|
|
Classe 1918
| |
Iscritti n° 4
Condizioni discrete
| 1938 |
|
|
Classe 1920
| |
Iscritti n° 171
Condizioni buone
| 1938 |
|
|
Classe 1921
| |
Iscritti n° 196
Condizioni buone
| 1938 |
|
|
Classe 1922
| |
Iscritti n° 177
Condizioni buone
| 1939 |
|
|
Classe 1923
| |
Iscritti n° 235
Condizioni buone
| 1940 |
|
|
Classe 1924
| |
Iscritti n° 182
Condizioni buone
| 1941 |
|
|
Classe 1925
| |
Iscritti n° 175
Condizioni buone
| 1942 |
|
|
Classe 1926
| |
Iscritti n° 170
Condizioni buone
| 1943 |
|
|
Classe 1927
| |
Iscritti n° 186
Condizioni buone
| 1944 |
|
|
Classe 1928
| |
Iscritti n° 172
Condizioni buone
| 1945 |
|
|
Classe 1929
| |
Iscritti n° 178
Condizioni buone
| 1946 |
Serie XIX - Leva di mare del Compartimento Marittimo di Gaeta*
|
|
Classe 1908
| |
Iscritti n° 423 + 16
Condizioni buone
| 1928 |
Serie XX - Liste dei renitenti*
|
|
Classe 1905
| |
Iscritti n° 28
Condizioni discrete
| 1924 |
|
|
Classe 1906
| |
Iscritti n° 42
Condizioni discrete
| 1925 |
|
|
Classe 1907
| |
Iscritti n° 39 + 1
Condizioni discrete
| 1926 |
|
|
Classe 1908
| |
Iscritti n° 37
Condizioni discrete
| 1927 |
|
|
Classe 1908
| |
Iscritti n° 41
Condizioni discrete
| 1928 |
|
|
Classe 1910
| |
Iscritti n° 33
Condizioni discrete
| 1929 |
|
|
Classi dal 1898 al 1910
| |
Iscritti n° 8
Condizioni discrete
| 1930-1931 |
|
|
Classe 1911
| |
Iscritti n° 20
Condizioni discrete
| 1932 |
|
|
Classe 1914
| |
Iscritti n° 10
Condizioni discrete
| 1934 |
|
|
Classe 1915
| |
Iscritti n° 6
Condizioni discrete
| 1935 |
|
|
Classe 1912
| |
Iscritti n° 16
Condizioni discrete
| 1936 |
|
|
Classe 1919
| |
Iscritti n° 3 + 4 + 1
Condizioni discrete
| 1939 |
|
|
Classe 1920
| |
Iscritti n° 9
Condizioni discrete
| 1939 |
|
|
Classe 1921
| |
Iscritti n° 6
Condizioni discrete
| 1940 |
|
|
Classe 1922
| |
Iscritti n° 8
Condizioni discrete
| 1941 |
|
|
Classe 1923
| |
Iscritti n° 7
Condizioni discrete
| 1942 |
|
|
Classe 1924
| |
Iscritti n° 17
Condizioni discrete
| 1943 |
|
|
Classe 1925
| |
Iscritti n° 7
Condizioni discrete
| 1945 |
|
|
Classe 1924
| |
Iscritti n° 3
Condizioni discrete
| 1946 |
Serie XXI - Liste di renitenti residenti all'estero*
|
|
Classe 1918
| |
Iscritti n° 4
Condizioni discrete
| 1939 |
|
|
Classe 1920
| |
Iscritti n° 9
Condizioni discrete
| 1941 |
|
|
Classe 1921
| |
Iscritti n° 2
Condizioni discrete
| 1942 |
|
|
Classe 1923-1924
| |
Iscritti n° 3 + 4
Condizioni discrete
| 1945 |
Serie XXII - Liste di leva riformati*
|
|
Classe 1910
| |
Iscritti n° 13
Condizioni discrete
| 1932 |
|
|
Classe 1911
| |
Iscritti n° 9
Condizioni discrete
| 1933 |
|
|
Classe 1914
| |
Iscritti n° 4
Condizioni discrete
| 1934 |
|
|
Classe 1912
| |
Iscritti n° 9
Condizioni discrete
| 1935 |
|
|
Classe 1913
| |
Iscritti n° 9
Condizioni discrete
| 1935 |
|
|
Classe 1915
| |
Iscritti n° 2
Condizioni discrete
| 1935 |
|
|
Classe 1916
| |
Iscritti n° 1
Condizioni discrete
| 1936 |
|
|
Classe 1920
| |
Iscritti n° 3
Condizioni discrete
| 1939-1942 |
|
|
Classe 1918
| |
Iscritti n° 1
Condizioni discrete
| 1942 |
Serie XXIII - Elenco dei rivedibili e rimandati*
|
|
Da iscrivere nella classe 1921
| |
Iscritti n° 27 + 20
Condizioni discrete
| 1939 |
|
|
Da iscrivere nella classe 1922
| |
Iscritti n° 43
Condizioni discrete
| 1940 |
Serie XXIV - Sussidi per i congiunti dei militari*
|
|
| |
Iscritti n° 14
Condizioni mediocri
| 1942 |
|
|
| |
Iscritti n° 1
Condizioni discrete
| 1943 |
|
|
| |
Iscritti n° 1537
Condizioni discrete
| 1943-1944 |
|
|
| |
Iscritti n° 886
Condizioni discrete
| 1945 |
|
|
| |
Iscritti n° 464
Condizioni discrete
| 1946 |
Serie XXV - Pensionati di guerra*
|
|
| |
|
Condizioni discrete
| Indicazioni cronologiche dal 1935 al 1946 (e sino al 1964) |
Lavori pubblici
Serie XXVI - Strade comunali
|
|
Elenco
| |
|
Condizioni mediocri
| 1866 |
|
|
Elenco
| |
Vol. I
Condizioni mediocri
| 1935-1936 |
|
|
Idem
| |
Vol. II
Condizioni buone
| 1935-1936 |
Serie XXVII - Consumatori di energia elettrica (Municipio)
|
|
Elenco
| |
|
Condizioni buone
| 26-12-1918 |
Serie XXVIII - Commissione edilizia comunale
|
|
Deliberazioni - Verbali n° 6
| |
|
Condizioni buone
| 25-8-1946/13-11-1946
e sino al 28-8-1953
|
Agricoltura, Industria, Commercio
Serie XXIX - Commissione Comunale per la disciplina del commercio
|
|
Deliberazioni
| |
Atti non numerati
Condizioni buone
| 21-9-1928/3-5-1937 |
|
|
Deliberazioni
| |
Atti non numerati
Condizioni buone
| 8-1-1937/28-5-1943 |
|
|
Deliberazioni
| |
Atti non numerati
Condizioni buone
| 13-2-1946/14-11-1946
(sino all'8-6-1955)
|
|
|
Deliberazioni
| |
Atti non numerati
Condizioni buone
| 9-9-1946/14-11-1946
(sino al 9-4-1976)
|
Stato civile*
Serie XXX - Atti di nascita
|
|
| |
Atti n° 158 + 4 - Indicazioni sul battesimo - Con tavola alfabetica
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1861 |
|
|
| |
Atti n° 192 + 9
Idem
| 1862 |
|
|
| |
Atti n° 195 + 5
Idem
| 1864 |
|
|
| |
Atti n° 192 + 7
Idem
| 1865 |
|
|
| |
Atti n° 232 - Con indice annuale
Condizioni buone
| 1866 |
|
|
| |
Atti n° 241 - Con indice annuale
Condizioni buone
| 1871 |
|
|
| |
Atti n° 266 + 7
Idem
| 1876 |
|
|
| |
Atti n° 268 + 2
Idem
| 1877 |
|
|
| |
Atti n° 260 + 2
Idem
| 1879 |
|
|
| |
Atti n° 256 + 1
Idem
| 1881 |
|
|
| |
Atti n° 265 + 1
Idem
| 1883 |
|
|
| |
Atti n° 305 + 7
Idem
| 1884 |
|
|
| |
Atti n° 294 + 1
Idem
| 1885 |
|
|
| |
Atti n° 300 + 1
Idem
| 1886 |
|
|
| |
Atti n° 265 + 4
Idem
| 1888 |
|
|
| |
Atti n° 305 + 3
Idem
| 1889 |
|
|
| |
Atti n° 302 + 2
Idem
| 1890 |
|
|
| |
Atti n° 266 + 5
Idem
| 1891 |
|
|
| |
Atti n° 324 + 6
Idem
| 1892 |
|
|
| |
Atti n° 277 + 4
Idem
| 1893 |
|
|
| |
Atti n° 304 + 3
Idem
| 1894 |
|
|
| |
Atti n° 292 + 3
Idem
| 1895 |
|
|
| |
Atti n° 309 + 4
Idem
| 1896 |
|
|
| |
Atti n° 261 + 7
Idem
| 1897 |
|
|
| |
Atti n° 311 + 5 - Indice annuale
Condizioni discrete
| 1898 |
|
|
| |
Atti n° 306 + 2 - Indice annuale
Condizioni buone
| 1899 |
|
|
| |
Atti n° 303 + 8
Idem
| 1900 |
|
|
| |
Atti n° 264 + 6
Idem
| 1901 |
|
|
| |
Atti n° 319 + 1
Idem
| 1902 |
|
|
| |
Atti n° 294 + 9
Idem
| 1905 |
|
|
| |
Atti n° 320 + 4
Idem
| 1906 |
|
|
| |
Atti n° 296 + 1
Idem
| 1907 |
|
|
| |
Atti n° 322 + 8
Idem
| 1908 |
|
|
| |
Atti n° 322 + 6
Idem
| 1909 |
|
|
| |
Atti n° 311 + 1 + 3
Idem
| 1910 |
|
|
| |
Atti n° 288 + 2 + 6
Idem
| 1911 |
|
|
| |
Atti n° 309 + 1 + 10
Idem
| 1912 |
|
|
| |
Atti n° 342 + 2 + 6
Idem
| 1913 |
|
|
| |
Atti n° 284 + 4 + 14 - Indice annuale
Condizioni discrete
| 1914 |
|
|
| |
Atti n° 284 - Indice annuale
Condizioni buone
| 1915 |
|
|
| |
Atti n° 254 + 2 + 16
Idem
| 1916 |
|
|
| |
Atti n° 180 + 1 + 1 - Indice annuale
Condizioni buone
| 1917 |
|
|
| |
Atti n° 193 + 1 + 4
Idem
| 1918 |
|
|
| |
Atti n° 237 + 1 + 26
Idem
| 1919 |
|
|
| |
Atti n° 360 + 1 + 2
Idem
| 1920 |
|
|
| |
Atti n° 390 + 1
Idem
| 1921 |
|
|
| |
Atti n° 349 + 4 + 1
Idem
| 1922 |
|
|
| |
Atti n° 372 + 19
Idem
| 1923 |
|
|
| |
Atti n° 335 + 2
Idem
| 1924 |
|
|
| |
Atti n° 327 + 1 + 2
Idem
| 1925 |
|
|
| |
Atti n° 308 + 2
Idem
| 1926 |
|
|
| |
Atti n° 313 + 6
Idem
| 1927 |
|
|
| |
Atti n° 392 + 4 + 9
Idem
| 1928 |
|
|
| |
Atti n° 325 + 14
Idem
| 1929 |
|
|
| |
Atti n° 318 + 7
Idem
| 1930 |
|
|
| |
Atti n° 311 + 3 + 7
Idem
| 1931 |
|
|
| |
Atti n° 378 + 3 + 13
Idem
| 1932 |
|
|
| |
Atti n° 313 + 2 + 6
Idem
| 1933 |
|
|
| |
Atti n° 301 + 4 + 38
Idem
| 1934 |
|
|
| |
Atti n° 287 + 4 + 8
Idem
| 1935 |
|
|
| |
Atti n° 335 + 4 + 2
Idem
| 1936 |
|
|
| |
Atti n° 316 + 5 + 3
Idem
| 1937 |
|
|
| |
Atti n° 329 + 9 + 4
Idem
| 1938 |
|
|
| |
Atti n° 347 + 6 + 5
Idem
| 1939 |
|
|
| |
Atti n° 316 + 5 + 3
Idem
| 1941 |
|
|
| |
Atti n° 320 + 9 + 4
Idem
| 1942 |
|
|
| |
Atti n° 299 + 9; 124
Idem
| 1943-1944
(sino al 15-6-1944)
|
|
|
| |
Atti n° 129 + 4 + 1
Idem
| 1944
sino al 15-6-1944)
|
|
|
| |
Atti n° 231 + 12
Idem
| 1945 |
|
|
| |
Atti n° 347 + 5 + 4
Idem
| 1946 |
Serie XXXI - Atti di nascita di esposti*
|
|
| |
Atti n° 1
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 9-9-1862 |
Serie XXII - Indici alfabetici di atti di nascita*
|
|
| |
|
Condizioni buone
| 1809-1900 |
|
|
| |
|
Idem
| 1931-1946
(e sino al 1960)
|
Serie XXXIII - Atti di matrimonio*
|
|
| |
Atti n° 23 - Con indicazione della "celebrazione cattolica" e tavola alfabetica
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1862-1863
Il registro dell'anno 1861 èschedato nel periodo pre-unitario perché compreso nel volume relativo al 1861
|
|
|
| |
Atti n° 23; 45 - Con indicazione della "celebrazione cattolica" e tavola alfabetica
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1864-1865 |
|
|
| |
Atti n° 40 - Con indice annuale
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1867 |
|
|
| |
Atti n° 6 - Supplemento
Idem
| 1869 |
|
|
| |
Atti n° 33 - Con indice anuale
Condizioni buone
| 1870 |
|
|
| |
Atti n° 7 - Supplemento
Idem
| 1872 |
|
|
| |
Atti n° 50 - Con indice annuale
Condizioni buone
| 1873 |
|
|
| |
Atti n° 52+ 6 - Con indice annuale
Condizioni buone
| 1889 |
|
|
| |
Atti n° 52 + 13 + 4
Idem
| 1910 |
|
|
| |
Atti n° 52 + 12 + 5 - Con indice annuale
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1911 |
|
|
| |
Atti n° 64 + 8 + 3 - Con indice annuale
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1912 |
|
|
| |
Atti n° 48 + 14
Idem
| 1913 |
|
|
| |
Atti n° 73 + 14 + 6
Idem
| 1914 |
|
|
| |
Atti n° 39 + 15 + 3
Idem
| 1915 |
|
|
| |
Atti n° 27 + 13 + 3
Idem
| 1917 |
|
|
| |
Atti n° 29 + 1 + 3 - Con indice annuale
Condizioni buone
| 1918 |
|
|
| |
Atti n° 77 + 12 + 20 - Con indice annuale
Condizioni buone
| 1919 |
|
|
| |
Atti n° 140 + 13 + 7
Idem
| 1920 |
|
|
| |
Atti n° 110 + 9 + 8
Idem
| 1921 |
|
|
| |
Atti n° 86 + 15 + 4
Idem
| 1922 |
|
|
| |
Atti n° 88 + 11 + 10
Idem
| 1923 |
|
|
| |
Atti n° 63 + 5 + 3
Idem
| 1924 |
|
|
| |
Atti n° 63 + 2 + 8
Idem
| 1925 |
|
|
| |
Atti n° 39 + 38
Idem
| 1929 |
|
|
| |
Atti n° 81 + 7 + 3
Idem
| 1930 |
|
|
| |
Atti n° 51 + 11 + 6
Idem
| 1931 |
|
|
| |
Atti n° 63 + 11 + 4
Idem
| 1932 |
|
|
| |
Atti n° 1 + 85 + 8 + 3
Idem
| 1933 |
|
|
| |
Atti n° 72 + 11 + 9
Idem
| 1934 |
|
|
| |
Atti n° 79 + 12 + 3 - Con indice annuale
Condizioni buone
| 1935 |
|
|
| |
Atti n° 89 + 8 + 2
Idem
| 1936 |
|
|
| |
Atti n° 70 + 18 + 1 + 17
Idem
| 1937 |
|
|
| |
Atti n° 72 + 18 + 3 + 13
Idem
| 1938 |
|
|
| |
Atti n° 8 + 31 + 3
Idem
| 1939 |
|
|
| |
Atti n° 71 + 19 +1 +5
Idem
| 1940 |
|
|
| |
Atti n° 53 + 33
Idem
| 1941 |
|
|
| |
Atti n° 51 + 35
Idem
| 1942 |
|
|
| |
Atti n° 47 + 26 + 1; 59 + 16
Idem
| 1943-1944 |
|
|
| |
Atti n° 74 + 38
Idem
| 1945 |
|
|
| |
Atti n° 92 + 2 + 46
Idem
| 1946 |
Serie XXXIV - Indice alfabetico degli atti di matrimonio*
|
|
| |
Con appendice relativa al 1923
Condizioni buone
| 1908-1931 |
|
|
| |
|
Condizioni buone
| 1931-1936
(e sino al 1960)
|
Serie XXXV - Atti di morte*
|
|
| |
Atti n° 133
Condizioni buone
| 1889 |
|
|
| |
Atti n° 206 - Con indice annuale
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1893 |
|
|
| |
Atti n° 199 + 46
Idem
| 1894 |
|
|
| |
Atti n° 200 + 3
Idem
| 1895 |
|
|
| |
Atti n° 157 + 3 - Con indice annuale
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1897 |
|
|
| |
Atti n° 196 + 3
Idem
| 1898 |
|
|
| |
Atti n° 242 + 7
Idem
| 1899 |
|
|
| |
Atti n° 174 + 6
Idem
| 1900 |
|
|
| |
Atti n° 181 + 3
Idem
| 1901 |
|
|
| |
Atti n° 170 + 4
Idem
| 1902 |
|
|
| |
Atti n° 221 + 6
Idem
| 1903 |
|
|
| |
Atti n° 203 + 4
Idem
| 1904 |
|
|
| |
Atti n° 172 + 6
Idem
| 1905 |
|
|
| |
Atti n° 162 + 6
Idem
| 1906 |
|
|
| |
Atti n° 214 + 1
Idem
| 1907 |
|
|
| |
Atti n° 173 + 4
Idem
| 1908 |
|
|
| |
Atti n° 192 + 1 - Indice annuale
Condizioni buone
| 1909 |
|
|
| |
Atti n° 217 + 1
Idem
| 1910 |
|
|
| |
Atti n° 238 + 1 + 3
Idem
| 1911 |
|
|
| |
Atti n° 145 + 1 + 4 - Indice annuale
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1912 |
|
|
| |
Atti n° 178 - Con indice annuale
Condizioni buone
| 1913 |
|
|
| |
Atti n° 206 + 5 + 2
Idem
| 1914 |
|
|
| |
Atti n° 178 + 61 + 1
Idem
| 1915 |
|
|
| |
Atti n° 134 + 1 + 4
Idem
| 1916 |
|
|
| |
Atti n° 147 + 1 + 8 + 35 - Con indice annuale
Condizioni buone
| 1917 |
|
|
| |
Atti n° 39 + 1 + 23
Idem
| 1918 |
|
|
| |
Atti n° 147 + 4 + 20
Idem
| 1919 |
|
|
| |
Atti n° 137 + 1 + 6
Idem
| 1920 |
|
|
| |
Atti n° 185 + 8
Idem
| 1921 |
|
|
| |
Atti n° 200 + 1 + 1
Idem
| 1922 |
|
|
| |
Atti n° 176 + 10
Idem
| 1923 |
|
|
| |
Atti n° 177 + 1 + 2
Idem
| 1924 |
|
|
| |
Atti n° 152 + 1 - Con indice annuale
Dorso in pergamena - Condizioni buone
| 1925 |
|
|
| |
Atti n° 142 + 15
Idem
| 1926 |
|
|
| |
Atti n° 180 + 3 + 1
Idem
| 1927 |
|
|
| |
Atti n° 177 + 3 - Con indice annuale
Dorso in pergamena
| 1928 |
|
|
| |
Atti n° 138 + 3 + 8
Idem
| 1929 |
|
|
| |
Atti n° 141 + 2
Idem
| 1930 |
|
|
| |
Atti n° 143 + 12
Idem
| 1931 |
|
|
| |
Atti n° 152 + 7 + 6
Idem
| 1932 |
|
|
| |
Atti n° 127 + 4
Idem
| 1933 |
|
|
| |
Atti n° 105 + 1 + 20
Idem
| 1934 |
|
|
| |
Atti n° 116 + 19 + 9
Idem
| 1935 |
|
|
| |
Atti n° 117 + 8
Idem
| 1936 |
|
|
| |
Atti n° 154 + 2 + 7
Idem
| 1937 |
Serie XXXVI - Indici alfabetici degli atti di morte*
|
|
| |
|
Condizioni buone
| 1809-1930 |
|
|
| |
|
Condizioni buone
| 1931-1946
(e sino al 1960)
|
Serie XXXVII - Dichiarazioni di cittadinanza*
|
|
| |
Atti n° 1 - Con indice annuale
Condizioni buone
| 1866 |
|
|
| |
Verificato in bianco
Condizioni buone
| 1868 |
|
|
| |
Atti n° 1
Condizioni buone
| 1872 |
|
|
| |
Atti n° 3 - Con indice annuale
Condizioni buone
| 1873 |
|
|
| |
Verificato in bianco
Condizioni buone
| 1875 |
|
|
| |
Atti n° 1 - Con indice annuale
Condizioni buone
| 1876 |
|
|
| |
Verificato in bianco
Condizioni buone
| 1878 |
|
|
| |
Atti n° 1
Condizioni buone
| 1887 |
|
|
| |
Verificato in bianco
Condizioni buone
| 1888 |
|
|
| |
Atti n° 1
Condizioni buone
| 1890 |
|
|
| |
Verificato in bianco
Condizioni buone
| 1891 |
|
|
| |
Atti n° 1
Condizioni buone
| 1895 |
|
|
| |
Verificato in bianco
Condizioni buone
| 1896 |
|
|
| |
Atti n° 1
Condizioni buone
| 1905 |
|
|
| |
|
Verificato in bianco
| 1908 |
|
|
| |
|
Verificato in bianco
| 1924 |
|
|
| |
|
Verificato in bianco
| 1930 |
|
|
| |
|
Verificato in bianco
| 1945 |
Serie XXXVIII - Registro di popolazione
|
|
| |
|
Condizioni buone
| 31-12-1934/31-12-1935 |
Serie XXXIX - Dichiarazioni di trasferimento di residenza
|
|
| |
|
Iscritti n° 533 - Condizioni buone
| 1-1-1936/28-12-1936 |
Serie XL - Pratiche di emigrazione
|
|
| |
Iscritti 1944 n° 73; 1945 n° 113; 1946 n° 183 (1947 n° 81)
Condizioni buone
| 1944-1946
(sino al 1947)
|
Serie XLI - Rubrica alfabetica con data*
|
|
| |
Senza indicazione dell'oggetto
Condizioni buone
| 1943-1944 |
Serie A - Amministrazione*
|
|
(Cat. 1, cl. 5)
| |
| 23-3-1944/24-6-1944 |
|
|
Corrispondenza riguardante il Sindaco e il Commissario Prefettizio
| |
| 23-3-1944/24-6-1944 |
|
|
"Cat. 1, cl. 6". Segretario Comunale - Personale dipendente
(Cat. I, cl. 7)
| |
| 1920-1944 |
|
|
Cartelle personali di dipendenti del Comune
| |
| 1920-1944
(saltuari)
|
|
|
Retribuzione dipendenti (e prestiti)
| |
| 1930-1938 |
|
|
Corrispondenza riguardante il personale dipendente
| |
| 1943-1944 |
|
|
Segretario Comunale
| |
| 11-8-1944/4-10-1944 |
|
|
Assistenza dipendenti Enti locali
| |
| 1944 |
|
|
Vice Sindaco e Assessori
| |
| 1944 |
|
|
"Cat. 1" (cl. 8)
| |
| 27-6-1944 |
|
|
Locali per uffici (corrispondenza relativa)
| |
| 27-6-1944 |
|
|
Deliberazioni del Podestà (con documentazione accesoria)
| |
| 1937 |
|
|
(Cat. I.) "cl. 9". "Cause riguardanti l'Amministrazione Comunale"
| |
| 1928-1936 |
|
|
"Causa Angelo Viscogliosi"
| |
| 1928-1936 |
|
|
"Causa Giovanni Albini"
| |
| 1932-1934 |
|
|
"Causa Concetta Montefusco"
| |
| 1934 |
|
|
Andamento servizio amministrativo
| |
| 1934 |
Serie B - Opere pie e beneficenza*
|
|
Cat. II, cl. 1. "Ente Comunale di Assistenza"
| |
| 1945-1947 |
|
|
Domande cessazione sussidi
| |
| 1945 |
|
|
Assistenza Maria Missuri, suddito americano
| |
| 1945 |
|
|
Sussidi a reduci, partigiani e prigionieri
| |
| 1945-1946 |
|
|
Sussidi ordinari a profughi di guerra
| |
| 1945-1946 |
|
|
Assistenza varia a profughi
| |
| 1945-1946 |
|
|
Ente Comunale di Assistenza - Amministrazione
| |
| 1946 |
|
|
Assistenza a congiunti di connazionali all'estero
| |
| 1946 |
|
|
U.N.R.R.A.: Refezione scolastica
| |
| 1946-(1947) |
|
|
Richiesta per l'istituzione di mense collettive
| |
| [1946] |
|
|
Ristoranti popolari
| |
| [1946] |
|
|
"Cat. II, cl. 1". Enti di assistenza e beneficenza
| |
| 1945-1947 |
|
|
E.N.D.S.I. - Distribuzione indumenti
| |
| 1945-1946 |
|
|
Uff. Provinciale Assistenza post-bellica
| |
| 1946-(1947) |
|
|
Ente Comunale di Consumo
| |
| 1946-(1947) |
|
|
"Fabbisogno Civico Ospedale"
| |
| 1946-(1947) |
|
|
"Rappresentanti dei Comuni in seno al ricostituendo Consiglio di Amministrazione del Civico Ospedale"
| |
| [1946] |
|
|
"Cat. II, Cl. 2"
| |
| 1943-1944 |
|
|
"Spedalità": diarie e corrispondenza
| |
| 1943-1944 |
|
|
"Cat. II, cl. 3"
| |
| 1899
, 1946-1947 |
|
|
Brefotrofi, orfanotrofi, esposti, baliatici
| |
| 1899
, 1946-1947 |
|
|
"Cat. II, cl. 5"
| |
| 1945-1946 |
|
|
Lotteria Nazionale "Italia". Consultorio pediatrico e materno
| |
| 1945 |
|
|
Comitato di Patronato
| |
| 1945 |
Serie C - Sanità ed igiene*
|
|
Cat. IV, cl. 1
| |
| 1921-1941
(saltuari)
|
|
|
Personale sanitario
| |
| 1921-1922
, 1938-1941 |
|
|
Personale sanitario (veterinario)
| |
| 1921-1938
, 1941 |
|
|
Condotta medica di Carnello
| |
| 1931 |
|
|
Personale sanitario (levatrice)
| |
| 1938-1941 |
|
|
"Cat. IV, cl. 1
| |
| 1923-1941
(saltuari)
|
|
|
Consorzio sanitario di Carnello
| |
| 1923 |
|
|
Consorzio veterinario
| |
| 1930
, 1932-1941 |
|
|
Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari
| |
| 1938-1941 |
|
|
"Cat. IV, Cl. 1"
| |
| 1935-1941 |
|
|
Farmacia Notarmarco - Capone
| |
| 1935-1941 |
|
|
(Cat. IV, cl. 2)
| |
| 1910-1944
(saltuari)
|
|
|
Corrispondenza Consiglio Sanitario Provinciale
| |
| 1910-1921 |
|
|
Ambulatorio Isola Liri Sup.(Croce Rossa)
| |
| 1917-1926 |
|
|
Modificazioni al Capitolato Sanitario
| |
| 1921 |
|
|
Denunzie malattie infettive
| |
| 1922-1923 |
|
|
Servizio Sanitario
| |
| 1943-1944 |
|
|
"Cat. IV, cl. 6"
| |
| 1921-1938 |
|
|
Cimitero
| |
| 1921
, 1933
, 1934
, 1938 |
|
|
Planimetria generale del Cimitero (con atti allegati)
| |
| 1922-1927 |
|
|
Inchiesta sulle condizioni del Cimitero
| |
| 1936-1938 |
Serie D - Finanza*
|
|
"Cat. V, cl. 1"
| |
| 1870-1942 |
|
|
Inventario dei beni comunali
| |
| 1870
, 1933
(revisione)
|
|
|
Beni comunali
| |
| 1917-1919
, 1925
, 1927-1933
, 1935-1942 |
|
|
"Cat. V, cl. 1"
| |
| 1917-1937 |
|
|
Boschi comunali
| |
| 1917-1919
, 1932 |
|
|
"Cat. V, Cl. 1"
| |
| 1878-1946 |
|
|
Fitto fabbricati
| |
| 1878-1921 |
|
|
Imposte sui beni comunali
| |
| 1921 |
|
|
Baracche, case asismiche
| |
| 1921-1922 |
|
|
Acquisto e vendita di cavalli
| |
| 1921-1923 |
|
|
Vendita, cessioni,concessioni di proprietà comunali
| |
| 1921
, 1933-1934
, 1936-1938 |
|
|
Fabbricati, Piazza XX Settembre, Via Colle San Bartolomeo
| |
| 1925 |
|
|
Case popolari, strade, ponti
| |
| 1925-1933 |
|
|
Colonia Elioterapica
| |
| 1934 |
|
|
Situazione debitoria dei Comuni
| |
| 1938 |
|
|
Usi civici, canoni: corrispondenza e atti istruttori
| |
| 1945-1946 |
|
|
Fitti di locali occupati dai profughi
| |
| 1946 |
|
|
"Cat. V, Cl. 2". Fatture
| |
| 1915
, 1924-1946 |
|
|
Spese sostenute in occasione del terremoto
| |
| 1915 |
|
|
Fatture liquidate e da pagare
| |
| 1942 |
|
|
Fatture e note pagate
| |
| 1944 |
|
|
Fatture e conti deliberati e non pagati
| |
| 1945 |
|
|
Fatture e conti pagati
| |
| 1945 |
|
|
"Cat. V, Cl. 3". Bilanci: corrispondenza e documentazione relativa
(Cl. 2)
| |
| 1938-1946 |
|
|
"Cat. V, Cl. 3"
| |
| 1909-1944 |
|
|
Tassa di energia elettrica a carico del Comune
| |
| 1909-1910 |
|
|
Imposte di Consumo
| |
| 1943-1944 |
|
|
"Cat. V, Cl. 4 bis"
| |
| 1932-1946 |
|
|
"Tariffe"
| |
| 1932
, 1937-1938 |
|
|
Tassa occupazione suolo pubblico
| |
| 1932
, 1934-1935
, 1937-1939 |
|
|
Reclamo II.CC. su materiali da costruzione
| |
| 1933-1936
, 1938-1939 |
|
|
Appalto Imposte di Consumo
| |
| 1938-1940 |
|
|
Prospetto riscossioni
| |
| 1939-1940 |
|
|
Contravvenzione a carico di Francesco ed Elisabetta Gallone
| |
| 1940 |
|
|
Corrispondenza ed atti diversi
| |
| 1943
, 1946 |
|
|
"Cat. V, Cl. 5"
| |
| 1884-1940 |
|
|
Catasto: corrispondenza
| |
| 1884
, 1926-1927
, 1929-1939 |
|
|
Mutuo - catasto edilizio urbano: corrispondenza
| |
| 1939-1940 |
|
|
"Cat. V, Cl. 7"
| |
| 1919-1939 |
|
|
Mutui
| |
| 1919-1922
, 1938-1939 |
|
|
Trattative mutuo ipotecario Ing. I. Vianello
| |
| 1933-1934 |
|
|
Trattative per mutui ipotecari
| |
| 1933-1934 |
|
|
"Cat. V, Cl. 7"
| |
| 1943-1963 |
|
|
Delegazione mutui - Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale
| |
| 1943-(1963) |
|
|
"Cat. V, Cl. 7"
| |
| 1938-1939 |
|
|
Nuovo elenco passività per mutui con l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza
| |
| 1938-1939 |
|
|
Trattative mutuo con l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza
| |
| 1938 |
|
|
Mutuo di lire 1.950.000 con l'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale
| |
| 1939 |
|
|
"Cat. V, Cl. 8-9"
| |
| 1921-1940 |
|
|
Servizio di Esattoria e Tesoreria: corrispondenza
| |
| 1921-1926
, 1928-1940 |
|
|
"Cat. V, Cl. 9"
| |
| 1921-1940 |
|
|
Riappalto esattoria
| |
| 1921-1932 |
|
|
Domande di rimborso per quote inesigibili, con documenti relativi
| |
| 1940 |
Serie E - Governo*
|
|
Corrispondenza con Enti diversi
| |
| 1943-1944 |
Serie F - Leva e truppa*
|
|
(Cat. VIII, cl. 1)
| |
| 1895-1925 |
|
|
Corrispondenza ed atti diversi
| |
| 1895-1925 |
|
|
"Cat. VIII, Cl. 1"
| |
| 1930-1944 |
|
|
Corrispondenza ed atti diversi
| |
| 1930-1943 |
|
|
Nati in Isola del Liri (iscritti alle liste di leva)
| |
| 1944 |
|
|
Nati in altri comuni
| |
| 1944 |
|
|
Elenco preparatorio per la formazione delle liste di leva
| |
| 1944 |
|
|
"Cat. VIII, Cl. 1"
| |
| 1945-1946 |
|
|
Nati in Isola del Liri
| |
| 1945 |
|
|
Nati in altri comuni
| |
| 1945 |
|
|
Nati in Isola del Liri
| |
| 1946 |
|
|
Nati in altri Comuni
| |
| 1946 |
|
|
"Cat. VIII, Cl. 3"
| |
| 1946-1947 |
|
|
"Cat. VIII, Cl. 5". Affari dipendenti dalla guerra
| |
| 1945-1946 |
|
|
Salme Caduti in guerra
| |
| 1940-1946 |
|
|
Infortunati civili di guerra
| |
| 1941-1945 |
|
|
Corrispondenza relativa alle vicende belliche
| |
| 1943-1944 |
|
|
Elenco delle offese belliche
| |
| 1944 |
|
|
Rastrellamento materiale bellico
| |
| 1945 |
|
|
Distruzioni belliche
| |
| 1945 |
|
|
Prigionieri di guerra
| |
| 1946 |
|
|
Sussidi vittime politiche
| |
| 1946-(1947) |
|
|
"Cat. VIII, Cl. 5". Danni di guerra
| |
| 1945-1946
(1947)
|
|
|
Corrispondenza e circolari
| |
| 1945 |
|
|
Relazione statistica danni di guerra
| |
| 1946-(1947) |
|
|
"Cat. VIII, Cl. 6"
| |
| 1945-1946 |
|
|
Sussidi a reduci disoccupati
| |
| 1945-1946 |
Serie G - Istruzione pubblica*
|
|
"Cat. IX, Cl. 2"
| |
| 1921-1943 |
|
|
Scuola elementare - Corrispondenza ed atti diversi
| |
| 1921
, 1935-1940
, 1943 |
|
|
"Cat. IX, Cl. 2"
| |
| 1921-1940
saltuari
|
|
|
Costruzione edifici scolastici
| |
| 1921 |
|
|
Andamento scolastico
| |
| 1921 |
|
|
Corso popolare di insegnamento
| |
| 1921 |
|
|
Asilo infantile
| |
| 1921
, 1935-1940 |
|
|
Edificio soclastico urbano
| |
| 1921
, 1935-1940 |
|
|
Contratto per fitto di aule scolastiche
| |
| 1934 |
|
|
Lavori di riparazione locali adibiti a scuola comunale
| |
| 1937-1939 |
|
|
Edifici scolastici rurali
| |
| 1934 |
|
|
"Cat. IX", (Cl. 4)
| |
| 1936-1944 |
|
|
Scuola "industriale"
| |
| 1936 |
|
|
Scuola di avviamento professionale: nomina di un bidello provvisorio
| |
| 1936 |
|
|
Scuola di avviamento profesionale: arredamento scolastico
| |
| 1936-1937
, 1940-1941
, 1944 |
|
|
Fitto locali. Scuola di avviamento professionale
| |
| 1937-1939
, 1941
, 1944 |
|
|
Scuola di avviamento professionale: corso superiore
| |
| 1940-1941 |
|
|
"Protezione Monumenti nazionali"
| |
| 1944 |
Serie H - Lavori pubblici*
|
|
"Cat. X, Cl. 1". "Progetto strada rotabile da Isola alla Selva"
| |
| 1882-1940 |
|
|
Elenco dei documenti
| |
| 10-8-1882 |
|
|
Profilo longitudinale
| |
| 10-8-1882 |
|
|
Sezioni trasversali
| |
| 10-8-1882 |
|
|
Disegni delle opere d'arte
| |
| 10-8-1882 |
|
|
Computo metrico dei movimenti di terra
| |
| 10-8-1882 |
|
|
Distribuzione trasporto delle terre
| |
| 18-8-1882 |
|
|
Computo metrico delle opere d'arte e lavori diversi
| |
| 18-8-1882 |
|
|
Variante al primo tronco
| |
| 18-8-1882 |
|
|
Riattazione (strada Selva)
| |
| s.d. |
|
|
Spese sostenute in economia (strada Selva)
| |
| 1921 |
|
|
Progetto dei lavori di costruzione della strada di allacciamento dalla Frazione Selva alla provinciale Sora-Castelliri
| |
| 1925 |
|
|
Strada Frazione Selva
| |
| 1926-1930
, 1933-1937 |
|
|
Strada di riallacciamento alla Frazione Selva
| |
| 1940 |
|
|
"Cat. X, Cl. 1"
| |
| 1862-1914 |
|
|
Ampliamento via Roma
| |
| 1862 |
|
|
Contravvenzione suolo pubblico (fratelli Venditti)
| |
| 1868 |
|
|
Contravvenzioni riguardanti il bosco comunale
| |
| 1869 |
|
|
Contravvenzione riguardante la strada provinciale (a Viscogliosi)
| |
| 1870 |
|
|
Contravvenzione stradale a Lefebvre
| |
| 1872 |
|
|
Espropriazione per la strada Isola-Casamari
| |
| 1873-1879 |
|
|
Capitolato appalto lavori (geom. Domenico Franchi)
| |
| 1881 |
|
|
Progetti per la sistemazione di strade: via Palazzo, via della Mola, via Di Pede, Supportico Porrini; altre strade (senza data)
| |
| 1881 |
|
|
Largario del ponte di Napoli
| |
| 1889 |
|
|
Rettifica di un tratto di via Carnello
| |
| 1892 |
|
|
Progetto della via dalla Piazza S. Lorenzo al Ponte di Roma
| |
| 1896 |
|
|
Concessione di strada per condotta elettrica
| |
| 1896 |
|
|
Polizia stradale
| |
| 1900-1901 |
|
|
"Strada provinciale - Servitù"
| |
| 1905 |
|
|
Allargamento strada in Isola Superiore
| |
| 1914 |
|
|
"Cat. X, Cl. 1"
| |
| 1915-1917 |
|
|
Strada per Sora - Secondo tratto
| |
| 1916-1919 |
|
|
Strada di accesso allo Stabilimento Viscogliosi
| |
| 1917 |
|
|
"Demolizione fabbricati"
| |
| 1917 |
|
|
Larghezza dei cerchioni delle ruote dei veicoli
| |
| 1917 |
|
|
Assunzione di lavori per conto di privati
| |
| 1917 |
|
|
"Baracche e costruzione di pozzi neri"
| |
| 1917 |
|
|
Manutenzione di strade comunali danneggiate dal terremoto
| |
| 1917 |
|
|
(Cat. X, Cl. 1)
| |
| 1918-1919 |
|
|
"Classifica di strade provinciali"
| |
| 1918 |
|
|
Perizia dei lavori della strada provinciale per Sora
| |
| 1918 |
|
|
Disegno di una cancellata: proprietà Viscogliosi
| |
| 1918 |
|
|
Strada Isola-Casamari: interramento fossi
| |
| 1918 |
|
|
Concessione per la costruzione di un ponticello: strada Isola-Casamari
| |
| 1918 |
|
|
Proposta di abbattimento di albero secolare
| |
| 1918 |
|
|
Edilizia: costruzioni e demolizioni
| |
| 1918 |
|
|
"Polizia stradale: contravvenzioni ed ordinanze"
| |
| 1918 |
|
|
Concessione al signor V. Mancini di un attraversamento stradale
| |
| 1919 |
|
|
Concessione al signor Iannucci per un cavalcafossi
| |
| 1919 |
|
|
Strada: Sezione Isola Liri-Arpino
| |
| 1919 |
|
|
Strada provinciale Isola-Casamari
| |
| 1919 |
|
|
(Cat. X, Cl. 1)
| |
| 1931-1944 |
|
|
Corrispondenza varia
| |
| 1931-1933 |
|
|
"Appalto lavori nuovo Ponte Roma"
| |
| 1934-1937 |
|
|
Strada per la frazione Capitino
| |
| 1934-1941 |
|
|
Concessione di accesso carrabile
| |
| 1937 |
|
|
Attraversamento di suolo in Viale Garibaldi
| |
| 1937 |
|
|
Certificati di abitabilità
| |
| 1939-1943 |
|
|
Costruzioni case popolari
| |
| 1941 |
|
|
Esecuzione di lavori stradali e permessi di circolazione
| |
| 1943-1944 |
|
|
"Cat. X, Cl. 2"
| |
| 1874-1939 |
|
|
Costruzione della balaustra del "Ponte Napoli"
| |
| 1874 |
|
|
Ponte di Roma
| |
| 1888
, 1939 |
|
|
"Cat. X, Cl. 3". Linee elettriche
| |
| 1897-1929 |
|
|
"Concessione alle Cartiere Meridionali per una condotta elettrica"
| |
| 1897 |
|
|
Illuminazione elettrica - Impianti
| |
| 1909-1910 |
|
|
"Dichiarazioni di consumo di energia elettrica"
| |
| 1919 |
|
|
"Concessione temporanea della dinamo elettrica della Società Cartiere Meridionali"
| |
| 1919 |
|
|
"Danneggiamento Centrale Elettrica Comunale"
| |
| 1928-1929 |
|
|
"Cat. X, Cl. 3". Linee elettriche
| |
| 1932-1937 |
|
|
Forniture energia elettrica (A. Viscogliosi)
| |
| 1932-1936 |
|
|
Progetto di sistemazione dell'impianto elettrico comunale.Progetto "Trito"
| |
| 1933 |
|
|
Concessione per appoggio linee elettriche
| |
| 1934 |
|
|
"Impianti elettrici"
| |
| 1935-1937 |
|
|
Attraversamento Valle del Liri con linea elettrica
| |
| 1937 |
|
|
Attraversamento di servitù per costruzione di linea elettrica
| |
| 1937 |
|
|
Rescissione di contratto di appoggio condutture
| |
| 1937 |
|
|
Linea elettrica (A.Viscogliosi)
| |
| s.d. |
|
|
(Cat. X, Cl. 4)
| |
| 1866-1920 |
|
|
Fiume Liri: concessione di acqua (a N. Sorvillo)
| |
| 1866-1867
, 1871-1878 |
|
|
Fiume Liri: derivazione chiesta da P. Nicolamasi
| |
|
29-4-1895, cat. XXIV, fasc. 7; 1-9-1896, cat. XIII, fasc. 10
| 1867-1897 |
|
|
Vertenza Pastorini-Viscogliosi
| |
| 1868-1869 |
|
|
Derivazione Roessinger
| |
| 1869-1870
, 1874 |
|
|
Concessione di prese d'acqua chiesta da A. Vescovali
| |
| 1870 |
|
|
"Fiume Liri: derivazione chiesta da Piscicelli e Ruggeri"
| |
| 1872-1878 |
|
|
Innovazioni sul Liri fatte da L. Mazzetti
| |
|
12-12-1893, Cat. XII, fasc. 9
| 1873-1894 |
|
|
Progetto per opere di miglioramento e risistemazione di strade e fognature
| |
| 1874 |
|
|
"Reclamo Courrier contro F. Viscogliosi"
| |
| 1875-1876 |
|
|
Fiume Liri: legittimazione chiesta da E. Grevanic
| |
| 1875-1877 |
|
|
Diga naturale sul Liri
| |
| 1876 |
|
|
Fiume Liri: legittimazione chiesta da A. Ippolito
| |
| 1876-1877 |
|
|
Fiume Liri: concessione di acqua a Loreto Mazzetti
| |
| 1877-1878 |
|
|
Fiume Liri: Concessione a L.B. Viscogliosi ed altre derivazioni
| |
| 1877-1879 |
|
|
Misura finale di lavori di conduttura e lastricatura eseguiti in Isola del Liri
| |
| 1881-1882 |
|
|
Progetto di una nuova conduttura per la fontana in Isola del Liri
| |
| 1890 |
|
|
Appalto e lavori di conduttura di acqua pubblica per Isola Superiore dalla sorgente di Nazaret
| |
| 1892-1893 |
|
|
Derivazione Manna-Viscogliosi
| |
|
20/4/1895, Cat. XIII, fasc. 9; 11-4-1895, Cat. XIII, fasc. 9
| 1895 |
|
|
Conduttura di acqua potabile per l'abitato di Isola Liri Inferiore
| |
| 1920 |
|
|
"Cat. X, Cl. 4". Derivazioni d'acqua
| |
| 1902-1919 |
|
|
Corrispondenza e pratiche varie
| |
| 1902
, 1905-1906
, 1907
, 1909-1910 |
|
|
Corrispondenza e pratiche varie
| |
| 1910-1914
, 1916-1919 |
|
|
"Cat. X, Cl. 4"
| |
| 1919-1946 |
|
|
Utilizzazione dell'acqua delle Cascate
| |
| 1919-1931 |
|
|
Alluvione del 1925 - Straripamento del Fiume Fibreno
| |
| 1925-1936 |
|
|
Acquedotto Municipale danneggiato dal terremoto del 1915
| |
| 1927-1929 |
|
|
"Vertenza Procesi"
| |
| 1928-1932 |
|
|
Canale "Le Forme"
| |
| 1928-1933 |
|
|
"Cat. X, Cl. 4"
| |
| 1928-1935 |
|
|
Acquedotto di Carnello
| |
| 1928-1932 |
|
|
Derivazione richiesta dal Comune di Sora
| |
| 31-5-1930 |
|
|
Derivazione del fiume Giovenco
| |
| 1932-1935 |
|
|
Rinnovazione di concessione di acqua del Comune
| |
| 1933 |
|
|
Lavori di spostamento del lavatoio pubblico
| |
| 1933-1934 |
|
|
Acquedotto Consorziale S. Pietro
| |
| 1933-1934 |
|
|
(Cat. X, Cl. 4)
| |
| 1934-1941 |
|
|
"Progetto Acquedotto Fibreno"
| |
| 1934-1935 |
|
|
"Acque pubbliche - Fontane"
| |
| 1934-1937 |
|
|
"Catasto delle acque pubbliche"
| |
| 1935-1936 |
|
|
Concessione di acqua potabile a V. Macciocchi e F. Campoli
| |
| 1935-1937 |
|
|
Concessione di acqua potabile al Conte Arduino Mangone
| |
| 1936 |
|
|
Danni dello straripamento del Liri
| |
| 1937 |
|
|
Allungamento in contrada sambucito
| |
| 1937-1938 |
|
|
Istanza di G.B. Mancini per derivazione d'acqua
| |
| 1938 |
|
|
Fiume Liri: danni di opere di sponde adiacenti alla diga ex Courrier
| |
| 1938 |
|
|
Concessione di acqua potabile a Luisa Alessandrini
| |
| 1940 |
|
|
Concessione di acqua potabile al cav. M. Manerini
| |
| 1940 |
|
|
Modifiche concessione di acqua potabile a V. Macciocchi
| |
| 1940 |
|
|
Concessione di acqua potabile a A. Quaglia
| |
| 1941 |
|
|
"Cat. X, Cl. 5"
| |
| 1895-1896 |
|
|
Progetto di conduttura di ghisa per fornitura di acqua potabile derivante dalla sorgente di Nazaret
| |
| 1895-1896 |
|
|
(Cat. X, Cl. 6)
| |
| 1875-1941
(saltuari)
|
|
|
"Espropriazione a danno di V. Manca"
| |
| 1875-1879 |
|
|
"Espropriazione Nicolamasi"
| |
| 1878-1882 |
|
|
"Espropriazione Mazzetti-Marsella"
| |
| 1878-1882 |
|
|
Baracca Scuola e baracca della Massoneria; baracca Adriani
| |
| 1915-1918 |
|
|
Espropriazione per la sistemazione delle baracche
| |
| 1916-1917 |
|
|
Espropriazione per pubblica utilità
| |
| 1917
, 1932-1934
, 1936
, 1938-1941 |
|
|
"Espropriazione Viscogliosi"
| |
| 1918 |
|
|
"Espropriazione per la costruzione dell'edificio scolastico di San Domenico"
| |
| 1918 |
|
|
Espropriazione terreni per pubblic utilità
| |
| 1919-1924 |
|
|
Occupazione edificio scolastico (pr. A. Viscogliosi)
| |
| 1928-1932 |
|
|
Espropriazione in danno della ditta Ciccodicola
| |
| 1929 |
|
|
Espropriazione per costruzione del primo gruppo di case asismiche
| |
| 1929 |
|
|
Espropriazione di fondi
| |
| s.d. |
|
|
"Cat. X, Cl. 7"
| |
| 1909-1933 |
|
|
Servizi postali
| |
| 1909
, 1917 |
|
|
Supplementi postali telegrafici
| |
| 1910 |
|
|
Impianti telefonici
| |
| 1917
, 1933 |
|
|
Servizio telegrafico
| |
| 1918 |
|
|
(Cat. X, Cl. 8)
| |
| seconda meta sec. XIX |
|
|
"Progetto di un edificio di ospedale:
Parte I: relazione
Parte II: Computo metrico
Parte III: Stima
Parte IV: Analisi
Parte V: Disegni
| |
| seconda metà del sec. XIX |
|
|
"Servizio automobilistico Sora-Arpino"
| |
| 1940 |
|
|
(Cat. X) "Cl. 9"
| |
| 1906-1917 |
|
|
"Tramvia Frosinone - Piperno Sora"
Parte I: Relazione e progetto
Parte II: Planimetria (I° parte)
Parte III: Profilo
Parte IV: Fabbricati
Parte V: Armamento della linea
Parte VI: Armamento della trasmissione aerea
Parte VII: Materiale mobile
| |
| 1906 |
|
|
Rete tramviaria Roma-Frosinone e diramazioni
| |
| 1906 |
|
|
Piano parcellare per espropriazione (edificio scolastico in San Domenico)
| |
| 1917 |
|
|
(Cat. X, Cl. 10)
| |
| 1893-1923 |
|
|
Copertura a volta dell'ossario
| |
| 1893 |
|
|
Casette asismiche, baracche. Progetto per la riparazione del Palazzo Comunale
| |
| 1917-1923 |
Serie I - Agricoltura, Industria, Commercio*
|
|
"Cat. X, Cl. 1". "Agricoltura"
| |
| 1943-1947 |
|
|
Controllo trebbiatura
| |
| 1943-1944 |
|
|
Macinazione e trasporto cereali
| |
| 1943-1944 |
|
|
Proroga contratti agrari
| |
| 1944 |
|
|
Macellazione suini
| |
| 1945-1946 |
|
|
Commissione agricola comunale: accertamenti e prezzi di prodotti agricoli
| |
| 1945-1946
(1947)
|
|
|
Campagne olearie
| |
| 1945-1946
(1947)
|
|
|
Schede proprietari agricoli
| |
| 1945-1946
(1947)
|
|
|
"Cat. XI, Cl. 2". Industria
| |
| 1910-1947 |
|
|
Ditta Sarra: impianti elettrici
| |
| 1910 |
|
|
Corrispondenza
| |
| 1943-1944
, 1946-1947 |
|
|
Artigiani
| |
| 1944
, 1946
(1947)
|
|
|
"Cat. X, Cl. 3". Commercio
| |
| 1939-1947 |
|
|
Corrispondenza
| |
| 1939
, 1943-1944
, 1946
(1947)
|
|
|
Assegnazione e distribuzione prodotti
| |
| 1944-1947 |
|
|
"Cat. XI, Cl. 3". Commercio
| |
| 1942-1949 |
|
|
Licenze di commercio
| |
| 1942-1946
(e sino al 1949)
|
|
|
Divieto di vendita di generi contingenti
| |
| 1946 |
|
|
Ordinanze per l'igiene dei locali
| |
| 1946 |
|
|
Camera di Commercio
| |
| 1946-(1947) |
|
|
(Cat. XI, Cl. 7)
| |
| 1943-1944 |
|
|
Lavoro: corrispondenza ed atti diversi
| |
| 1943-1944 |
Serie L - Stato civile*
|
|
(Cat. XII, Cl. 1)
| |
| 1901-1945
(saltuari)
|
|
|
Certificati di morte, atti diversi, corrispondenza
| |
| 1901
, 1914
, 1917
, 1919-1930
, 1937 |
|
|
Certificati di nascita, atti diversi, corrispondenza
| |
| 1911
, 1915-1926
, 1928
, 1930-1933
, 1936-1937
, 1944-1945 |
|
|
Certificati di matrimonio, corrispondenza
| |
| 1915
, 1921-1926 |
|
|
Atti di legittimazione, adozioni
| |
| 1930
, 1945 |
|
|
Atti di stato civile: verifica
| |
| 1930 |
|
|
Cambiamenti di residenza
| |
| 1925 |
Serie M - Affari vari e diversi*
|
|
"Cat. XIV, classe unica"
| |
| 1943-1944 |
Serie N - Calamità, sicurezza pubblica*
|
|
"Cat. XV, Cl. 1". "Terremoto 1915"
| |
| 1915-1924 |
|
|
Deliberazioni, verbali della commissione per l'assegnazione, consegna pigioni, corrispondenza
| |
| 19-2-1915/9-12-1915 |
|
|
Consegna al Comune di terreni occupati e di ricovero
| |
| 1915-1916 |
|
|
Casette asismiche; domande di assegnazione, consegna pigioni, corrispondenza
| |
| 1915-1916
, 1920
, 1923-1924 |
|
|
Casette asismiche: certificati
| |
| 1916 |
|
|
"Cat. XV, Cl. 1". "Terremoto 1915"
| |
| 1923-1943
(saltuari)
|
|
|
Case economiche e popolari
| |
| 1923
, 1936-1941 |
|
|
Concessione gratuita al Comune delle case popolari
| |
| 1936 |
|
|
Sicurezza pubblica: armi e munizioni
| |
| 1943 |
|
|
"Cat. XV, Cl. 4". Esercizi pubblici: licenze e traffici ambulanti
| |
| 1927-1946
(saltuari)
|
|
|
Prestito del Littorio: vincolo depositi cauzionali
| |
| 1927-1928
, 1930-1931 |
|
|
Versamento cauzione commercianti
| |
| 1927-1929 |
|
|
Domande accolte dalla Commissione Comunale del Commercio
| |
| 1927
, 1929
, 1934-1940 |
|
|
Deliberazioni della Commissione Comunale del Commercio
| |
| 1929-1931 |
|
|
Domande del commercio da esaminare
| |
| 1931 |
|
|
Domande respinte dalla Commissione Comunale
| |
| 1931
, 1935-1940 |
|
|
Deposito cauzionale
| |
| 1931
, 1935-1939 |
|
|
Trasferimento esercizi
| |
| 1936-1939 |
|
|
Rinnovo licenze di pubblici esercizi
| |
| 1944-1946 |
|
|
Licenze esercizi pubblici e macellazione
| |
| 1944-1946 |
|
|
"Cat. XV, (Cl. 8)"
| |
| 1943-1944 |
|
|
Pubblica Sicurezza: corrispondenza ed atti diversi
| |
| 1943-1944 |
Fuori catalogo: Manifesti
Archivi aggregati
Archivio aggregato "A" - Ufficio di Conciliazione
Atti istruttori
|
|
| |
|
Atti non numerati - Condizioni buone
| 1895-1900 |
Udienze
|
|
| |
|
Fogli scritti n° 152 - Condizioni buone
| ottobre 1944-luglio 1948 |
|
|
| |
|
Condizioni buone
| 21-8-1945/1-7-1948 |
Sentenze
|
|
| |
|
Atti n° 152 - Condizioni buone
| 1889 |
|
|
| |
|
Atti n° 169 - Condizioni buone
| 1892 |
|
|
| |
|
Atti n° 214 (leggibili) - Condizioni discrete
| 1896 |
|
|
| |
|
Atti n° 173 - Condizioni discrete
| 1907 |
Archivio aggregato "B" - Ente Comunale di Assistenza
|
|
Deliberazioni
| |
|
Numerate per argomenti - Condizioni buone
| 6-6-1926/29-6-1940 |
|
|
Deliberazioni del Comitato
| |
|
Condizioni molto buone
| 14-10-1945/21-12-1946
(sino al 13-11-1948)
|
|
|
"Protocollo"
| |
|
Condizioni molto buone
| 14-7-1937/27-12-1946
(sino al 31-3-1950)
|
|
|
"Ordini di esigenza"
| |
|
Condizioni molto buone
| 16-4-1942/21-11-1946 |
|
|
"Verifiche Commissione dell'E.C.A. e del Comitato Comunale"
| |
|
Condizioni molto buone
| 10-7-1944/2-9-1946
(sino al 14-1-1947)
|
|
|
Elenco dei poveri
| |
|
Condizioni buone
| 1946 |
|
|
"Rubrica alfabetica dei beneficiari"
| |
|
Condizioni buone
| 1946
(sino al 1947)
|
|
|
"Ruolo indennità caro pane a favore dei poveri"
| |
|
Condizioni buone
| (1945?) |
|
|
"Ruolo caro pane disoccupati"
| |
|
Condizioni buone
| agosto 1946 |
|
|
"Ruolo sussidio straordinario ai poveri"
| |
|
Condizioni buone
| 24-7-1946 |
|
|
"Ruolo sussidio ai reduci (due fascicoli"
| |
|
Condizioni buone
| 1945 |
|
|
"Ruolo sussidio temporaneo ai reduci" (due fascicoli)
| |
|
Condizioni buone
| 1946 (gennaio-febbraio) |
|
|
"Lavori al campo sportivo - Ruolo sussidio ai disoccupati" (22 fascicoli)
| |
|
Condizioni buone
| 1945-1946 |
|
|
Idem (nove fascicoli)
| |
|
Condizioni buone
| 1946-(1947) |
|
|
Lavori al campo sportivo; elenchi e tabelle di paga degli operai
| |
|
Condizioni buone
| s.d. |
|
|
Sussidi a rimpatriati dall'estero
| |
| 1942-1944 |
|
|
Sussidi a famiglie di congiunti all'estero
| |
| 1943-1944 |
|
|
Rendiconti sussidi a profughi
| |
| 1945-1946 |
|
|
Sussidi ordinari a reduci
| |
| 1945-1946 |
|
|
Sussidi danaro e viveri a profughi
| |
| 1945-1946 |
|
|
Sussidi ordinari a reduci - Atti
| |
| 1945-1946 |
|
|
Assistenza sanitaria a profughi
| |
| 1945-1946 |
|
|
Reduci: disposizioni generali
| |
| 1946 |
|
|
Sussidio a profughi (rendiconto e ruoli di pagamento)
| |
| 1946 |
|
|
Distribuzione viveri a profughi
| |
| 1946 |
|
|
Sussidi straordinari e reduci e profughi
| |
| 1946 |
|
|
Contabilità (Prefettura, ecc.)
| |
| 1946 |
|
|
Contabilità (fatture e note pagate)
| |
| 1946 |
|
|
Assistenza alla Prefettura ed altri enti
| |
| 1946 |
|
|
Sussidi straordinari assistenza postbellica
| |
| 1946 |
|
|
Domande di sussidio straordinario respinte
| |
| s.d. |
|
|
Assistenza postbellica
| |
| 1946 |
|
|
Comitato e personale d'ufficio
| |
| 1946 |
|
|
Maternità ed infanzia
| |
| 1946 |
|
|
Caropane ai reduci
| |
| 1946-1947 |
|
|
Assistenza sanitaria ai reduci
| |
| 1946-1948 |
Archivio aggregato "C" - Lascito B. Viscogliosi
|
|
Comitato per l'erigendo Ospedale
| |
| 1918-1926 |
Archivio aggregato "D" - Cartiera E. Boimond
|
|
Libro paga settimanale
| |
|
Fogli n. 119 - Condizioni buone
| 24-12-1937/7-4-1938 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 117 - Condizioni buone
| 1-4-1938/14-7-1938 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 119 - Condizioni buone
| 8-7-1938/27-10-1938 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 115 (scritti) - Condizioni buone
| 27-10-1938/28-1-1939 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 117 - Condizioni buone
| 2-7-1939/27-9-1941 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 115 - Condizioni buone
| 25-2-1940/8-6-1940 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 127 - Condizioni buone
| 15-9-1940/16-12-1940 |
|
|
Idem
| |
|
Condizioni discrete
| 10-11-1940/11-1-1941 |
|
|
Idem
| |
|
Condizioni buone
| 5-1-1941/2-3-1941 |
|
|
Idem
| |
| 24-8-1941/25-10-1941 |
|
|
Libro paga settimanale
| |
|
Fogli n° 193 - Condizioni buone
| 28-9-1941/22-8-1942 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 127 - Condizioni buone
| 26-10-1941/14-7-1938 |
|
|
Idem
| |
| 19-10-1941/15-8-1942 |
|
|
Idem
| |
| dicembre 1941-febbraio 1942 |
|
|
Idem
| |
| 16-12-1941/14-2-1942 |
|
|
Libro paga settimanale
| |
|
Fogli n° 127 - Condizioni buone
| 24-5-1942/26-7-1942 |
|
|
Libro paga settimanale
| |
|
Fogli n° 126 - Condizioni buone
| 16-8-1942/21-8-1943 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 127 - Condizioni buone
| 1-11-1942/26-12-1942 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 117 - Condizioni buone
| 28-3-1943/22-5-1943 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 116 - Condizioni buone
| 22-8-1943/10-11-1943 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 117 - Condizioni buone
| 24-10-1943/25-12-1943 |
|
|
Idem
| |
| 19-12-1943/19-2-1944 |
|
|
Libro paga settimanale
| |
|
Fogli n° 115 - Condizioni buone
| 2-4-1944/19-8-1944 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 116 - Condizioni buone
| 13-8-1944/17-3-1945 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 117 - Condizioni buone
| 4-3-1945/18-8-1945 |
|
|
Libro paga settimanale
| |
|
Fogli n° 98 - Condizioni buone
| 11-11-1945/21-6-1947 |
|
|
Libro paga settimanale
| |
|
Settimane n° 92 - Condizioni buone
| 23-12-1945/7-6-1947 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli 147 - Condizioni buone
| 2-5-1946/12-10-1946 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 93 - Condizioni buone
| 29-9-1946/4-1-1947 |
|
|
Libro giornale
| |
|
Pagine n° 496 - Condizioni buone
|
Verificato il 29 settembre 1942 dalla Pretura di Sora
|
|
|
Libro paga settimanale
| |
|
Fogli n° 108 - Condizioni buone
| 26-6-1947/28-2-1949 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 106 - Condizioni buone
| 25-4-1948/7-5-1949 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 109 - Condizioni buone
| 17-7-1949/25-8-1951 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 119 - Condizioni mediocri
| 29-1-1950/23-10-1950 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 120 - Condizioni buone
| 30-7-1950/19-12-1951 |
|
|
Libro manodopera - Edilizia (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 119 - Condizioni buone
| 31-12-1950/29-12-1951 |
|
|
II libro di manodopera (quattordicinale)
| |
|
Idem
| 30-12-1951/6-9-1952 |
|
|
Libro manodopera (quattordicinale)
| |
Idem
Libro paga di Sant'Elia Fiumerapido
| 27-1-1952/15-11-1952 |
|
|
Il libro manodopera (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 119 - Condizioni buone
| 24-8-1952/19-4-1953 |
|
|
l libro manodopera (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 120 - Condizioni buone
| 2-11-1952/2-4-1953 |
|
|
Libro manodopera (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 117 - Condizioni buone
| 2-11-1952/2-4-1953 |
|
|
II Libro manodopera (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 117 - Condizioni buone
| 19-3-1953/9-1-1954 |
|
|
Libro manodopera (quattordicinale)
| |
|
Idem
| 9-8-1953/15-5-1954 |
|
|
I Libro manodopera (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 122 - Condizioni buone
| 4-10-1953/3-4-1954 |
|
|
"Pistolengo Cartiera : manodopera" (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 116 - Condizioni buone
| 29-11-1953/5-2-1955 |
|
|
"Manodopera" (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 120 - Condizioni buone
| 27-12-1953/16-10-1954 |
|
|
I Libro manodopera (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 118 - Condizioni buone
| 3-4-1954/5-9-1954 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 121 - Condizioni buone
| 5-9-1954/5-3-1955 |
|
|
"Manodopera" (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 124 - Condizioni buone
| 3-9-1955/9-5-1956 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 119 - Condizioni buone
| 8-1-1956/7-7-1956 |
|
|
"Pistolengo" San Domenico: manodopera (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 121 - Condizioni buone
| 18-3-1956/28-9-1957 |
|
|
"I Libro manodopera" (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 121 - Condizioni buone
| 9-12-1956/25-5-1957 |
|
|
"Seguito cartiera: manodopera" (quattordicinale)
| |
|
Idem
| 17-3-1957/15-2-1958 |
|
|
"I Libro manodopera" (quattordicinale)
| |
|
Idem
| 12-5-1957/9-1-1958 |
|
|
Idem
| |
| 27-10-1957/12-4-1958 |
|
|
"Seguito cartiera: manodopera" (quattordicinale)
| |
|
Idem
| 2-2-1958/20-12-1958 |
|
|
I Libro manodopera (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 119 - Condizioni mediocri
| 28-9-1958/28-2-1959 |
|
|
"Libro manodopera" (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 121 - Condizioni mediocri
| febbraio 1959-luglio 1959 |
|
|
"I Libro manodopera" (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 114 - Condizioni buone
| 2-9-1959/19-12-1959 |
|
|
Idem
| |
|
Fogli n° 119 - Condizioni buone
| 20-12-1959/7-5-1960 |
|
|
"Manodopera" (quattordicinale)
| |
|
Fogli n° 119 - Condizioni buone
| s.d. |
|
|
"Elenco piante e documentazione relativa ad opere murarie delle cartiere"
| |
|
Condizioni buone
| 1959
(e retro)
|
|
|
Rubrica alfabetica
| |
|
Condizioni mediocri
| s.d. |
|